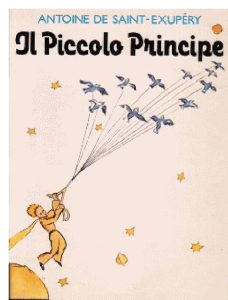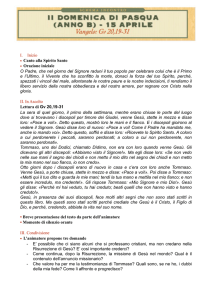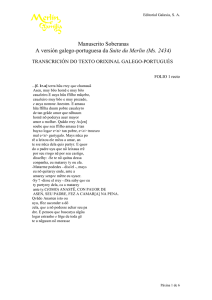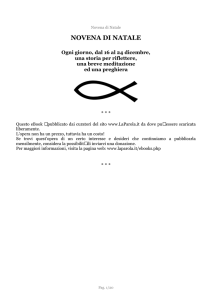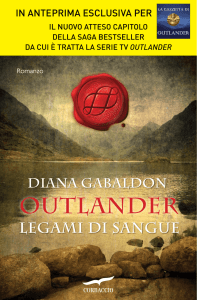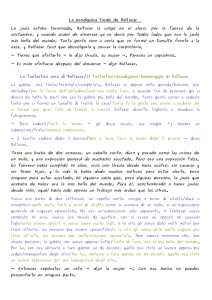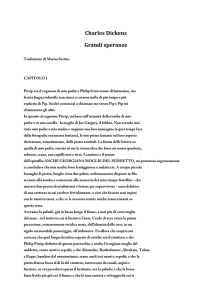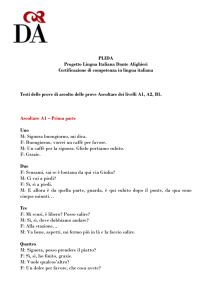Presentazione Per capire il talento di Giorgio Scerbanenco e la sua qualità di scrittore, non c’è nulla di meglio del Centodelitti, che torna finalmente nelle librerie italiane a quarant’anni dalla sua prima pubblicazione. Tra le qualità di Scerbanenco c’è, per cominciare, un’inesauribile fantasia narrativa: il «padre del noir all’italiana» era prima di tutto una straordinaria macchina per inventare storie – decine di storie, ogni giorno, ogni settimana, ogni anno... Storie che potevano prendere la forma di un romanzo, oppure restare condensate in poche pagine, o addirittura in poche righe. Una manciata di quelle trame avrebbe potuto fare la fortuna di qualunque scrittore, ma lui ne aveva in serbo talmente tante che non si curava di metterle da parte. Le pubblicava tutte, senza paura di disperdere o bruciare il proprio talento, su giornali e riviste, con straordinario successo. Poi c’è la qualità di quelle storie, che ci portano in un mondo complesso e brutale, violento e terribile, ma al tempo stesso pieno di sentimento e di sentimenti: il nostro mondo, dove il delitto non è un’eccezione. Ancora, c’è la capacità di catturare l’attenzione del lettore già dalla prima riga, e di portarlo fino al colpo di scena conclusivo, incatenato dalle svolte della trama e anche dalla verità dei dettagli: un’immagine, un oggetto, un gesto che danno realtà al racconto e lo rendono vivo. Infine, c’è l’accumulo di queste trame, in un interccio che si sovrappone al tessuto della realtà, e al tempo stesso offre la chiave per comprenderne il mistero crudele. Perché questo incredibile Centodelitti, con la sua raffica di microromanzi fulminanti, diventa quasi un’autentica «Enciclopedia del male», dove la sopraffazione e la violenza – con la loro fondamentale stupidità – sono la regola. Alla fine a prendere il sopravvento è il piacere della lettura: Scerbanenco gioca da vero maestro con la nostra curiosità e le nostre attese, e ci insegna a guardare il mondo e noi stessi con occhi diversi. Giorgio Scerbanenco (1911-1969), nato a Kiev, a 16 anni si stabilisce a Milano; per guadagnarsi da vivere fa molti mestieri finché non approda al mondo dell’editoria. Dopo aver scritto migliaia di racconti «rosa», si dedica al «poliziesco», e nel 1968 vince l’ambitissimo Grand Prix de littérature policière. Fra i titoli di maggiore successo Venere privata, Al servizio di chi mi vuole, La ragazza dell’addio, Traditori di tutti, Milano calibro 9, Dove il sole non sorge mai, I milanesi ammazzano al sabato, Ladro contro assassino , I ragazzi del massacro, Le principesse di Acapulco, Europa molto amore , Al mare con la ragazza, Le spie non devono amare, La sabbia non ricorda, Non rimanere soli, Racconti neri, Il Centodelitti e I sette peccati capitali e le sette virtù capitali, tutti pubblicati con Garzanti. Nel 2007, sempre per Garzanti, sono apparse le trame inedite degli altri romanzi di Duca Lamberti raccolte in Il ritorno del Duca, a cura di Gian Franco Orsi. Introduzione Il Centodelitti esplode da Garzanti in quelle indimenticabili edizioni con la copertina gialla e viola. Era il 1970. Più giallo di così... Poi rispara nella collezione periodica Gialli Garzanti, con gli occhi blu dalla prima edizione, dal 1974 in poi. E dopo? Sono finite le cartucce? No, anche i libri vengono rapiti e, dopo lungo e laborioso riscatto adesso Il Centodelitti è libero. Eccolo, è tornato a furor di popolo, a grande richiesta degli appassionati di Scerbanenco vecchi e nuovi. Quante e-mail, quante lettere, quante telefonate, quante radio ci avevano richiesto ansiosamente notizie di questo libro ormai mitico. Ragazzi in tesi di laurea su Scerbanenco cadevano in crisi depressive perché non riuscivano a trovarlo. «Forse Il Centodelitti è il miglior libro di Scerbanenco»: così veniva presentato nella prima edizione, quarant’anni fa. Se un libro del genere scompare, dovrebbero muoversi la polizia di Stato, la CIA, l’FBI e anche il KGB, se ci fosse ancora. Sì, è stato rapito perché era troppo bello. Ma lo abbiamo ritrovato. Ci sono quei racconti brevi, leggeri come un soffio ma così tragici da farci soffocare. Storie fulminanti ma complesse come romanzi, dove l’abiezione, la violenza, la tragicità, la povertà, la morte, la paura sono quelli di oggi. E sono passati quarant’anni. Mi piace ricordare come Giorgio scriveva quei brevissimi racconti. Erano nati nel 1963 come Il Quattronovelle per una rivista. I quattro racconti dovevano stare tutti in una pagina e avevano un tema diverso ogni settimana: la guerra, gli innamorati, le grandi città di notte, avere sedici anni, vittoria!, i piccoli paesi, i sogni, le infermiere, a che servono i soldi?, la moglie in vacanza... Li scriveva in un’oretta dopo cena. È andato avanti così per oltre due anni. I colleghi gli dicevano: «Ma perché sprechi delle idee così belle per dei racconti così brevi?». Lui rispondeva: «Faccio fatica a scrivere solo quattro racconti su un tema, perché me ne vengono in mente dieci, venti, trenta, e devo eliminarli». Era questo Giorgio Scerbanenco, lo scrittore che amiamo ancora oggi. Così vicino a noi per la sua passione di scrivere tutto sé stesso, ogni volta, in ogni personaggio: tutti diversi eppure tutti così umani, dal più abietto al più tenero, dal più meschino al più generoso. Comunque una parte viva di lui. E se i delitti ci sono, non sempre sono armi, pistole, mitra, bombe, coltellate in gola... Sono anche parole, silenzi, situazioni così forti e tragiche da morire, come delitti, centodelitti... Nunzia Monanni 1 · L’agonizzatoio «L’autista per il commendatore», disse l’infermiera al citofono. «Subito signorina», disse il custode. Prese il ricevitore dal telefono e fece il numero dell’autorimessa. «Giacomo?» «Cosa vuoi?» disse Giacomo. «La macchina per il commendatore.» «Subito», disse Giacomo. Sputò il mozzicone di sigaretta che stava, più che fumando, masticando, si mise la giacca, il berretto con la visiera marrone, si calzò meglio lo stivale marrone sinistro che era quello che non gli andava mai bene e salì sulla Mercedes color bronzo scuro. Quando uno ha fatto l’autista per quasi mezzo secolo, un’auto è una cosa viva, come un cavallo. Uscì con elegante e dolce manovra dall’autorimessa nel sole furioso di quella fine luglio romana, appena mitigata dai grandi alberi alti disseminati nel vasto parco attorno alla villetta, e andò a fermarsi davanti all’ingresso. Scese dalla Mercedes, inappuntabile nella sua divisa marrone scuro, con gli stivali marrone più chiari, come la visiera del berretto, ed era questo ciò che il commendatore intendeva per un autista o, come si diceva ai suoi tempi, uno chauffeur. Dalla finestra il commendatore lo vide. Gli piacque: in un mondo di cafoni, era riuscito a conservare un poco di stile, una bella auto bronzo scuro e uno chauffeur in una perfetta livrea, in piedi vicino alla macchina, quasi sull’attenti. L’infermiera Ulrica Lodo, alle sue spalle, disse: «L’auto è pronta». Lui si volse. «Grazie», e gli piacque anche lei, in quella divisa blu scura, quasi come una suora, monacale, col lungo velo blu scuro: la gente inferiore deve avere un abito, una livrea, non si può lasciarla vestire come vuole perché non ha gusto e si vestirebbe chi sa come, forse da pagliaccio. E detto grazie, aggiunse: «Per favore, il bastone». L’infermiera, Ulrica Lodo, lo aveva già staccato dall’attaccapanni e glielo porse. «Eccolo, commendatore.» Lui lo prese e vi si appoggiò. Era un meraviglioso Burester & Son color mogano, soltanto in Inghilterra ne avrebbero potuto apprezzare la finezza, nel cerchietto d’oro sulla punta del manico erano incise le sue iniziali, R. R., Rodrigo Regante, e sotto, in carattere piccolissimo: Burester & Son-London. Non era il suo unico bastone, è ovvio, ne aveva altri due, una canna d’India chiara, da mattino, e un Wander dal pomello d’avorio, da sera. Ma il Burester era quello adatto a ogni occasione, e di gran classe. «Per favore, i guanti», disse. Per una passeggiata nel pomeriggio sono di rigore i guanti grigio chiaro di vitello scamosciato, a meno che non piova, e in questo caso bisogna mettere quelli di cinghiale scuro. L’infermiera, col suo viso magrolino, il naso a lama di coltello, sorrise agra. Aveva già in mano i guanti. «Eccoli, commendatore.» Avere a che fare con un vecchio di ottantanove anni era un poco dura, quel brutto vecchio cretino con tutte le sue manie, ma lo stipendio era alto, molto alto, e bisognava abbozzare, perché era una romanaccia, sotto quell’aria così inglese, e diceva «abbozzà», per dire sopportare. Il commendatore Rodrigo Regante si infilò i guanti, lentamente, tanto la servitù può aspettare, anzi, deve, poi, così alto, così magro, reso ancora più alto e più magro dal cappello Davidson dalle larghe tese che creava profonde ombre sul suo viso ossuto, si appoggiò al suo Burester e uscì dalla stanza. Seguito dall’infermiera percorse tutto il bel corridoio luminoso di sole vicino al tramonto, ed esitò solo un momento davanti alla scalea fatta a serpe, coperta da un morbido tappeto giallo senape. «Prego», disse l’infermiera, tenendogli il braccio, per accompagnarlo lungo la discesa. «Prego», disse lui liberandosi da quell’aiuto, infastidito. E comincio a scendere da solo, senza neppure tenersi alla ringhiera, lentamente, da vegliardo, eppure con una certa energia e virilità. Attraversò l’anticamera, il domestico Luigi gli aprì la porta, restando poi sull’attenti, esattamente come un soldato, perché lui veniva definito commendatore, per quanto quel titolo gli importasse assai poco, ma era in realtà un colonnello, un glorioso colonnello, come testimoniavano le numerose medaglie avute nella prima guerra mondiale, e nella seconda avrebbe dovuto essere promosso generale, se i fascisti non fossero stati così stupidi da tenerlo in disparte. Al vederlo uscire, l’autista Giacomo si tolse un attimo il berretto, se lo rimise, aprì la portiera della Mercedes. Prima di salire in auto lui sollevò un poco il bastone. «Lungomare», disse. Salì e sedette col bastone tra le gambe, l’infermiera Ulrica salì dopo di lui, sedette vicino a lui, ma lasciando oltre dieci centimetri di spazio perché sapeva che il commendatore non amava stare troppo vicino a gente inferiore come lei, che gli venisse la peste a quel vecchio. La Mercedes si avviò verso il lungomare di Fregene; erano quasi quindici anni che il commendatore lo percorreva al mattino, in auto, da quando si era fatto fare la villa lì, e prima della guerra che quegli stupidi di fascisti avevano voluto fare senza di lui, e così era finita come era finita, veniva ogni tanto da Roma lì a Fregene, guidando lui personalmente la sua Lancia con l’aquila sul tappo del radiatore. Ed era venuto lì in lontanissimi anni in cui Fregene non esisteva ancora e sulla mappa era segnata così: Località pineta detta Fregene, e non c’era neppure una casa, solo qualche cacciatore ogni tanto, e le onde battevano sulla sabbia, davanti a nessuno, perché nessuno era a vederle, e anche a quell’epoca lui veniva lì, ed era tanto giovane, allora. «Giacomo, ferma dopo il distributore di benzina», disse all’autista. «Sì, commendatore», disse l’autista Giacomo, maledicendolo per la noia che gli faceva venire, perché dopo una quindicina di anni che lo portava lì e si fermava sempre una trentina di metri dopo il distributore di benzina, ogni mattina sempre lì, allo stesso posto eppure ogni mattina glielo ripeteva, maledetto. Poi, ubbidiente, fermò esattamente trenta metri dopo il distributore di benzina, sempre nel solito posto, l’asfalto era stato annerito dalle macchie d’olio della Mercedes, e delle precedenti auto che da quindici anni e più sostavano lì, sempre allo stesso punto. Il commendatore discese dalla Mercedes e guardò il tratto di spiaggia. Certo, tutto era molto differente da quel giorno così lontano, quasi di un’altra era geologica, in cui, a colpi di accetta, aveva fatto a pezzi la spia austriaca Beneditta. Adesso c’era solo sabbia e ombrelloni e donne quasi nude, oltre a quello scempio di distributore di benzina, ma allora, nel 1901, la pineta arrivava quasi fino al mare, folta, intensa, tanto che l’urlo spaventoso di lei, di Beneditta, appena lo aveva visto afferrare l’accetta, si era perso nel nulla. Ma, nonostante il grande cambiamento, il commendatore riconosceva benissimo il punto esatto in cui aveva vibrato i suoi interminabili colpi di accetta. Ecco, era stato tra quell’ombrellone a strisce verdi e quello a strisce arancione, sotto cui erano seduti uomini e donne neri come negri. Lì aveva atterrato Beneditta urlante col primo fendente di accetta, poi aveva continuato accecato dalla furia, poi si era reso conto che più colpiva più il cadavere diveniva irriconoscibile e non avrebbero mai potuto sapere chi era l’assassino. Così colpì, colpì, finché davvero neppure lui avrebbe potuto riconoscere Beneditta, spia al servizio degli Asburgo, travestita da studentessa di lingue classiche, latino e greco. Era stato proprio lì, tra l’ombrellone a strisce verdi e quello a strisce arancione, dove era la capanna del boscaiuolo; riconosceva benissimo il posto, anche se era molto cambiato, e ogni mattina veniva a rivedere la scena. «Adesso andiamo alla tenenza dei carabinieri», disse all’autista Giacomo che era vicino alla Mercedes. Aveva visto abbastanza, in un certo senso aveva anche sentito l’urlo di Beneditta, il grande e unico urlo, dopo il quale c’era stato il silenzio, accarezzato dallo sciacquio delle onde sulla spiaggia, e che risentiva ogni mattina che veniva lì, e veniva lì, ecco, appunto per risentirlo. «Prego?» disse l’autista Giacomo. L’ordine era talmente insolito che doveva certamente aver udito male. Non vedeva poi che relazione potesse esserci fra il commendatore e la tenenza dei carabinieri. Probabilmente il commendatore cominciava a parlare a caso, come tutti i rimbambiti. «Desidero che tu mi conduca alla tenenza dei carabinieri», disse forbitamente il commendatore, perché con le persone inferiori bisogna usare un linguaggio terso, chiarissimo, in modo che le loro piccole menti possano almeno un poco comprendere. A questo punto intervenne l’infermiera Ulrica Lodo, perché era lei dopo tutto che aveva la responsabilità del vecchio cretino e non voleva correre rischi. «Alla tenenza dei carabinieri?» disse, molto educata, ma con un clandestino tono di rimprovero. Ma lui sapeva quello che faceva: non era né rimbambito né cretino come pensavano quegli esseri inferiori che lui pagava tanto lautamente, e quindi ripeté, questa volta gelido: «Sì, signorina: alla tenenza dei carabinieri». «Bene, commendatore», disse l’autista Giacomo. Lui salì, solennemente in un certo senso, perché era una decisione che stava meditando da anni. I primi tempi aveva pensato, era oltre i settant’anni, che ormai sarebbe morto e che era inutile, poi, passando ancora anni e anni e anni, aveva deciso che bisognava chiudere la propria vita nobilmente. Adesso, a ottantanove anni, sapeva con chiarezza che cosa doveva fare, e un vecchio straccetto di infermiera e un vecchio imbecille d’autista non avrebbero certo potuto contrastarlo. In auto l’infermiera, ricordando gli ordini del medico, evitare al vecchio ogni emozione, tentò ancora. «Mi scusi, commendatore, posso andare io alla tenenza dei carabinieri, se occorre per qualche pratica.» Lui rise e tossì. «Per la pratica che mi occorre posso andare solo io», e sorrise ma con un che di sprezzo, oltre che di ironia. «Sì, commendatore», disse l’infermiera Ulrica Lodo. Eventualmente avrebbe fatto sempre in tempo a chiamare il medico, e poi, certamente, avrebbe avvertito il maresciallo dei carabinieri di non dare troppo retta a uno che aveva quasi novant’anni. L’autista Giacomo guidò ministerialmente verso il comando dei carabinieri, entrò e uscì dal folto della pineta, finché non si fermò davanti alla villetta che aveva sul fronte del Portocino quella piccola insegna, una specie di piccolo scudo con scritto Repubblica italiana, comando carabinieri MaccareseFregene. Lui scese, davanti all’autista Giacomo che gli apriva la portiera, scese fieramente, appoggiandosi appena al suo Burester & Son, un milite era proprio sulla soglia e stava accendendosi una sigaretta, ma buttò subito il fiammifero in terra a vedere quell’alto vecchio rinsecchito che veniva verso di lui col cappello con così larghe tese e con quel bastone scuro che l’uomo sembrava tenere quasi come una sciabola. «Desidero parlare col maresciallo dei carabinieri», disse lui fermamente. «Sono venuto a costituirmi.» «È venuto a costituirsi?...» ripeté il maresciallo dei carabinieri della tenenza MaccareseFregene. Aveva fatto accomodare il vecchio sulla poltroncina che usava sua moglie quando era incinta, perché ci stava comoda, e dietro la poltroncina c’erano l’infermiera Ulrica Lodo e l’autista Giacomo, che egli aveva voluto rimanessero lì, come testimoni. «Sì, costituirmi», disse nettamente lui. L’infermiera, alle sue spalle, scosse il capo, fissando il maresciallo, per fargli capire che non doveva dare nessuna importanza alle parole di uno tanto vecchio. «Perché?» disse il maresciallo, dopo aver raccolto lo sguardo. «Ho ucciso una donna, una ragazza di poco più di venti anni, a colpi di accetta», disse lui nettamente, sempre più nettamente. «Accetta?» disse il maresciallo. Fissava il vecchio, con educazione e con attenzione professionale, perché non c’è nulla di impossibile in questo mondo, lo sapeva meglio di ogni altro. «Sì, accetta», rispose il vecchio nettamente, perché la gente pensa che quando uno è vecchio non sa parlare con chiarezza e lucidità, e allora lui dimostrava invece che parlava meglio di uno di vent’anni. «L’avevo presa nel capanno del boscaiolo dove andavamo a nasconderci.» «A nasconderci chi?» disse il maresciallo. Faceva il suo lavoro e lo faceva bene, con chiunque avesse a che fare, minorenni o vecchi rimbambiti. «Io e quella ragazza», lui disse fiero. «Come si chiama la ragazza?» Si accorse troppo tardi che il presente non andava bene, trattandosi di una ragazza uccisa, morta. «Beneditta Volken, era una spia.» «Spia?» Per carità, che non venissero fuori complicazioni politiche di spionaggio, pensò il maresciallo, a lui bastavano i ladri e gli assassini normali, senza mettersi in mezzo alle spie. «Sì, io ero addetto all’ambasciata americana a Roma», spiegò il vecchio, «mia madre era americana e mi aveva ottenuto quel posto di interprete, io parlo l’inglese molto bene.» «Sì», disse il maresciallo. L’ufficio era piccolo, era davvero una giornata terribilmente calda di fine luglio e la stanza era davvero troppo piena, con l’infermiera e l’autista, e il milite che scriveva tutto quello che loro dicevano. «Lei come ha fatto a sapere che era una spia?» «Perché quel giorno, per la fretta, ero uscito dall’ufficio con la borsa dei documenti che avrei dovuto portare a casa per tradurli.» «E allora?» «Allora ho preso il calesse e siamo andati a Fregene.» «Che cosa ha preso?» «Il calesse», lui disse quieto, le mani appoggiate sul Burester & Son. «Il calesse col cavallo?» chiese il maresciallo. Cercava di stare tranquillo, perché, per capire bene le cose, anche se stranissime come quella che quel vecchio stava raccontando, bisognava essere tranquilli. «Sì, era un sauro di razza, mettevo poco più di tre ore ad arrivare a Fregene, ma ci fermavamo per la strada a far colazione.» «E allora lei ha saputo che era una spia», disse il maresciallo. Guardava l’infermiera che scuoteva ogni tanto il capo e che continuava a fargli capire di non dare nessuna importanza a quello che diceva il vecchio. «Sì, quando siamo arrivati nella pineta di Fregene», disse lui, «e ci siamo nascosti nel capanno del boscaiolo, a lei è caduta la borsetta, e la borsetta si è aperta, e nella borsetta c’erano dei fogli che sono caduti in terra.» «Fogli?» disse il maresciallo. «Sì, fogli. Erano delle copie dei documenti che io avevo nella mia borsa e che lei mi aveva rubato.» «E che documenti erano?» domandò il maresciallo, voleva proprio andare in fondo a quella storia, per incomprensibile che fosse. «Il più importante», lui disse, preciso e altero, «era un breve codice per la corrispondenza fra il re d’Inghilterra e il presidente degli Stati Uniti.» «Ma è la regina d’Inghilterra», disse il maresciallo, un poco confuso. «Allora c’era il re.» A quel tempo, voleva dire, c’era il re. «Va bene», disse il maresciallo. «Lei ha scoperto che era una spia, e cosa ha fatto?» Lui spiegò: «L’ho interrogata. L’ho fatta confessare. Così ho saputo che era da mesi che approfittava di me, per rubarmi documenti, per avere informazioni e per passarle agli Absburgo». «Agli...?» «Agli Absburgo.» «Ah, sì, capisco», disse il maresciallo, «e poi?» Ma non capiva molto. Cosa fossero gli Absburgo, aveva una vaga reminiscenza, aveva sentito quel nome un paio di volte a scuola, niente altro, doveva aver a che fare coi tedeschi o con gli austriaci, non poteva dirlo. «E poi, quando ho scoperto la verità, sono divenuto furioso», lui spiegò, sempre con maggiore precisione, «ero giovane, io le volevo bene davvero e scoprire che veniva con me solo perché era una spia, per rubarmi informazioni, mi ha accecato di rabbia.» «E cosa ha fatto?» disse il maresciallo quasi dolcemente, passandosi il fazzoletto nel collo della camicia fradicio di sudore. «Nel capanno c’era l’accetta del boscaiolo», egli quasi scandì, militarescamente, «e l’ho fatta a pezzi, non vedevo più dal furore, sa, avevo solo ventitré anni, e le volevo davvero bene, volevo sposarla.» «Sì», disse il maresciallo. Tossì un poco, educatamente, «e poi?» «E poi sono fuggito. Sono salito sul calesse...» Il maresciallo guardò il vecchio che raccontava che era salito sul calesse, sul giovane sauro, ed era tornato a Roma, e nessuno aveva saputo più niente di lui e di quella donna tagliata a pezzi così piccoli che non avevano mai potuto riconoscerla. «Sul Messaggero del maggio 1901 lei può leggere tutto quello che le ho detto io», disse lui. «Una giovane donna orrendamente tagliata a pezzi, questo è stato il primo titolo. Non sono mai riusciti a identificarla, e così non hanno mai potuto scoprire il colpevole, che sono io...» «Lei», disse il maresciallo, senza tono interrogativo, così, forse tanto per dire, poi scosse il capo anche lui, era davvero troppo insolito, troppo diverso dai comuni mascalzoni, papponi, aspiranti rapinatori che gli capitavano ogni giorno. «Lei ha ammazzato quella ragazza. E quando è stato? Ha detto nel 1901, oppure ho capito male?» «No, ha capito benissimo. L’ho uccisa nel 1901.» «Nel... 1901?» «Sì, maresciallo: nel 1901, allora avevo ventitré anni, ero molto giovane.» Il maresciallo fece cenno di sì, come per confermargli che si rendeva conto che nel 1901 lui doveva essere molto giovane. Nel 1901 il maresciallo non era ancora nato, non era nato neppure l’autista Giacomo e tanto meno l’infermiera Ulrica. E dopo aver accennato di sì, il maresciallo disse: «Lei vuol dire che nessuno, da allora, ha scoperto che lei era l’assassino, e che adesso viene a costituirsi?». «Voglio proprio dire questo. Non hanno potuto riconoscere il cadavere e quindi non mi hanno potuto trovare. E adesso sono venuto qui, a costituirmi a lei», e lui appoggiò fermamente le due mani sul Burester & Son. Ancora una volta il maresciallo fece cenno di sì, che capiva, benché non fosse sicuro di aver capito molto, tanto che domandò: «Nel 1901?». La data gli sembrava inverosimile. «Sì, maresciallo: il 20 maggio del 1901», disse il vecchio. Il maresciallo guardò il milite stenografo che scriveva tutto, e nella sua mente voltò e rivoltò quella data, 20 maggio 1901, senza ancora riuscire a crederci. «Lei vuol dire sessantasei anni fa?» chiese, quasi accademicamente. «Sì, signor maresciallo, sessantasei anni fa.» Allora il maresciallo abbassò lo sguardo sulla scrivania. Non aveva nessun motivo di mettere in dubbio il racconto di quel vecchio. Benché l’infermiera e l’autista, alle spalle del vecchio, volessero fargli capire con le loro espressioni che il vecchio stava delirando, lui era convinto che invece diceva la verità e che sessantasei anni prima aveva massacrato a colpi di accetta una ragazza, tanto da renderne il cadavere assolutamente irriconoscibile. «Capisco», disse infine il maresciallo, «ho fatto prendere nota di quanto lei ha detto e lo comunicherò al procuratore della Repubblica. Comunque, siccome sono passati oltre trent’anni dal delitto, anzi, il doppio e più di trent’anni, il delitto è caduto in prescrizione.» «Prescrizione?...» disse il vecchio. Nonostante la sua chiarezza mentale, qualche cosa gli sfuggiva, così il senso della parola «prescrizione» che solo in quel momento cominciava a intuire. «Prescrizione vuol dire che il reato è prescritto, che non è più punibile», spiegò il maresciallo. «E perché?» «Perché dopo trent’anni c’è la prescrizione», il maresciallo lo disse col tono di voce, come dicesse: dopo trent’anni, quello che è stato è stato. «E qui ne sono passati sessantasei di anni.» Allora lui si alzò, appoggiandosi con la destra al Burester e sostenuto al gomito sinistro dall’infermiera. «Sono venuto qui a confessare di aver commesso un delitto, e credevo che lei mi avrebbe arrestato.» Il maresciallo si alzò anche lui. «Non posso arrestarla. Comunicherò i fatti che lei mi ha raccontato al procuratore della Repubblica, e deciderà lui.» Dopo sessantasei anni quel vecchio doveva venire a dare fastidio proprio a lui. La Mercedes tornò alla villa nella pineta di Fregene, a duecento metri di distanza dal mare. Veramente, lui non la chiamava la villa, ma l’agonizzatoio, perché da anni e anni stava agonizzando, lì, sul luogo del delitto, vicino a dove una volta era il capanno del boscaiolo, e aveva fatto costruire la villa proprio lì, perché dicono che gli assassini tornano sul luogo del delitto, ma lui addirittura ci abitava, ci agonizzava, da anni, e da tanti anni avrebbe voluto morire, e invece stava sempre bene, sempre meglio, pareva che ringiovanisse. Aiutato dall’infermiera lui si cambiò d’abito, perché nel tardo pomeriggio occorre vestirsi con abiti più scuri, e prese il bastone Wander dal pomello d’avorio e andò nel salone biblioteca dove poté leggere sull’enciclopedia che un reato cade in prescrizione quando è passato un certo numero di anni, di solito almeno venticinque. “Che sciocchezza”, pensò, “se squarto una donna a colpi di accetta oggi, allora mi mettono in galera, invece, se l’ho squartata sessantasei anni fa, niente. Ma chi è che ha fatto le leggi?” Continuò a domandarselo, seduto sulla grande poltrona davanti alla grande finestra che dava, laggiù, nel punto esatto dove una volta erano stati un capanno e un’accetta e una donna e un assassino: lui. E continuò ad agonizzare, lì, come agonizzava da tanti anni. La legge non lo voleva punire, c’erano le prescrizioni e simili imbecillaggini, e doveva starsene lì, davanti alla finestra, a vedere quel punto, trenta metri a destra oltre il distributore di benzina, dove una volta aveva fatto una donna a pezzi, ad agonizzare lì. «Commendatore, scende in sala per il pranzo?» L’infermiera era entrata, e aveva parlato con quell’aria servile e arrogante che aveva sempre. La odiava: era una servaccia che lo trattava da vecchio scemo, e questo proprio non lo tollerava. «Ho telefonato al dottore e gli ho raccontato che siamo stati dal maresciallo dei carabinieri», aggiunse la romanaccia travestita da inglese, per punirlo. Forse lui non se ne rese neppure conto, anche se aveva quasi novant’anni, l’afferrò alla gola, di colpo, e le cadde addosso, e continuò a stringere finché lei non si dibatté più, non rantolò più, non si mosse assolutamente più, e così lui capì che era morta. Poi faticosamente si rialzò, aggrappandosi alla poltrona, al tavolo. La odiava da anni, quella donna, era la testimone della sua agonia. Riuscì ad arrivare al telefono, ansante, fece il numero del centralino. «Per favore, i carabinieri», disse alla telefonista. Mentre attendeva guardò un’ultima volta dalla finestra, non voleva più agonizzare lì, era meglio il carcere, la tomba, qualunque cosa, ma non lì. «Pronto?» disse. Si sentiva un po’ svanito, a novant’anni può accadere. «Ho ucciso una donna, ma non nel 1901: l’ho uccisa adesso.» Questa volta il delitto non sarebbe andato in prescrizione: era appena successo. 2 · L’Uomo Forte Rubare l’auto era stato come un tuffo nell’acqua gelida: terribile ma rapido, un attimo convulso quando aveva aperto la portiera, si era messo al volante, aspettandosi di essere bloccato dall’antifurto, e invece niente, l’auto era partita, dolce e veloce, e allora i polmoni gli si erano riempiti di nuovo d’aria, aveva vinto, era stato Uomo Forte, e Lindi lo avrebbe visto arrivare con l’auto e avrebbe capito che era Uomo e Forte, e poi non c’era molto di male, in Svezia anche i giovani ricchi rubavano le auto per fare una scampagnata con la ragazza e la polizia gli dava soltanto una sgridata, lo aveva letto su quel giornale. Ma la trionfale euforia fu breve, scomparve alla vista del primo vigile: potevano fermarlo e non era mica in Svezia, era a Milano. Poi, al posto dell’appuntamento, Lindi aveva una faccia così tirata, e, appena salita, attaccò a piangere di paura. «Hai visto?» le disse, falso spavaldo, tremante, e il nuovo vigile che oltrepassarono gli dette uno spasimo allo stomaco. «Non piangere. Di che hai paura? Facciamo un giro, al ritorno la piantiamo per strada.» In Svezia rubavano le auto anche i giovani ricchi, ma lei continuava a piangere, e la vista di un milite della polizia stradale lo inchiodò, aggrappato al volante. Dopo un due chilometri capì che non ce l’avrebbe fatta a tirare avanti. «Dev’essere l’olio, senti come scalda, questa cretina», mentì, d’un tratto ispirato, sperando di esser creduto da lei, armeggiando e strappando col cambio marcia, sinché non furono proprio fermi. «Ma che jella, scendiamo...» Corsero fuori dall’auto divenuta un incubo, improvvisamente felici. Un poco meno lui che non aveva saputo essere l’Uomo Forte che voleva. 3 · Grazie, professore L’uomo suonò il campanello, l’infermiera gli aprì la porta, lo fece entrare, lo guidò attraverso l’anticamera e il breve corridoio e aprì la porta dello studio. Il professore che era seduto dietro la scrivania si alzò di scatto al vederlo, e divenne pallido. Richiusa la porta, lui disse mitemente, perché era un uomo mite: «Mi scusi, professore, ho dato un nome falso alla sua infermiera, per avere una visita, ma io non sono malato, non ho bisogno di un cardiologo illustre come lei, ho bisogno solo di parlarle». Sempre in piedi, gelidamente, l’illustre cardiologo disse: «Parli pure». E lui parlò: «Quattro anni fa mia moglie mi ha lasciato per mettersi con lei», parlò mitemente e mitemente continuò: «Io non ho fatto niente perché, se una donna vuole stare con un altro, nessuno la può fermare. L’unica cosa che ho fatto è stata di sorvegliarvi un poco, per i primi due anni ho visto che andavate d’accordo e non ho detto niente, poi i miei informatori mi hanno detto che cominciavate a litigare, e che lei professore aveva anche un’altra relazione». Abbassò il capo e disse mitemente, ma con un sordo dolore nella voce: «Allora ho pensato che lei forse era stanco, e che io potevo riprendermi mia moglie, e sono venuto qui per questo». Aveva in tasca una rivoltella e l’avrebbe adoperata, perché era mite ma rivoleva sua moglie, a ogni costo. L’illustre cardiologo lo guardò. Intanto che quell’uomo, quello straccetto d’uomo, parlava, aveva pensato quasi a uno scherzo, poi aveva capito che lo straccetto parlava seriamente e allora aveva respirato di sollievo. E disse gelido, oltraggioso: «Sua moglie è nella sala a destra del corridoio, credo che stia guardando la televisione. Per quello che mi riguarda, può andare a prendersela e portarsela via, anche subito: non sarò davvero io a impedirglielo. Anzi...». Lui accennò di sì, poi disse, con sincerità, con profonda sincerità, levando dalla tasca la rivoltella: «Grazie, professore, se non mi avesse detto così, l’avrei uccisa, con questa», si rimise la rivoltella in tasca. «Lei sarebbe morto e io sarei finito in galera.» Uscì dallo studio dell’illustre cardiologo, andò nel corridoio a destra, come gli era stato indicato, aprì la porta della sala, e lei era lì, sola, infelice, che guardava la televisione. Si alzò impaurita al vederlo. «Vieni a casa con me, se vuoi», lui disse mitemente, calcando col tono sul «se vuoi». E precisò, perché era mite ma anche preciso: «Lui non ti vuole più e ti lascia libera». Lei pianse solo in macchina. Venne via così, subito, senza neppure la borsetta, non disse una parola, e neppure lui la disse oltre quelle che aveva detto. 4 · Solo da ieri Aveva un bellissimo pigiama rosso sangue aperto sul petto villoso, parlava e parlava: «Ho cominciato a scassinare una serratura che avevo appena sei anni. Mio fratello maggiore aveva un grande atlante geografico, per la paura che glielo sciupassi lo teneva chiuso in un armadio in camera di mamma e papà. Io ero tanto piccolo, ma con una forbice lavorai nella serratura di quell’armadio, e dàlli e dàlli, finii per aprirlo...». Lei ascoltava. Il lenzuolo le copriva solo i fianchi. Teneva in mano quel bicchiere, glielo offriva. «Poi guarda il destino», continuò lui dopo aver bevuto, «a quindici anni mi mandano proprio a fare il fabbro. In poco tempo mi mangio tutti, compreso il principale. Con un pezzo di nastro d’acciaio apro qualsiasi serratura normale, con un cacciavite gli armadi blindati...» Lei gli offrì di nuovo il bicchiere. Lui lo vuotò. «Poi sai com’è. S’incontrano cattive compagnie. Qualcuno mi dice: “Tu potresti fare un sacco di soldi”. Io gli do retta e attacco con le casseforti degli uffici... Sinché ora non mi è riuscito il colpo grosso...», parlava attraverso la nebbia dell’alcool e del sonno, «...una cassaforte con centoventiquattro milioni. Divisi in tre, fanno più di quarantadue a cranio. Ora basta casseforti, non ne ho più bisogno. Metto su un negozietto di ferramenta a Savona e non ci mancherà niente. Io ti sposo, l’ho capito subito che sei una brava ragazza, anche se fai il mestiere che fai e ti conosco solo da ieri...» Chiuse gli occhi, si addormentò di colpo. La ragazza lo lasciò russare per un pezzo prima di cominciare a scivolare fuori dal letto. Alla fine andò, nuda, nell’ingresso, a telefonare: «Brigadiere, è lui quello delle Assicurazioni Generali...». Le dispiaceva mandare in galera un così bel ragazzo. Ma pazzo lui, pronto a sposare la prima puttana incontrata, proprio una confidente della polizia. 5 · Sapendo di mentire La serata si concluse al Beauty Show. C’erano quei due grossi cosi olandesi da portare in giro per la città con tutti i riguardi, perché si trattava di clienti da centinaia di milioni al colpo, e lui, per ordine del direttore generale, li aveva portati in giro. Prima a Brera, per un brivido fuori moda. «Belle ragazze in Italia», disse uno dei due olandesi. «Davvero molto belle ragazze», disse l’altro, chissà quale dei due era il più grosso. Così al principio, poi lo ripeterono per l’intera serata, e a proposito di qualsiasi scorfano vedessero nei locali dove lui li guidò. Dopo l’aperitivo al bar psichedelico di Brera, li guidò a mangiare. E, al termine di una gran mangiata e di una gran bevuta, i due erano maturi per il Beauty Show. Lui ce li guidò. C’era già stato altre volte, ma sempre solo per motivi di lavoro, per accompagnare dei clienti della ditta. Lui odiava lo spogliarello. All’una, fuori dal teatro, nella fresca notte di primavera i due grossi olandesi gli fecero la solita domanda degli altri clienti. Lui era il Cicerone del relax per i clienti stranieri, li accompagnò al portone del palazzotto ospitale, li lasciò in buone mani. Finalmente poté tornare a casa. Erano le due. La moglie lo aspettava sveglia. «Che faccia hai», disse. «Devi dirgli che mandino un altro ad accompagnare in giro i sudicioni.» Lui accennò di sì, sapendo di mentire. Non poteva mica raccontare ai superiori che qua e là per il mondo aveva una figlia spogliarellista o peggio, che aveva cercato di correggerla, chiudendola in collegio, ma un baldo giovane era stato più forte di lui, degli insegnanti del collegio, perfino della polizia e gliel’aveva portata via e buttata sul mercato. «Questa è l’ultima volta che ci vado», mentì, carezzò sulla guancia la madre della spogliarellista. «Glielo dirò domani stesso.» Era tanto stanco che non si accorse neppure di morire. Morì sognando sua figlia che si spogliava per quei due grossi cosi. 6 · Nudo, no «Che cosa c’è?» disse Pippo. «Insomma, perché non andiamo?...» disse quello, seduto nell’auto, dietro, vicino a Pippo, e il cui nome era Federico Federzoni, per la polizia, ma che gli amici chiamavano il Ragazzo della via Gluck e che era sempre un poco nervoso. «La batteria...» disse quello che era al volante, e che la polizia conosceva come Ruggero Domaré, per lo meno quei pochi poliziotti, quattro, che avevano avuto il coraggio di affrontarlo, e di cui due erano stati fulmineamente trapassati, nella giusta e definitiva sede toracica, dalle pallottole della rivoltella di Ruggero Domaré che nel suo ambiente veniva chiamato il Bello, semplicemente, perché simbolo della bellezza, così alto, così grosso, e così focosamente rosso di capelli, perché quello era il suo ultimo cachet. Quando aveva lavorato nel dipartimento ricatti agli anormali, i suoi capelli erano biondo cenere, tutti abboccolati, e quando invece faceva la spola da Marsiglia a Genova alla pesca di ragazzine da mettere in pista, allora il cachet era nero, lucido, e aveva dei basettoni riccioluti che sembrava importato fresco fresco, incartato nella carta velina, come le arance, da Palermo o da Piazza Armerina, così che non solo le svedesi o le tedesche si scioglievano per lui, ma anche le pollastre nostrane. Gli dicevano Bello, semplicemente, perché lo era, e anche la polizia sapeva che il suo nome, più vero di quello vero, era il Bello. E il Bello disse: «Queste porche e sporche batterie, oggi le fanno con lo sputo». «Non possiamo restare fermi qui, davanti a questa trattoria, con te con quei capelli così rossi», disse nervosamente il Ragazzo della via Gluck, «ci sono tutti i carabinieri della Valle Padana addosso a noi. Fila via, Bello, non possiamo dormire.» «Se la batteria non funziona, la macchina non parte», disse il Bello. «Allora noi due scendiamo e spingiamo la macchina», disse Pippo, che era un uomo pratico. Dallo specchietto il Bello guardò i due che scendevano, richiudevano le portiere, e li vide, dietro il cofano, che cominciavano a spingere. La snella Taunus, infatti, si mosse e lui innestò la marcia e spinse piuttosto forte l’acceleratore. La Taunus allora filò via come una freccia scoccata da un antico mastro arciere, e lui guardò dallo specchietto i due, Pippo e il Ragazzo della via Gluck, che lo guardavano pensando che lui si sarebbe fermato, dopo aver preso la rincorsa, ma lui, il Bello, schiacciava sempre di più l’acceleratore, non aveva nessuna voglia di fermarsi e alla prima dolce curva che conduceva a Cassano d’Adda non li vide più. Ed era esattamente quello che voleva, così continuò a spingere l’acceleratore finché vicino a Cassano d’Adda, nel sole splendente di quel pomeriggio di primavera, rallentò e prese una stradina che conduceva in mezzo ai campi. La prima questione da risolvere era quella dei capelli rossi. Il suo intuito di ex campagnolo, figlio di contadini, lo guidò giusto e arrivò al doppio filare di gelsi in mezzo a cui scorreva il canaletto di neppure un metro. Si guardò intorno, erano i placidi, roridi campi lombardi e non c’era nessuno, era l’una e mezzo e la gente stava ancora a tavola o già faceva il sonnellino. Si buttò in terra e affondò la testa nell’acqua non molto pulita e neppure odorosa del canaletto: era un cachet idrosolubile, potete farvi i capelli biondi al mattino, neri il pomeriggio e verdi la sera, se volete, perché con una sciacquata il colore va via. E mentre si sciacquava energicamente le chiome che spandevano fiotti di rosso nell’acqua torbidella del canaletto pensò, ridacchiando dentro di sé, che la polizia stava cercando tre uomini in impermeabile chiaro, quasi bianco, uno dai capelli rossi, molto rossi, il viso tutto efelidi più di quello di Rita Pavone, e due bei biondi. I tre uomini, così biondi e così rossi e così vistosi, erano saliti al secondo piano del palazzo dell’Amministrazione provinciale, in via Vivaio, vicino all’istituto dei ciechi, avevano chiesto di parlare col professor Umberto Uberti, capo del dipartimento farmacologico SN, cioè sezione narcotici. Erano agenti dell’ufficio controllo della dogana di Chiasso, e avevano mostrato le loro tessere, e venivano a verificare che i due chili di Bolder, il narcotico numero 2 nella scala degli allucinogeni di Fitzgerald, fossero arrivati lì. Alla presenza di due poliziotti in divisa e armati, del professor Umberto Uberti e della segretaria dell’SN, sezione narcotici, dottoressa in chimica Laura Giovannini, era stato aperto il piccolo armadio a muro dallo sportello di acciaio dello spessore di quindici centimetri nel cui interno erano i due lunghi rulli contenenti le quattromila capsule di Bolder, ciascuna di mezzo grammo. Si dice due chili di allucinogeno. I tre uomini, due dai capelli biondi, uno dai capelli rossi, avevano tolto i rulli dall’armadietto blindato e avevano controllato che i sigilli ai coperchi dei rulli fossero intatti, come infatti erano. Quei controlli erano necessari perché qualche volta alla dogana, con tutti i documenti in regola, passano narcotici destinati agli ospedali e che dovrebbero arrivare all’amministrazione provinciale che li distribuisce, appunto, agli ospedali della provincia, col dovuto controllo, ma che invece si perdono lungo la strada, o diminuiscono di peso, un chilo diventa mezzo, e i tre avevano detto, ecco, che venivano dalla dogana di Chiasso a controllare se il Bolder era arrivato a destinazione. Ma quando i due rulli erano stati fuori dall’armadietto, sul tavolo di vetro del severo ufficio, i tre uomini, Pippo, il Ragazzo della via Gluck e il Bello, avevano levato dalle tasche dei loro impermeabili bianchi corti pezzi di tubo di piombo, e contemporaneamente, come in un balletto studiato in diecine di prove, avevano colpito in pieno viso, con fulminea rapidità e con bestiale violenza, i due agenti, il professore e la dottoressa. Le vittime erano crollate a terra col viso fracassato. La dottoressa in chimica era morta di colpo, il professor Umberto Uberti sarebbe morto tre giorni dopo; dei due agenti, uno sarebbe rimasto cieco e col viso tutto deformato, e all’altro avrebbero applicato al cranio sfondato una placca d’argento, ma era dubbio che sarebbe tornato mai più, mentalmente e fisicamente, un uomo normale. I tre, allora, avevano preso i due rulli di Bolder e li avevano messi nella grande borsa nera che si erano portati appresso, e prima di uscire avevano schiacciato il bottone che accendeva la lampadina rossa fuori dell’ufficio in modo che, per un bel pezzo, neppure l’usciere più sfacciato avrebbe osato entrare, quindi se ne erano andati via, svelti, ma senza paura. Non si possono fermare tre signori che salgono su un’auto con la bandierina della Finanza e con la vistosa targa Polizia Doganale; il carabiniere al portone aveva perfino salutato, rispettosissimo. In una solitaria traversa di viale Monza, ed esattamente in via Fratelli Bressan, i due biondi e il rosso avevano lasciato l’Alfa, rubata, togliendo la bandierina e la targa, ed erano saliti, con la borsa coi due rulli di Bolder, sulla Taunus, e se ne erano andati verso Cassano d’Adda. Il colpo era stato studiato e preparato per quasi un anno da un cervellone che nessuno aveva mai visto ma di cui sapevano il nome, Mario Rossi, che era come dire l’Innominato, il quale da lontano, attraverso emissari, li aveva istruiti come un regista puntiglioso guida gli interpreti in un’impegnativa opera di Shakespeare. I corti impermeabili chiari, quasi bianchi, erano a double face, chiari da una parte, grigio scuro dall’altra. Insomma, la polizia si sarebbe lanciata all’inseguimento di tre uomini in impermeabile chiaro, due biondi e uno rosso, a bordo di un’Alfa, e invece loro non erano né biondi né rossi, ma banalmente castani, e avevano un impermeabile grigio, e andavano con una Taunus, non con l’Alfa. Dopo essersi lavato i capelli finché l’acqua del canaletto smise di diventare rossa, il Bello, sia pure con riluttanza, dato l’odore di quell’acqua, si lavò il viso per cancellare le efelidi che si era disegnato con la matita, e intanto gli veniva da ridere perché lui a scuola, in aritmetica, non aveva mai preso alti voti, anzi; però aveva pensato che se riusciva a tenersi tutto il Bolder lui, invece che dividerlo in undici, come aveva decretato il lontano e misterioso cervellone Mario Rossi, invece di prendere un undicesimo, avrebbe preso tutto. E così aveva seminato i suoi due colleghi, Pippo e il Ragazzo della via Gluck, fingendo che la batteria fosse scarica, così loro erano scesi per spingere la macchina, e lui li aveva piantati portandosi via la grande borsa nera con dentro i due rulli di Bolder. Saltò in piedi, finito il lavacro, il capo basso, strizzandosi con le mani i capelli non più rossi, e passandosi poi le mani sul viso per asciugarlo, e mentre aveva il viso così coperto dalle mani, sentì un dolce muuuhhh, e scoprendo il viso, vide appunto che si trattava di una vacca arrivata a pochi metri da lui, e la vacca non lo avrebbe preoccupato, ma c’era un vecchietto con un bastoncino che guidava l’animale, e dagli occhi attoniti di lui capì che il vecchietto aveva veduto lui che si lavava i capelli rossi e diveniva castano: ne avrebbe parlato per tutta la vita, in tutta Cassano d’Adda e dintorni. Sarebbero bastate poche ore e il più pigro carabiniere della zona sarebbe stato informato che un uomo così e così, che aveva i capelli rossi, se li era lavati nel fossatello ed era divenuto castano, e che guidava una macchina così e così, benché vecchio e contadino forse distingueva le marche di auto, Taunus, e la targa col numero poteva ricordarsela. «Ehi, per favore!...» sorrise al contadino che guidava la vacca, gli sorrise, il viso esposto al sole già caldo di quella intensa giornata di marzo, agitò un braccio festoso, scrollandosi le gocce d’acqua che gli colavano sul viso dai capelli ancora bagnati. Il vecchio contadino si avvicinò con la sua vacca, adesso era quasi sul bordo del fossatello, lui continuò a sorridergli. «Per Cassano, da che parte devo andare?» domandò, e si guardò in giro, non c’era nessuno, e allora non attese neppure la risposta, strinse il vecchietto alla gola e si buttò in terra con lui, e prima che lui potesse emettere un solo gemito gli immerse la testa nell’acqua del canaletto e ve la tenne finché il contadino smise di dibattersi e allora lo lasciò cadere tutto nell’acqua, e ancora per un paio di minuti stette a guardarlo, per assicurarsi che non avrebbe mai più parlato, e anche la vacca che gli era vicina guardava, ma senza comprendere, ovviamente, e, anche se comprendeva, senza interesse. Lui dette una manata sul bianco collo della vacca e salì in auto. Prima di mettere in moto controllò i sedili posteriori: la borsa nera coi due rulli di Bolder era lì. Avviò l’auto, tornò in strada e accese la radio. Una tenera, trillante voce di bambina si mise subito a cantare: «La minicoda, la minicoda, tra i minigatti è molto di moda – la minicoda, la minicoda», e alla fine della canzone l’annunciatrice disse: «Abbiamo trasmesso una delle canzoni presentate allo Zecchino d’Oro». Guidando, lui, il Bello, si passò una mano sul viso per asciugarsi qualche goccia che pioveva ancora dai capelli bagnati. «La minicoda, la minicoda», mormorava, perché la canzone gli era piaciuta, «tra i minigatti è molto di moda.» Una capsula di Bolder di mezzo grammo può bastare per due applicazioni, si dice così: si bagna l’estremità senza fosforo di un fiammifero di legno e s’immerge il fiammifero così umido nella capsula ritirandone un po’ di polvere rosea, quindi si mette il fiammifero in bocca, sotto la lingua. L’effetto, appunto, è sublinguale, per assorbimento, come quello del cianuro, ed immediato, solo che per il cianuro si dice: conta fino a tre e poi muori, mentre per il Bolder si può dire: conta fino a tre e poi esplodi. Un’applicazione di Bolder, vezzeggiativo di una formula chimica lunga diverse righe di stampa, dura circa un paio d’ore. In queste due ore un uomo si sente onnipotente, in ogni senso: immaginativamente vive in un mondo cinerama a colori con grandi orchestre. Fisicamente si sente, forse è solo una sensazione, in grado di atterrare un toro a pugni. E sessualmente si sente più capace di un gallo andaluso, e i galli andalusi sono noti non solo per la loro ferocia nei combattimenti ma, anche di più, per lo straordinario numero di galline che riescono a sedurre. Il Bolder, ecco, rende baldi, più baldi, come dice il nome, rende Superman, rende Nembo Kid, e anche un poco Diabolik o marchese di Sade. Finito l’effetto, un paio d’ore circa, si passano un po’ di giorni parte dormendo sfiniti, parte in bagno in preda a violente convulsioni addominali. Ma c’è un molto grande numero di persone che giudica che valga la pena di questi inconvenienti pur di fare un’applicazione. Medici specialisti hanno dimostrato che anche il fisico più robusto in due o tre anni al massimo di applicazioni esplode definitivamente per paralisi cardiaca. Ma queste dimostrazioni non vengono lette dai tossicomani che non leggono in genere nulla e tanto meno le pubblicazioni scientifiche di tossicologia. Il Bolder è uno dei meno nobili allucinogeni, anche i più avidi di droghe hanno timore dei suoi effetti brutali. Ma è appunto la violenza, l’immediatezza, la brutalità dei suoi effetti che attira molta gente. I due rulli contenenti 4000 capsule di Bolder valevano, ma a buttarli via, un’ottantina di milioni. Lo smercio non era difficile. Queste furono le cose che i due funzionari dell’ufficio stampa della questura spiegarono a oltre una dozzina di giornalisti accorsi alla chiamata. «Come sempre, questi delinquenti non hanno molta stima della polizia. Gli uomini che hanno massacrato quattro persone all’Amministrazione provinciale», disse uno dei funzionari ai giornalisti, «non sono né biondi, né rossi, né hanno impermeabili bianchi. Sono degli stupidi che pensano che noi ci mettiamo a inseguire dei biondi e dei rossi in impermeabile bianco. Noi non inseguiremo nessuno», disse energicamente il funzionario, con fonda voce siciliana, «sarete voi giornalisti a prenderli, perché noi abbiamo le fotografie dei tre uomini che hanno fatto il colpo...» Due uscieri svolsero sul grande tavolo le tre fotografie formato gigante 96 × 72. Erano le fotografie, 1) di Federico Federzoni, detto il Ragazzo della via Gluck, 2) di Giuseppe Pestalozzi, detto Pippo e, 3) di Ruggero Domaré, detto il Bello. «Questi sono i tre uomini da prendere», disse il funzionario, coi baffetti che gli si muovevano nervosi; «darò una fotografia a ciascuno di voi: pubblicatela, date il massimo rilievo possibile alla notizia. Quattro persone sono in fin di vita o rovinate per sempre, a causa loro, ma anche loro hanno commesso un errore. Il cervellone che ha organizzato il colpo si è tradito: ha firmato il suo delitto. Uno dei poliziotti, quello accecato, ha detto di essere stato colpito con un tubo di piombo. Prima di perdere la vista per sempre ha distinto perfettamente il corto, pesante tubo col quale uno dei tre lo ha colpito. Due anni fa, a Parigi, Le Premier Bureau de la Direction Narcotiques veniva invaso da quattro uomini venuti per un’ispezione da parte della SSN, Suprema Sorveglianza Narcotici, che si impossessarono di tutto il quantitativo di morfina, uccidendo o ferendo gravemente gli agenti di guardia e i medici dirigenti dell’ufficio con tubi di piombo come questo», e mostrò la fotografia. «Date il massimo rilievo alla notizia, non abbiate paura di creare panico, ma dite che i tre più pericolosi delinquenti che esistano in Europa girano per un triangolo Torino-Milano-Brescia-Parma-Torino. Da questo triangolo non possono uscire, vi sono già oltre duecento blocchi stradali, questo triangolo è la loro trappola, ma è solo col vostro aiuto di giornalisti che faremo molto più presto. Pubblicate queste foto, avvertite che sono gente che spara subito, e che vi sono due milioni di taglia. Fate dei titoli grossi come una casa e forse in ventiquattro ore, ho detto ventiquattro, li prenderemo...» I baffetti alla Hitler del funzionario smisero di agitarsi. «Dipende molto da voi: la stampa. Noi possiamo fare i blocchi stradali, possiamo chiuderli in una rete, ma possono passare anche delle settimane, prima di prenderli, e intanto loro ammazzano altra gente. Ma se pubblicate le loro fotografie sui vostri giornali, se incitate la gente a dar loro la caccia come a bestie feroci, allora li prenderemo subito.» Il funzionario chinò il capo: «Grazie». E il vecchio usciere cominciò a distribuire a ciascun giornalista le fotografie formato gigante dei tre, Pippo, il Bello, il Ragazzo della via Gluck, oltre a quella del tubo di piombo, più i foglietti del curriculum vitae dei tre. Alla stazione di Cremona, a mezzanotte, lui scese dalla Taunus, con la borsa nera dove c’erano i due rulli del Bolder, e andò allo sportello a prendere un biglietto per Milano, seconda classe. Secondo il piano, aveva girellato pigramente fino a quell’ora. Il suo problema era semplice e delicato. La semplicità consisteva nel fatto che doveva vendere a un signore, che lo aspettava a Lugano, il carico di Bolder. Si trattava in fondo di andare a Lugano: molto semplice. La delicatezza, invece, consisteva nel fatto che diverse persone erano fermamente intenzionate a impedirglielo, eventualmente ad ammazzarlo, pur di riprendergli il Bolder, e a non lasciarlo andare né a Lugano, né altrove. Parte di queste persone erano circa duemila tra poliziotti e carabinieri, più una cinquantina di cani addestrati alla caccia all’uomo. Le altre erano i suoi amici, i suoi colleghi: Pippo, il Ragazzo della via Gluck, il cervellone Mario Rossi e un’altra mezza dozzina di ometti della banda, che non potevano perdonargli lo scherzo. Questi colleghi e amici stavano già battendo tutta la Valle Padana alla sua ricerca, alla ricerca di una Taunus nera, ma questo lui lo aveva previsto e così adesso prendeva il treno e se ne tornava a Milano, come aveva pianificato da molto tempo prima, appena avuta l’idea di tenersi tutto il Bolder per sé. Né la polizia né i suoi amici Pippo o il Ragazzo della via Gluck, però, potevano immaginare che avesse la sfacciataggine di tornare a Milano, e in via Conservatorio, cioè a una cinquantina di metri dal palazzo dell’Amministrazione provinciale, dove era stato fatto il colpo, rubati i due rulli di Bolder e ammazzate o mezzo ammazzate quattro persone. Ma lui in via Conservatorio aveva la sua ragazza, quella che nessuno conosceva, di cui mai aveva parlato a nessuno, anche perché era ragazza per modo di dire, aveva quarantadue anni e non li portava neppure troppo bene, ma aveva un nascosto pregio, la grossa sartoria che possedeva in via Montenapoleone: che, se a lui occorrevano, in momenti di penuria, centomila lire, lei, le guance un po’ cadenti, nonostante il lifting, metteva dieci biglietti da diecimila uno sopra l’altro. Nessuno sapeva di questo suo legame nella società bene, e lui aveva appunto calcolato di nascondersi dalla Cristi Solario, che era il nome della quarantaduenne sarta delle più aristocratiche signore di Milano e provincia, soltanto qualche giorno per vedere come si mettevano le cose, e aspettare il momento giusto di poter filare a Lugano a vendere il Bolder a quel signore. Perciò lasciò la Taunus alla stazione di Cremona, ma di fianco, in una piccola, buia strada, dove avrebbe potuto sostare anche delle giornate senza essere notata, e prese il treno delle ore zero e trentacinque minuti, come aveva calcolato fin dal principio. Era una specie di treno merci, peggio di un accelerato, e arrivò alla stazione di Milano che erano quasi le tre. Ora ideale, non c’era quasi nessuno, anche i poliziotti si stendono sui divani o sulle poltrone degli uffici interni, aveva una manciatella di gettoni telefonici in tasca, perché, umanamente, cercava di prevedere tutto, si buttò nella prima cabina e chiamò. A quell’ora, le tre, la cameriera non rispondeva, infatti rispose lei, dopo un poco, anzi, molto poco, perché, se non doveva fare l’amore, gli aveva spiegato una volta, lei la sera prendeva il sonnifero. E rispose con la voce grassa di sonnifero. «Pronto?» «Sono Ruggero», lui disse. Nessuno gli rispose, per molto tempo, e allora lui disse: «Pronto? Mi senti?». La voce di lei, meno grassa, anzi, tagliente e tremante nello stesso tempo, disse: «Sì, ti sento...». «Cristi», lui disse, facendo la voce morbida da latin lover e tenendo ben stretta nella mano la borsa col Bolder, «ho bisogno di parlarti, subito.» Ancora un troppo lungo silenzio, e ancora lui disse: «Pronto? Mi senti?». «Sì, ti sento.» «Cristi, scusami, ma ho bisogno di vederti subito. Sono qui alla stazione, prendo un tassì e vengo lì.» Un silenzio meno lungo, poi la voce della quarantaduenne: «Sì, ti aspetto al portone». E dieci minuti dopo lui arrivava in quella vecchia palazzina di via Conservatorio, così aristocratica, e sul portone c’era lei, Cristi Solario, una delle dodici signore dell’alta moda milanese e una delle donne più sole al mondo e, di conseguenza, più desiderose d’amore al mondo. Aveva indosso una pelliccia di cavallino color biondo, proprio il biondo dei capelli biondi, sopra la vestaglia. Lui cominciò a baciarla in ascensore. Il suo mestiere lo sapeva fare benissimo. Alle cinque gli venne sonno e spense la luce del paralume sul comodino dalla parte di lei. Ma lei lo riaccese. «Cosa c’è?» disse lui, «adesso dormiamo.» «No», disse lei, «devo farti vedere un giornale.» «Oh, senti, a quest’ora non leggo...» «Io invece sì, leggo a qualunque ora, molti giornali, e ce n’è uno che ti deve interessare», uscì dal letto, si alzò in piedi, completamente nuda, non per impudicizia, ma per vanità: perché mentre il viso era vecchio, il corpo aveva la forma e l’elasticità di quello di una ragazza, e uscì dalla camera. Il tono della voce di lei gli fece passare il sonno. A parte il fatto che a lui, personalmente, non piacevano i giornali, e nemmeno i giornalisti, sapeva che Cristi era una donna troppo intelligente e che vi doveva essere un motivo serio perché alle cinque del mattino, dopo tanto amore, volesse fargli vedere un giornale. E lei arrivò, ma dopo un poco, dalla sala dove era andata a prendere il giornale, teneva il giornale davanti a sé. Era La Notte, la prima pagina, ultima edizione, e vi erano tre foto che occupavano tutta la prima metà alta della pagina: una era quella di Pippo, l’altra quella del Ragazzo della via Gluck, e la terza era la sua. Il titolo, per tutte le nove colonne, era: Le belve della droga, poi c’erano anche tre righe corpo 36 in cui veniva specificato che si trattava dei tre più pericolosi delinquenti europei, neppure italiani, europei. «Non sapevo che tu fossi così famoso...» gli disse lei, e gli buttò il giornale in faccia, in uno scoppio di pianto. Sì, certo, aveva pensato che era uno dei tanti forchettoni addosso alle donne vecchiarde come lei, non si era mai illusa che potesse essere diverso, ma non fino a quel punto. I suoi amori, purtroppo, avevano tutti una base interessata, sapeva di dover pagare, e pagava. Ma c’era un limite. Lui si mise in ginocchio sul letto e il giornale che prese per leggere, per vedere la sua fotografia, si sparse sopra le lenzuola. Le belve della droga. Quattro persone massacrate a colpi di tubo di piombo. Due chili di allucinogeni rapinati alla Sezione Narcotici. Queste sono le fotografie dei rapinatori. Due milioni di taglia. Lui lesse un poco, si guardò nella fotografia: era proprio il suo viso, senza efelidi, senza trucco di capelli, lui-lui come lo avevano fotografato una volta a Genova durante la retata per il contrabbando di caffè. Piangendo, lei sedette sul letto e si coprì con le coperte. «Ruggero, va’ via, scappa, Ruggero, scappa...» singhiozzò. Lui buttò il giornale in terra, sprezzante. «Ma io no, questo è il miglior nascondiglio che ci sia per me, a pochi metri dal palazzo dove ho preso il Bolder; via Vivaio si vede da qui, dalle tue finestre, nessuno mi viene a cercare qui. Poi si calmano le ricerche e io vado.» «No, Ruggero», lei adesso singhiozzava forte. «Va’ via subito, scappa, ho chiamato la polizia. Stanno arrivando.» Per quanto fosse furbo, al primo momento lui si rifiutò di capire, poi l’afferrò per il collo e la schiacciò sul cuscino. «Hai telefonato alla polizia?» «Sì.» «Quando?» «Adesso...» La schiacciò ancora più brutalmente contro il cuscino, stringendole il collo fino a soffocarla. «Come, adesso? Cosa vuol dire: adesso?» «Quando sono andata a prendere il giornale, in sala, il giornale che ti ho portato, e ho telefonato anche alla polizia.» E c’era una cosa che lei non poteva dire, né a lui, né a nessuno, neppure a sé stessa: che avrebbe voluto chiamare la polizia fin da quando lui le aveva telefonato dalla stazione, ma era una donna fatta così, prima di denunciarlo alla polizia aveva avuto la debolezza di essere ancora vicino a lui. «E allora sei morta...» disse lui, perché in quello stesso momento tutto l’isolato echeggiò dell’ululio di molte sirene d’auto. Dovevano essere un reggimento di poliziotti. Non gli venne neppure in mente di tentare di fuggire, capiva che tutta la zona era circondata. Si limitò semplicemente a ripeterle: «E allora muori». E le sue dieci dita si strinsero intorno al collo di lei. Poi cominciò a vestirsi, nel clangore delle sirene delle auto della polizia, perché non gli piaceva essere arrestato nudo. 7 · Il delitto non rende Lo strillo della ragazza era previsto, quasi non lo udì neppure, sentì appena il caldo della mano di lei, mentre le strappava la borsetta, poi dette più gas che poté alla moto; dallo specchietto vide la ragazza barcollare per l’urto ricevuto, e la faccia attonita, con la bocca aperta, di una donna che aveva capito quello che avveniva, uno scippo, e stava appunto a bocca aperta, senza gridare, stupefatta di aver capito. Quando fermò la moto, era già molto lontano. Guardò nella borsetta, e ci trovò esattamente cinquantamila lire, cinque biglietti da diecimila. Non credeva tanto: lei aveva un aspetto modesto, non aveva l’aria di una capace di tenersi tutti quei michelangeli nella borsetta. C’era anche la carta d’identità della ragazza. La scorse rapidamente prima di buttare via la borsetta: Maria Norassi, ventiquattro anni, commessa... «Maria Norassi, ventiquattro anni, commessa...» ripeté l’agente, scrivendo, «Quanto c’era nella borsetta?» La fissava, lei disse: «Cinquantamila lire.» Non era stata sua l’idea di denunciare lo scippo alla polizia, ma erano accorsi dei passanti, un vigile, l’avevano portata al commissariato. «Cinquantamila lire», ripeté l’agente, scrivendo. «Altri valori?» Lei rispose che non aveva altri valori nella borsetta. «Mica farsi illusioni», disse l’agente con affettuosa amarezza, «anche se prendiamo quel mascalzone, non prendiamo certo le cinquantamila lire.» Lei uscì dal commissariato, e le mani libere, senza borsetta, le davano disagio. Si rese conto d’improvviso che non aveva una lira e che, per arrivare a casa, avrebbe dovuto attraversare a piedi tutta la città. Arrivare lì, invece, era stato facile. La Mercedes dell’ingegnere non aveva impiegato neppure venti minuti sino al villino accogliente. L’ingegnere aveva ancora un aspetto giovanile, in fondo era stata una cosa meno odiosa e triste di quanto avesse pensato. Era la prima volta che lei faceva una cosa simile, ma l’ingegnere era stato molto gentile e delicato anche nel metterle i cinque biglietti da diecimila nella borsetta. Era uscita non troppo avvilita dal villino per andare al posteggio dei taxi e tornare a casa, e allora era successo il guaio. Si fermò, dopo un poco che camminava, all’angolo di un viale che dava su un piazzale: era una parte di città sconosciuta per lei. All’angolo c’era un bar tabaccheria, in una vetrinetta erano esposti accendini e pipe di varie qualità. Lei aveva progettato con quelle cinquantamila lire anche di comprare un accendino per Renato. Aveva voglia di piangere, ma a che sarebbe servito? E poi aveva anche voglia di ridere: il delitto non rende. Riprese a scarpinare. 8 · Meglio non licenziarle «Signorina, la prego, si ricordi che quello che lei mi ha detto deve ripeterlo in tribunale sotto giuramento, e che, se non ha le prove, potrà essere denunciata per calunnia», disse l’avvocato. «Ma io ho le prove», lei disse. «Anzi, le copie.» «Copie?» disse l’avvocato. «Che cosa intende per copie?» «Per esempio, questa», disse lei. Era abbastanza giovane e abbastanza graziosa, ma anche abbastanza sciupata per i suoi ventinove anni, e levò dalla valigetta che teneva sulle ginocchia una cartella con dentro molte veline, e dalla cartella una velina celestina. «Questa è la copia di una fattura di ventidue milioni per l’acquisto di ventisei bobine monorichiamatrici di emergenza per montacarichi e ascensori normali. E questa è la copia della giacenza in magazzino delle bobine monorichiamatrici: mancano esattamente le ventisei bobine elencate in questa fattura...» «Lei quindi vuol dire che il suo direttore ha finto di comprare queste ventisei bobine, invece non ha comprato niente e d’accordo con la ditta venditrice si è spartito i ventidue milioni che figurano in questa fattura?» disse l’avvocato. «Non lo dico solo io», disse lei, tranquilla e tenacemente vendicativa, «lo dicono anche questi documenti. Qui c’è il conto dell’autorimessa e servizi automobilistici», e tese all’avvocato un altro foglio. L’avvocato lesse il foglio. «È un normale rendiconto di autoservizi per un’azienda grande come la Wenk...» «No», disse lei, implacabile, «il dottor Linzevi, mio direttore, faceva maggiorare le fatture, di oltre mezzo milione al mese, e in cambio aveva sempre a disposizione le macchine con autista. Si dividevano la quota tra lui e il direttore dell’autonoleggio.» «Lei ha le prove di questo?» disse l’avvocato. «Guardi che è un’accusa molto grave.» «Oh, sì», disse lei tirando fuori un’altra velina dalla cartella, «ecco la copia del chilometraggio fatto dalle undici auto della Wenk e dai ventiquattro camion; il costo complessivo della benzina, degli autisti e del resto non arriva al sessantacinque per cento della fattura: questo vuol dire che il rimanente trentacinque per cento è stato rubato.» L’avvocato non amava le parole forti e alzò la mano, ma fu inutile, lei ripeté: «...è stato rubato dal dottor Linzevi, e diviso col direttore dell’autonoleggio». L’avvocato accennò di sì col capo, perché il ragionamento era irrefutabile. E continuò ad ascoltare la giovane graziosa donna che a poco a poco inondò il suo tavolo di veline che provavano come il dottor Linzevi, direttore generale della Wenk, frodasse la sua grossa azienda, per decine e decine di milioni all’anno, e, approfittando della sua carica, per speculazioni anche meschine come quella di farsi fare la spesa per la sua famiglia, nei migliori negozi della città, a spese della mensa aziendale della Wenk. «Per quanti anni lei è stata segretaria del dottor Linzevi?...» disse l’avvocato, sommerso da tutte quelle indiscutibili veline. «Sei anni», lei rispose quieta, ormai placata, avendo detto tutto. «E perché il dottor Linzevi l’ha licenziata?» disse l’avvocato. «Perché ne ha presa un’altra, di ventidue anni, che gli piace di più», lei rispose, inequivocabilmente chiara. L’avvocato la guardò. Il dottor Linzevi era ora un uomo finito. Sette o otto anni di carcere, e la rovina completa. Meglio non licenziarle, le segretarie. 9 · La cartella di Longadà «Se gli porta via la cartella, Longadà ci crepa», disse l’assistente. Il direttore alzò le spalle. «Può essere», disse, «ma se gliela lascio, mi spaventa e mi fa star male tutti gli altri. Gliela porti via, anche con la forza, se occorre...» Gliela dovettero portar via con la forza, perché lui non la lasciava mai, la cartella; di notte se la metteva sotto la schiena, di giorno la teneva sempre stretta sotto un braccio; gliela portarono via due infermieri, dicendogli che dovevano svestirlo per mettergli un abito nuovo, ma lui si accorse che gli strappavano la cartella e così vecchio come era, novantadue anni, s’aggrappò a un infermiere, le dita come pinze d’acciaio sulle sue braccia, rantolando che la cartella era sua, e riuscì a riafferrarla, ma malamente, così che i ritagli di giornale che conteneva si sparsero per tutta l’infermeria volando spinti dal vento che entrava dai finestroni. I ritagli col suo nome scritto in grande e il titolo La strage di Longadà, giornali di oltre settant’anni prima, quando lui non aveva ancora vent’anni, ma aveva già ucciso sei persone, tutta la sua famiglia, con l’accetta, e lo avevano condannato all’ergastolo, dove per tutta la vita era stato il primo, il più temuto e rispettato, perché nessun altro ergastolano aveva commesso un furibondo macello simile, e la cartella coi ritagli lo documentava, e poi lo avevano mandato in quell’ospedale per vecchioni, dove continuava a essere il primo, terrorizzando i suoi compagni, facendosi ubbidire come un potente, mostrando vanitosamente i documenti della sua antica ma insuperabile ferocia. «La cartella, la cartella, la cartella...» rantolò prima del collasso. 10 · Fine del viaggio «Sì, va bene, vi siete sposati questa mattina, ma venite lo stesso con noi...» disse il milite. Si avviò con il suo compagno sotto la pioggia verso la caserma, mentre loro, nella quasi putrescente millequattro il cui immortale motore funzionava ancora, li seguivano a passo di funerale, e lei finiva di rivestirsi, sorpresa com’era stata poco prima dai due militi, dal fascio della lampada portatile che aveva illuminato brutalmente la tenerezza della sua nudità. «Ci siamo sposati questa mattina», disse lui in caserma, al maresciallo, «abbiamo pochi soldi per il viaggio di nozze, non possiamo andare in albergo...» Il maresciallo soffiò su un angolo della scrivania per far andar via un poco di polvere. «Perché, secondo voi, quelli sposati possono fare i propri comodi in mezzo alla strada?» Ammesso poi che fossero sposati: tentavano solo di commuoverlo con quella trovata, forse. Disse al milite di metterli in guardina, il giorno dopo avrebbe preso le informazioni, comunque c’era la denunzia per atti osceni commessi in luogo pubblico. Lei gridò di no, lui si mise a piangere: «Ma eravamo in una traversa dello stradone, era buio, pioveva, se avessimo avuto i soldi saremmo andati all’albergo...». «State calmi», disse il maresciallo uscendo, «se no c’è anche ribellione alla forza pubblica.» Non si ribellarono, piangendo entrarono uno in una stanzetta, l’altra in un’altra, lontana, della caserma: il favoloso viaggio di nozze che avevano sognato di fare senza soldi sulla carriola presa a un parco rottami, così pieni di entusiasmo e di giovinezza, era finito. Per tutta la vita, non avrebbero più sognato. 11 · Safari a Milano Un safari è una grossa partita di caccia. Si fa specialmente in Africa, mettiamo per cacciare il leone, o l’elefante, o la gazzella, o altri animali più o meno feroci o selvatici. Come è noto, la caccia all’elefante è quella che dà più emozioni. L’elefante è un animale nervoso, suscettibile, si arrabbia facilmente e quando è arrabbiato e vi si butta addosso dovete centrarlo col proiettile Kepler della carabina Kepler, proiettile che pesa esattamente 62,5 grammi ed è dirompente, una specie di piccola bomba, così che la testa dell’elefante, per corazzata che sia, viene non solo perforata, ma internamente spappolata: se però non lo centrate mentre carica, allora è come essere investiti da una valanga, anzi peggio, da un treno rapido. Un safari si può fare anche in Italia dove, per esempio in Sardegna e in Maremma, sono normali le partite di caccia al cinghiale. Ma si può fare anche a Milano e infatti undici giovani, di cui il maggiore aveva ventitré anni, lo avevano organizzato. Il luogo di caccia era via Mecenate. Via Mecenate comincia all’estrema periferia, diritta, per non dire infinita, costituita da palazzoni alti dieci, dodici piani, che sono le case di abitazione, e da edifici più bassi ma più estesi in larghezza che sono le fabbriche. Vi sono fabbriche di ogni genere, e c’è anche una specie di giardinetto, con giochi per bambini, ma i bambini non ci sono quasi mai perché gli scivoli e i girelli e i cavallucci sono di solito occupati da giovanotti che scivolano o girano o vanno a cavalluccio insieme con ragazze sulla trentina molto note alla polizia perché usano passeggiare molto la notte. Anche i giovanotti sono molto noti e sorvegliati dalla polizia. Il più anziano di loro ha ventitré anni, il minore quattordici. Un quarto di essi è stato in riformatorio, e un altro quarto in carcere a San Vittore. Gli altri, per il momento sfuggiti alla legge, sono però vivaci aspiranti sia al riformatorio sia a San Vittore. Essi costituiscono la banda. Qualche volta il sole arriva anche a via Mecenate, ma se può lo evita. Di solito in via Mecenate è tempo nuvoloso, o piovoso, o ghiacciato. Come la Groenlandia, via Mecenate può essere definita la fabbrica del maltempo. Questo è il luogo di caccia, il luogo del safari. L’animale selvaggio da cacciare in via Mecenate era un giovane ragioniere di ventisei anni, abitante quasi in fondo alla lunga strada, là dove Milano si perde nelle campagne, e che si chiamava Martino Allara. Nonostante il nome che aveva del diminutivo, era alto quasi due metri e largo come un armadio. Nei tempi andati, quando era giovane, sedici anni, era chiamato l’Elefante. Infatti a quei tempi faceva parte della banda di via Mecenate, era già stato in riformatorio, ne era uscito fingendosi un bravo ragazzo, e aveva subito trovato una ragazza da far lavorare. Insieme con la banda si era dato ai soliti furti nelle fabbriche della via o sulle auto in sosta. Aveva appunto rubato gomme a quelle auto in sosta e verso i vent’anni aveva anche preso il vizio dell’eroina, un volgare surrogato di eroina che aggiungeva all’effetto allucinante un effetto tossico massacrante. Un medico di via Mecenate che lo conosceva molto bene e che aveva compassione di lui, quando lui ebbe una crisi cardiaca in seguito a troppa eroina, lo fece ricoverare a sue spese nella vicina clinica Quattro Marie. Non solo lo disintossicò dalla droga, ma lo disintossicò anche nell’anima, lo convinse che per faticoso che sia, vivere onestamente è meglio che buttare le ragazze sui marciapiedi, o rubare e ammazzare. Nessuno saprà mai come riuscì in questo miracolo, perché vi riuscì, e nessuno saprà mai perché spese tanto denaro e tanto tempo per un giovane farabutto al quale non era legato da nulla, ma la sua opera umanitaria dette un risultato straordinario: Martino Allara, l’Elefante, uscì dalla clinica completamente guarito, materialmente e moralmente. Si staccò del tutto dalla banda, si mise a fare l’autista domestico del vecchio medico che l’aveva salvato, e la sera andò a scuola. A ventiquattro anni diventò ragioniere e il vecchio medico gli trovò un posto nella amministrazione in una fabbrica di minuterie metalliche. Adesso, a ventisei anni, per la sua volontà di lavorare, per la sua intelligenza, per la sua energia, era divenuto vicedirettore amministrativo. I suoi rapporti con la banda di via Mecenate però, da tempo, si erano fatti tesi. Era accaduto che due anni prima il ragionier Martino Allara era stato invitato a presentarsi al commissariato. Era stato ricevuto dal commissario in persona. «Si sieda.» «Grazie.» La sedia era un poco piccola per lui, ma tutte le sedie lo erano. «Lei sa che due giorni fa, qui, in via Mecenate, è stata uccisa una ragazza, una di quelle...» Fece segno di sì, che lo sapeva, un po’ perché leggeva i giornali, un po’ perché anche senza leggere i giornali tutta via Mecenate lo sapeva. «Mi scusi, ragioniere», disse con molta umanità il commissario, «io so che lei è oggi una delle persone più rispettabili della zona, ma io conosco molto bene la sua vita e so che in passato faceva parte della banda del quartiere. Ora, senza fare tante chiacchiere, le chiedo di aiutare la legge. Lei conosce tutti i ragazzi, e anche le donne che essi prostituiscono, e forse può dirci qualche particolare che ci porti a scoprire il colpevole...» Guardò il commissario negli occhi, senza parlare. Non solo poteva dare qualche particolare: poteva addirittura dire chi era stato l’assassino della ragazza, al minimo poteva indicare un’alternativa. La ragazza era Vincenzina, e Vincenzina era di Paolo. Però c’era Renatuccio, il romano, che aveva l’abitudine di soffiare le ragazze ai compagni. Era quindi evidente, lui lo sapeva, che Vincenzina aveva tentato di passare a Renatuccio, facendo le corna a Paolo, e che Paolo allora l’aveva ammazzata, per lezione anche alle altre due ragazze che aveva e che non dovevano essere tentate di passare in altra scuderia. Poteva anche darsi, però, che Vincenzina, che in un primo tempo aveva accettato le proposte di Renatuccio, dopo si fosse impaurita e fosse tornata da Paolo, allora Renatuccio per vendicarsi della mancata parola, l’aveva stesa a coltellate. Non c’era nessun dubbio, Vincenzina era stata uccisa o da Paolo o da Renatuccio. «Perché non risponde?» disse il commissario. «Perché sto pensando...» «Pensi pure, ma intanto mi ascolti», disse il commissario. «Io voglio ripulire il quartiere da questa marmaglia. Per quanto i miei uomini siano bravi, non riuscirò a molto, se lei non ci aiuta. Lei le conosce tutte, una per una, quelle brutte facce, conosce le loro abitudini, i loro sistemi, perfino i loro pensieri. Lei non è obbligato ad aiutarmi, se non vuole, mi dica di no e non le farò niente, ma per ogni ragazza che viene buttata sul marciapiede, o anche uccisa in questa zona, sarà un poco responsabile anche lei, anche se non fa più parte della banda, perché il suo silenzio è complicità con quelli della banda. Lei, per esempio, adesso sa chi ha ucciso Vincenzina, ma non me lo dice.» Lui continuò a pensare e a tacere. Non gli piaceva fare la spia, non gli piaceva fare l’informatore della polizia, ma il medico che l’aveva tirato fuori dall’abisso dell’eroina sintetica e adulterata, e dalla banda, gli aveva insegnato le cose essenziali della vita: che la giustizia è qualche cosa che deve esistere, se non esiste non può più esserci vita sociale. «Mi ha ascoltato?» disse il commissario. «Sì, ho ascoltato», disse l’Elefante. «Le ho detto che lei sa chi ha ucciso quella povera ragazza, ma non me lo dice.» «L’ho sentito benissimo», disse lui. «Perché non mi risponde?» disse il commissario. «Perché sto pensando...» disse lui. Il commissario si spazientì. «Allora senta, vada a pensare a casa. Non ho molto tempo da perdere.» «Mi scusi, signor commissario, ma resto qui. Voglio decidere subito.» «Bene», disse il commissario, rabbonito da quella risposta, «allora aspetto.» Si mise a guardare dalla finestra aperta che dava su una squallida traversa di via Mecenate, in quella squallida giornata di fine estate, attese paziente, capiva di avere di fronte un galantuomo, anche se questo galantuomo in passato era stato un farabutto, e lui, come poliziotto, rispettava i galantuomini. Dovette aspettare un poco, tanto per il suo carattere nervoso, quasi due minuti. «Signor commissario...» disse infine l’Elefante. Il commissario volse il viso verso di lui. «Sì?» disse. «Sono solo pochi anni», disse l’Elefante, «che mi trovo sulla buona strada e che ho un buon lavoro, questo lei lo sa», parlava lento e paziente, senza drammaticità. «Però, forse non sa che mi sono fidanzato e che presto vorrei sposarmi.» «No, questo non lo sapevo», disse il commissario. «Quei delinquenti», disse l’Elefante, «se io parlo e se sanno che io ho parlato, fanno qualche brutto scherzo alla mia ragazza, forse me la stendono come Vincenzina.» «Questo non avverrà. Io farò proteggere lei e la sua ragazza.» «Signor commissario, non prenda impegni. Se io parlo», spiegò l’Elefante, «devo rispedire la mia ragazza al suo paese, a Napoli, per essere sicuro che questi delinquenti non le facciano niente di male, e devo restare solo e rimandare il matrimonio fino a quando l’ultimo farabutto di via Mecenate non sarà al sicuro in qualche riformatorio o a San Vittore.» Il commissario comprese benissimo che quella era la verità. «Inoltre», continuò il ragioniere Martino Allara, «se parlo, avrò bisogno di una rivoltella, per difendermi dai miei ex amici. Quelli non scherzano, lei lo sa. Ma, siccome sono stato in riformatorio, non posso avere il porto d’armi.» «Chi lo dice?» disse il commissario. Aprì un cassetto della scrivania, frugò un momento tra varie carte, poi ne tirò fuori una e gliela mise davanti: «Questo è il modulo per la richiesta del porto d’armi. Può darsi che la richiesta venga accettata». Gli sorrise con gli occhi e anche lui sorrise con gli occhi. «Un’altra cosa, signor commissario: non voglio una lira, né alcun favore. So che la polizia usa compensare in qualche modo i suoi informatori. Io non lo faccio per compenso, lo faccio per...» Aveva in mente quello che gli aveva detto il suo vecchio medico, cioè che bisogna stare con la giustizia, ma non se la sentì, e disse: «Insomma non voglio niente». Il commissario passò al tu: «Sta’ tranquillo, non vedrai mai un soldo». Sorrisero insieme, da uomo a uomo. Poi il commissario disse ancora: «E adesso dimmi chi è che ha ucciso Vincenzina». L’Elefante annuì. Disse: «O è stato Paolo, che faceva lavorare la ragazza, o è stato Renatuccio che voleva soffiargliela...». Gli dette tutti i dati sui due bravi giovani, poi uscì. Il giorno dopo convinse Assunta, la sua fidanzata, a tornare a Napoli dai suoi. Fu una scenata terribile. Assunta era una napoletana verace. La udirono almeno per metà di via Mecenate: «Mi hai fatta venire quassù, mi hai compromessa con la scusa di sposarmi e adesso mi rimandi a casa con la scusa di un lavoro che non mi puoi spiegare. Io lo so, il lavoro che non mi puoi spiegare, è che ne hai trovata un’altra e che mi vuoi fare fessa, ma ti sbagli: io ti cavo gli occhi...». Lui dovette difendersi davvero dalle sue unghie, poi cercò ancora di resistere, poi dovette cedere e spiegarle perché voleva che lei tornasse, per un poco di tempo almeno, a Napoli. E, appena glielo ebbe spiegato, lei tacque di colpo, divenne perfino pallida, disse quasi piangendo: «No, figlio mio, tu non lo devi fare questo lavoro, quelli ti accoppano, non ci mette mica molto, quella gente». «No, non mi accopperanno», disse lui, «ma non voglio che facciano del male a te, così devi tornare a casa.» Lo disse con tanta decisione che lei capì. «Sì, Martino», disse a lui. «Se sei un uomo onesto, tornerai a Napoli a prendermi.» Assunta Maruscello partì il giorno dopo per Napoli, e da quel momento, per la banda di via Mecenate, cominciò il regno del terrore. Oltre all’arresto di Paolo e Renatuccio, per l’assassinio di Vincenzina, nessuno della banda poteva muoversi che veniva subito beccato. «Stanotte hanno svaligiato una tabaccheria al 124, sono entrati al piano di sopra, in un appartamento vuoto, hanno fatto un buco nel pavimento e si sono calati giù», telefonava il commissario al ragioniere Martino Allara, vicedirettore amministrativo delle Minuterie Metalliche Orselli. «Hai qualche idea?» Certo che lui l’aveva, l’idea: gli acrobati che saltavano alle finestre del primo e che facevano buchi nei pavimenti o nei soffitti, erano solo tre e li conosceva benissimo. «Possono essere stati solo Carlo de Marte, Luigino, quello che ha sempre il raffreddore del fieno, il cognome non me lo ricordo più, e Antonello, quel ragazzone che ha un neo vicino all’occhio.» In neppure due mesi, quelli della banda di via Mecenate non poterono più muoversi, non poterono più rubare neppure una gomma d’auto, forse neppure una mela all’ortolano, che il giorno stesso venivano pescati, al massimo il giorno dopo. In quanto allo sfruttamento, via Mecenate stava divenendo una delle vie più oneste di Milano, i giovani delinquenti che spingevano le ragazze sul marciapiede venivano individuati con molta facilità, una dozzina di essi andarono ad alloggiare in quello che il commissario chiamava il collegio dei furbi, cioè la galera, dove finivano tutti coloro che credevano furbescamente di poter vivere imbrogliando o ammazzando gli altri. La banda, è naturale, non venne sterminata, ma falcidiata sì: da una quarantina che erano, erano rimasti in undici. Questi undici sapevano, ormai l’avevano capito, che l’uomo che aiutava la polizia a distruggerli era Martino Allara, l’Elefante. E decisero di ucciderlo perché altrimenti sarebbero morti loro, se non altro di fame, perché non potevano muovere un dito che arrivava la polizia. Si trattava, dunque, di una caccia all’elefante, un safari all’elefante, e l’elefante era lui, Martino Allara. In un safari occorre un capocaccia. Il capocaccia era Ruggerino Molteni, che era capo della banda di via Mecenate, non tanto perché aveva ventitré anni, quanto perché aveva fatto il vaiolo, in Africa, era sopravvissuto, ma naturalmente aveva il viso tutto segnato e violaceo, e questa maschera impressionante, se gli impediva di partecipare ai colpi della banda, rendendolo troppo riconoscibile, non gli impediva di dirigere la banda, stando rintanato nel sotterraneo del suo caffè, dove continuava a giocare a biliardo con metà del cervello e con l’altra metà a organizzare qualche colpo. Fu lui che organizzò il safari. «State a sentire, stupidelli», disse una sera agli ultimi superstiti della banda che lo circondavano mentre lui tirava al biliardo un angolo di tre sponde, «o lo eliminiamo, o lui elimina noi...» Ma per organizzare un grande safari, ci vuole anche l’esca, e l’esca era una ragazzina di quattordici anni, di nome Liliana, ma detta anche Lilì, che lavorava nella fabbrica di minuterie metalliche della quale era vicedirettore amministrativo il ragioniere Martino Allara. Il capocaccia sapeva che l’animale da abbattere era molto pericoloso, non solo era alto quasi due metri e pesava quasi un quintale, ma era anche bene armato, sia di una rivoltella, sia di un coltello. Inoltre, come l’elefante, era molto furbo e intelligente. La scelta dell’esca era stata molto elaborata nelle sedute della banda intorno al biliardo, e infine avevano trovato la ragazzina Lilì. Se il ragioniere Martino Allara conosceva gusti e abitudini dei suoi ex compagni di banda, gli ex compagni di banda conoscevano gusti e abitudini sue. Ogni uomo ha la sua debolezza segreta, anche Achille aveva un tallone debole. Il capocaccia, e i più anziani ragazzi della banda conoscevano bene la debolezza dell’Elefante: le ragazzine. Lui amava la sua fidanzata, cercava di controllarsi, di vincersi, ma le ragazzine gli piacevano. Non aveva mai commesso niente di riprovevole, non aveva fatto nulla a nessuna ragazzina, ma le ragazzine gli piacevano lo stesso. Lilì era la più bella esca che si potesse pensare per l’Elefante. Aveva appena compiuto quattordici anni, ed era appena stata assunta alle Minuterie Metalliche Orselli. Era di famiglia onesta, ma onesta lei non lo era, un ragazzo della banda la conosceva da quando aveva dodici anni. Ed era molto carina, l’esca, anche col grembiulino nero, in fabbrica, davanti alla inscatolatrice dei fermagli per lettera, suscitava vivaci desideri nei compagni proletari, e apprezzamenti sostanziosi sulla di lei costituzione e bella apparenza. Era l’esca migliore che si potesse desiderare per la caccia all’Elefante. Appena l’Elefante ne avesse sentito l’odore, si sarebbe precipitato verso di lei. E nella trappola. Col suo viso vaioloso, il capocaccia Ruggerino Molteni si era curvato la sera prima sul foglio di carta che era sul tavolo pieno di appunti, e aveva scritto l’ora di inizio del safari: «Alle nove e dieci di domani sera». Alle nove e dieci della sera dopo il telefono suonò. La signora Elisa rispose: «Pronto?». «Per favore, vorrei parlare col ragioniere Allara», disse una limpida voce femminile. «Vado a vedere», disse la signora Elisa, brusca, perché in genere odiava le donne, soprattutto la loro voce. Andò a bussare alla camera che affittava al ragioniere Martino Allara, che le aprì subito. «Telefono», gli disse la signora Elisa. L’Elefante andò all’apparecchio. «Pronto?» «Pronto, ragionier Allara?» «Sono io.» «Scusi, ragioniere, se la disturbo, io sono Lilì.» Già lui l’aveva capito dalla voce. In quanto vicedirettore amministrativo delle Minuterie, era anche ispettore del personale e controllava le assunzioni. Aveva firmato lui il suo foglio di assunzione e l’aveva vista due o tre volte, attraversando lo stabilimento davanti alla inscatolatrice dei fermagli per lettera o delle puntine da disegno. E gli era molto piaciuta, non solo per la sua debolezza, ma perché lei faceva di tutto per piacere, a ogni uomo. «Mi dica», lui disse controllandosi, perché rivedeva i due lievi gonfiori sotto il grembiule nero della ragazza. «Scusi tanto, ragioniere, lei lo sa che ogni mercoledì ho il turno delle pulizie di questo reparto...» disse Lilì, flettendo la voce in modo che risultasse femminilità e infantilità. «Io ho fatto le pulizie, poi quando ho finito sono andata dal custode per farmi aprire, ma il custode non c’è e io non posso uscire.» «Come non c’è il custode?» disse lui, l’Elefante, un po’ arrabbiato, anche se era preso dalla calda, umorosa cantilena di quella voce. «Non c’è, signor ragioniere, la portineria è chiusa, l’ho cercato per tutto lo stabilimento, ma non c’è. Mia madre starà in pensiero a non vedermi tornare, sono le nove passate, sa come sono i vecchi, pensano sempre male. Io non posso uscire, il cancello è troppo alto, se no l’avrei scavalcato, ho pensato di telefonare a lei, mi scusi, sa, non è colpa mia...» È vero che l’avevano istruita e che il capocaccia le aveva insegnato frase per frase, curvandosi su di lei col suo viso vaioloso, però lei recitava benissimo: se l’avessero saputo, l’avrebbero presa alla televisione. Come vicedirettore amministrativo lui aveva le chiavi dell’ingresso principale dello stabilimento. «Va bene, vengo io», le disse. L’indomani si sarebbe informato meglio e se del caso avrebbe licenziato il custode, perché negli stabilimenti succedono le cose più inverosimili: che il custode notturno vada a bere all’osteria, per esempio, lasciando la fabbrica tutta sola; ma ora era urgente andare a liberare quella ragazzina che aveva lavorato fino alle nove e che adesso era rimasta imprigionata lì. Arrivò alle nove e venti, parcheggiò la Seicento nello spiazzo riservato alle auto dei dirigenti, uscì dalla macchina abilmente, ma con un certo sforzo, data la sua mole, e lui stesso era il primo a ridere di sé ogni volta che entrava o scendeva dalla Seicento. Chiusa a chiave l’auto, aprì il cancello che dava negli uffici, con in mente i due gonfiori che Lilì mostrava sotto il grembiule, ma mentre percorreva il lungo corridoio che portava al reparto macchina, corridoio illuminato squallidamente dalle due sole lampadine di emergenza, alzando il capo casualmente vide pendere dal muro, in alto vicino al soffitto, un filo elettrico tagliato. L’elefante è un animale attento, osservatore, e diffidente. Si fermò. Non occorreva essere un tecnico elettricista per capire che quel filo piatto, per il suo colore rosso, era il filo che dall’ufficio cassa, dove era la cassaforte, portava a tre potenti suonerie disposte in tre punti strategici dello stabilimento. Allora l’Elefante si fermò, era stato richiamato dall’esca così giovane e tenera, ma cominciava a sentire un odore insolito, odore di cacciatori, forse. E non solo si fermò, ma si appoggiò subito con le spalle al muro, levò subito la rivoltella dalla fondina, tolse la sicura e la tenne nella destra, mentre con la sinistra prendeva il lungo coltello che portava nella tasca interna della giacca, premeva il piccolo scorrevole e la lunga lama saltò fuori, temibile più di un rasoio o della stessa rivoltella: uno squarcio nella carne di quel coltello era assai più disastroso di un proiettile. E così appoggiato al muro e ben armato, guardando attento da ogni parte del corridoio, cominciò a pensare. Era un uomo riflessivo, meditativo, come l’elefante. E doveva riflettere a molte cose. La prima era di natura finemente tecnica: il sistema delle suonerie d’allarme negli stabilimenti era congegnato in modo che se i ladri tagliavano il filo per impedire che la batteria suonasse, un apposito congegno faceva sì che tagliando il filo la suoneria suonasse ugualmente, e subito. Era evidente che la batteria non aveva suonato, se no anche dalla strada se ne sarebbero accorti. Quindi, uno specialista aveva neutralizzato anche il congegno di sicurezza, e questo specialista non poteva essere che Robertuccio, un sedicenne, figlio di un onestissimo elettricista della zona, che degli onesti insegnamenti professionali del padre aveva studiato solo l’arte di ridurre all’impotenza i più complicati sistemi di allarme elettrici. Ma, se c’era Robertuccio, voleva dire che c’era tutta la banda del vaioloso Ruggerino Molteni. Il vaioloso aveva dunque pensato di svaligiare la cassaforte delle Minuterie Metalliche Orselli, impresa non difficile, ma non tanto redditizia, avrebbero trovato al massimo un milione, e qualche centinaio di migliaia di lire in marche da bollo e assicurative, lui lo sapeva. La seconda riflessione fu Lilì. Che c’entrava Lilì? Poteva essere solo una coincidenza, pensò, mentre continuava a guardare da una parte e dall’altra del lungo corridoio così squallidamente illuminato: per coincidenza, proprio la sera in cui quei cretini e farabutti della banda di via Mecenate avevano deciso di farsi la cassaforte delle Minuterie, l’ignara Lilì si trovava a fare le pulizie del suo reparto, e magari i ragazzi della banda l’avevano presa in ostaggio o anche uccisa per non essere riconosciuti, come poteva darsi che avessero ucciso il guardiano, non ci mettevano mica molto. Ma l’elefante non crede alle coincidenze, è un animale razionale che sa che tutto ciò che avviene ha una causa precisa. Se Lilì era lì quella sera, doveva esserci una causa precisa. Se gli aveva telefonato che non c’era il custode e di venire ad aprirle il cancello, doveva esserci una causa precisa. La causa avrebbe potuto essere che Lilì, falsa ingenua, era d’accordo con loro. Ma perché la banda lo avrebbe attirato lì in fabbrica mentre stava facendo il colpo alla cassaforte? La banda aveva tutto l’interesse che non vi fosse nessuno, e non a far arrivare gente, specialmente lui, il suo nemico numero 1. E allora l’Elefante capì, e capì di essere caduto in trappola. Per un momento il ragioniere Martino Allara apprezzò perfino la genialità del piano del vaioloso. Il primo scopo era quello di farlo fuori e avevano scelto come luogo le Minuterie, per loro particolari ragioni, che non capiva. Ma, dato che andavano alle Minuterie, perché non svuotare anche la cassaforte, unendo così l’utile di qualche milione al dilettevole di massacrarlo? Lilì era stata l’esca, conoscevano il suo debole per le giovanissime, sapevano che una ragazza di quattordici anni sarebbe riuscita a farlo venire fin lì in trappola. Infine, la terza riflessione fu che era certamente circondato da una mezza dozzina di quei farabutti della banda. Non sapeva dove fossero, ma sentiva che erano intorno a lui, che lo spiavano. Sapeva che non avrebbero sparato, meglio non fare chiasso, aspettavano solo il momento di aggredirlo. Infine pensò che cosa dovesse fare. Era molto semplice. Prima di tutto non muoversi di lì, dove stava con le spalle al muro, e poi sparare, fuori, verso la strada, attraverso le grosse vetriate del corridoio. Qualcuno avrebbe udito i colpi, si sarebbe radunata gente, lui avrebbe urlato, e i farabutti avrebbero dovuto fuggire. E stava per sparare quando sentì la voce di Lilì, a destra del corridoio: «Ragioniere, ragioniere, è lei, ragioniere?». E dal fondo del corridoio apparve, nella luce da mortorio, Lilì, libera dal grembiule nero, perché aveva finito di lavorare, vestita di un abitino giallo da cui trasparivano, ancora meglio, i due teneri gonfiori. «Sono io, vieni qui», le disse, e nello stesso tempo capì di essere un ingenuo, di avere addentato l’esca, perché da sinistra, mentre lui si distraeva parlando con Lilì verso destra, arrivò uno dei farabutti, con un tubo di piombo che sollevò con tutte e due le mani e glielo dette sul capo con tutta la sua forza. L’Elefante vide con la coda dell’occhio il cacciatore che vibrava il colpo, ma non fece in tempo a pararlo. E svenne. Riprese i sensi qualche minuto dopo, ma era già, non solo disarmato, ma anche con le mani e i piedi legati, e anche nudo. Due dei farabutti della banda lo tenevano in piedi. Guardò dove si trovava: era nel reparto presse dello stabilimento, malamente illuminato dalle luci di emergenza, vicino a una delle presse più grandi, la Davidson, che stampava quattro fogli di metallo speciale, trasformandoli con un colpo solo in quarantamila puntine di disegno. Lo sapeva perché l’aveva fatta acquistare lui. Poi, ancora mezzo intontito, guardò davanti, e vide il viso del vaioloso. E riuscì a udire anche la sua voce. «Tu sei una spia e io ti farò morire da spia, così anche gli altri che fossero tentati di fare la spia come te, avranno un esempio di come finiscono le spie. Questa è una pressa, la più pesante dello stabilimento. Diventerai una sogliola, brutto grassone.» Allora l’Elefante capì perché lo avevano attirato proprio lì, alle Minuterie. L’elefante è un animale curioso e vuol capire tutto, anche se sta per morire. Ma volle rispondere al vaioloso che aveva ideato un safari così geniale: gli sputò in faccia. «Brutta spia, mettetelo sotto», disse il capo cacciatore, asciugandosi la faccia. «No, no, questo non lo fate!» urlò da un angolo del reparto la voce di Lilì, «ammazzatelo, ma non così!» Si sentì un gemito, e Lilì colpita da un pugno in piena bocca smise di parlare. «Mettetelo sotto la pressa», disse il capocaccia. I due farabutti lo misero sotto la pressa, l’Elefante sentì il freddo oleoso del metallo sulla pancia e pensò ad Assunta. Povera, povera Assunta, quando avrebbe saputo la notizia della sua fine. Sarebbe impazzita, ne era sicuro. «Robertuccio, tu che te ne intendi, metti in moto la pressa», disse il vaioloso. Robertuccio era l’elettrotecnico, ed era un robusto delinquente, ma vi sono cose che neppure un delinquente può sopportare. Massacrare così a freddo un uomo fece orrore anche a lui. «Sì», disse, perché al vaioloso nessuno osava dire di no, schiacciò il bottone rosso, ma non successe niente, e lui lo sapeva benissimo che non sarebbe successo niente: perché la pressa si mettesse in moto, prima del bottone rosso di avviamento bisognava schiacciare il bottone verde di sblocco, e quello celeste che metteva in moto la spatola girevole per cui l’operaio non poteva stare vicino alla pressa quando cadeva. «Cosa c’è?» disse il vaioloso. «Fa’ vedere a me perché non funziona. Qui ci sono tre bottoni.» Schiacciò quello verde, così, a caso, ed era quello giusto: quattro lampadine celesti si accesero. «Capisco», disse, «prima di schiacciare il bottone rosso di avviamento bisogna mettere in moto il congegno antinfortunio.» L’uomo sotto la pressa sapeva che quello era il ragionamento giusto e sentì che il vaioloso aveva schiacciato anche il bottone celeste: così la spatola cominciò a fuoruscire dalla parte bassa della pressa per tener lontano l’operaio dalla pericolosa macchina. Adesso bastava schiacciare il bottone rosso ed era finito. «State buoni dove siete: polizia», l’Elefante udì gridare, però, e udì anche la raffica di mitra sparata in aria, per convincere i farabutti a ubbidire. Pur essendo gravemente ferito al capo, il custode delle Minuterie Metalliche ha potuto trascinarsi al telefono e avvisare la polizia, che è riuscita così a evitare per un soffio l’orrendo massacro che la banda stava per commettere... Il ragionier Martino Allara è partito per Napoli, per andare dalla sua fidanzata (dai giornali). 12 · Non ti spaventare Dormivano, quietamente, lievemente, accucciati come bambini uno dietro l’altro, nel tic tic tac della sveglia, la luce del lampione che passava a righe attraverso la persiana, e non udirono il primo richiamo del telefono in anticamera; solo lei mosse un poco un braccio per stringere meglio lui, come a proteggersi, ma, al secondo, lui aprì gli occhi, ancora incosciente, e al terzo capì. «Il telefono», mormorò, automaticamente si alzò, infilò le pantofole, anche lei aprì gli occhi, lo fissò, lui le fece una carezza: «Dormi, dormi, sarà uno sbaglio». Non era uno sbaglio: appena sollevò il ricevitore rispose alto, clamoroso, minaccioso, il silenzio. «Pronto, pronto», lui disse, la gola arida, e gli rispondeva solo l’altisonante silenzio. «Pronto, pronto.» Poi depose il ricevitore, quasi con ribrezzo, tornò in camera e sedette sul letto vicino a lei. Lei faticava ad aprire gli occhi. «Chi era?» chiese. Lui non rispose e lei fu subito sveglia. «Chi era?» ripeté angosciata, ma non poté finire, il telefono squillò di nuovo. «Non ti spaventare», lui disse, spaventato. Si alzò, andò di nuovo a rispondere, e gli rispose di nuovo il niente, il vuoto, ma così denso e compatto come fosse piombo. Allora andò in cucina, e prese la bottiglia del cognac, tornò in camera da lei, passando davanti al telefono che suonava di nuovo, ma lui non avrebbe risposto più. «Non aver paura», disse, atterrito. «Ma non può essere lei...» lei disse, distrutta dalla paura. Lui bevve dalla bottiglia un poco di cognac: no, non poteva essere lei, la moglie, che fino a due anni prima li aveva tormentati quasi ogni giorno e ogni notte telefonando in quel modo, non poteva essere lei perché era morta da un anno e da un anno loro vivevano in pace. «Non so chi può essere», disse, «i morti non telefonano.» 13 · Il ricatto Il ricatto continuava da quasi un mese, il campione di aritmetica, storia, geografia, italiano girellava per il cortile nelle liquefacenti ore di caldo del primo pomeriggio quando sapeva che lei, sonnolenta, irosa e sudata doveva fare quegli astrusi compiti che le davano a scuola. Ogni tanto si avvicinava alla finestra della sua stanzetta che dava nel cortile, senza neppure guardarla, solo per farsi vedere, in calzoni lunghi, ma il viso di bambino coi capelli biondi ispidi e opachi, da duro, mica da biondino, sapendo che lei lo vedeva, anche se fingeva di non guardarlo, e ripensava al suo ricatto: se vuoi che ti faccia il compito devi darmi un bacio, se no ti arrangi, e da un mese lei resisteva, andando a scuola col compito tutto sbagliato. Ma quel pomeriggio era forse troppo caldo, sulla copertina della rivista che aveva sul tavolo c’erano due che si baciavano, un film in cinemascope, chi sa se avrebbe potuto vederlo, e sul quaderno c’era quel formicaio di numeri, quanto facevano i due quinti di trentacinque più i tre noni di trentasei, e lei non resisteva più. «Angelino...» Lo chiamò dalla sua stanza, sommessa. Ma quello sentì benissimo, anche se era dall’altra parte dell’assolato, bollente, deserto cortile, si avvicinò, scavalcò la finestra, guardandosi intorno e fu nella sua stanza, e lei mostrò il compito, ma lui scosse il capo: «Niente per niente», disse duro. Lei chiuse gli occhi e attese il bacio. Lo sapeva benissimo quanto facevano i due quinti di trentacinque, più i tre noni di trentasei, esattamente ventisei, proprio quella volta c’era riuscita e non aveva bisogno di cedere al ricatto, ma voleva un bacio, grande grande, cinemascope, come quello della copertina della rivista. 14 · Non si sarebbe sentito Pioveva. Nella saletta verde della tabaccheria si sentiva piovere da ore perché ai tre tavoli c’erano solo vecchi che giocavano a carte, in silenzio quasi sempre. Qualche scoppio di voce appena ogni tanto, e poi si sentiva di nuovo la pioggia allagare la strada. Era tardi. Il padrone si stava facendo una camomilla prima di chiudere. A parte quelli che giocavano, c’era una sola cliente nella saletta verde. Stravaccata su quella sedia, a fumare. Veniva immancabilmente a quell’ora per lei morta. Si fumava una o due sigarette, guardando i vecchi. O magari non li guardava neppure. Teneva gli occhi dalla loro parte, e basta, aspettando di raccogliere le forze, alzarsi. Sotto la pioggia arrivò la camionetta della polizia. Tre militi irruppero nel locale. Il padrone continuò a trafficare alla sua camomilla. «Tutto tranquillo...» disse. «Chi le ha chiesto un parere?...» disse il maresciallo. Tutto tranquillo. Tutto in ordine. Il maresciallo dette ancora un’occhiata ai vecchi che giocavano a tressette la solita bottiglia di vino. Alla peripatetica bolsa che si riparava lì dalla pioggia non aveva bisogno di controllare i documenti. La conosceva a memoria, come una poesia. Meglio d’una poesia, anzi. Perché, le poesie studiate a scuola, se l’era dimenticate. Tutto in ordine. Una volta, sino a pochi mesi avanti, quello era stato un locale malfamato. Ma erano riusciti finalmente a ripulirlo dalla giovane teppaglia. Tutto in ordine. Il maresciallo era soddisfatto. Concesse addirittura un minimo di confidenza al padrone. «Sogni d’oro...» disse. I militi uscirono. La lotta era stata lunga, ma la banda di ragazzotti e ragazzotte era stata costretta a scegliersi un’altra tana. La camionetta si riavviò. Il padrone cominciò a sorseggiare la sua camomilla. Si sentiva di nuovo la pioggia. La strada doveva proprio essere allagata. Da quanti giorni e quante notti pioveva a Milano? «Che mortorio...» disse la bolsa poesia al padrone. Il padrone assentì. Finiva la camomilla a piccoli sorsi. In fondo, non gli piaceva, non gli conciliava affatto il sonno, e per di più aveva il sospetto che gli procurasse acidità di stomaco. Quando c’erano quei mascalzoni, le urlate dei pokeristi e delle puttanelle minorenni, il rombo del juke box, le liti e le follie dei delinquenti precoci non permettevano mai che si sentisse piovere. Non si sarebbe sentito sparare, con loro lì. 15 · La prova indiziaria L’importante era di sapere se anche quel mercoledì Lolita fosse nella cuccia in cucina tra il frigorifero e la cucina a gas. Mentre attendeva il tram alla fermata vicino all’ufficio, sperò di no e in tram immaginò di vedere Lolita che gli si arrampicava sui calzoni, appena entrato in casa, e gli leccava la mano, sarebbe stato tanto felice se fosse avvenuto così. Scese dal tram, andò all’edicola a comprare il romanzo giallo che gli serviva per addormentarsi vicino alla moglie così bella ma così fredda, da tanti mesi, soprattutto il mercoledì, salutò il portinaio: «Buona sera, signor Alessandro». Arrivò con l’ascensore al quarto piano, lei gli aprì la porta, e Lolita non c’era, ed era mercoledì. Lui andò subito in cucina, e Lolita era lì, rintanata nella sua cuccia. «Buona sera, Lolita», le disse. Ma Lolita, la cocker biondissima e nevrastenica, non venne fuori, neppure col muso. «Su, bella, perché non vieni fuori?» una domanda che faceva, più che alla cagna, a quel freddo corpo, freddo per lui, rivestito di rosso, che era sua moglie. «Sono stati qui gli operai ad accomodare lo scarico del bagno, ed è corsa a nascondersi e non ha più voluto uscire...» disse con tono falso il freddo corpo vestito di rosso. Lolita era malata di nervi. Perché non c’era la psicanalisi per i cani? Appena entrava in casa qualche estraneo, scappava nella sua cuccia e non ne usciva più per tutto il giorno. E ogni mercoledì, da un paio di mesi, Lolita stava rintanata nella cuccia. Sua moglie riceveva qualcuno, il mercoledì, ne era certo, ma poteva dirglielo? Lolita atterrita nella cuccia rappresentava solo una prova indiziaria. No, non poteva dirglielo. Aprì il cassetto del tavolo di cucina. Guardò il lungo coltello lì in fondo. Ne toccò il manico quasi con dolcezza. 16 · Scuola serale Il primo incontro avvenne così: lui stava seduto su una panchina, al Parco, ai bordi della Triennale, erano le dieci di una fredda sera di maggio, molti si erano rimessi i soprabiti o i pullover, a sinistra si vedevano le luci del piazzale della Stazione Nord, la sua panchina era in ombra, il più vicino fanale era a oltre dieci metri, schermato dalle grandi foglie di un alberone. Forse piovigginava, o stava per piovere, anche se era presto nel viale non passava nessuno, solo qualche auto. Non c’erano angoli adatti per le coppie, ed era troppo vicino alle vie intorno alla stazione, anche le passeggiatrici lavoravano nei viali più interni. Lui aveva caldo, con quel maglione nero sui calzoni di velluto celeste a coste, e per tutta la camminata fatta da casa. Aveva caldo, era senza un soldo, ed era furibondo. Era venuto fin lì perché aveva pensato che in posti come la Stazione Nord c’è sempre qualche frescone o qualche frescona da spremere, in un modo o nell’altro, e aveva fatto un giretto nell’interno, era entrato anche nel bar ristorante, ma in tre minuti che aveva impiegato in questo giretto aveva odorato tre poliziotti e allora era subito venuto fuori. Rubare un’auto era la cosa che stava studiando, perché gli era venuta un’idea. Si accese una sigaretta. Dunque: si prende un’auto, la più vistosa che si trova, che faccia impressione, e si va per i viali del Parco della bella Milano, lentamente. Allora dal buio sotto gli alberi escono le minorenni e lui si ferma. La minorenne sale, lui va avanti ancora un poco, cerca il posto più buio, poi, senza preavviso, l’addormenta con un pugno, le prende tutto quello che ha nella borsetta, e la lascia lì, addormentata, nella macchina rubata. Gli inconvenienti di questo piano che stava meditando erano due. Il primo che non aveva gli attrezzi per forzare la portiera di un’auto, e che avrebbe dovuto girare a cercare una macchina non chiusa, o coi finestrini aperti, cosa difficile. L’altro inconveniente era che le passeggiatrici hanno degli amici ai quali consegnano i loro proventi volta per volta e così quelle nella borsetta non hanno quasi mai niente. Non tutte possono o pensano di fare così, ma molte sì, e stava tormentandosi su questo piano, pensando a quante probabilità aveva di fruttare, e ricordandosi, con amara ironia, del proverbio che aveva sentito spesso dire da sua zia Angelina, romana: «Guardalo bene, guardalo tutto: l’omo senza sordi quant’è brutto», e si sentiva veramente brutto con quelle sole duecento lire che gli ballavano nella tasca dei calzoni celeste. E mentre così si tormentava un piccolo uomo uscì dall’ombra dell’alberone vicino e venne come svagato verso di lui e si fermò davanti a lui, fissandolo un momento in silenzio, un solo momento, ma lui s’irritò: quello era proprio il genere di lavoro che non avrebbe mai fatto; aveva alcuni compagni che lo facevano, ma lui non li frequentava, anche in quell’ombra semipiovigginosa si vedeva che l’uomo era vecchio, distinto ma vecchio, piccolo e tarchiato, ma vecchio. Li odiava, quegli odiosi vecchi. «Vattene via, hai sbagliato portone», gli disse, contenendosi, se no l’avrebbe preso a calci. «Volevo solo sapere», disse il vecchio, ma la sua voce era assai meno vecchia, «se volevi guadagnare mezzo milione, ma non come pensi tu.» «E come?» «Questo te lo spiegherò poi. Questo è un acconto.» Levò la sinistra dalla tasca dell’impermeabile nero, corto, liscio come una vestaglia da magazziniere del Gondrand e gli tese un biglietto da dieci. «Prendi, non aver paura, anche se non ci accordiamo resta tuo...» Lui lo prese, il vecchio sedette sulla panchina in un modo strano, di sbieco, in modo da stare tutto di fronte a lui. «Come ti chiami?» «Cosa sei, dell’anagrafe?» lui gli disse nervoso, non credeva alla gente che va in giro a regalare mezzi milioni, sentiva puzzo di bidonata da morire ed era pronto a tirare calci come un mulo. «Scusa, caro, ma per avere mezzo milione bisogna dare almeno i propri dati», disse il vecchio. Adesso piovigginava davvero, ma sotto le foglie dell’alberone si resisteva bene. Era certamente un bidone, ma era curioso di sapere che genere di bidone fosse, e rispose tranquillo, il foglietto da diecimila già chiuso nel taschino con la lampo e nemmeno il campione del mondo dei pesi massimi glielo avrebbe levato più. «Mi chiamo Carlo Datti.» «Quanti anni hai?» «Diciannove.» «Dove abiti?» «In via Marostica 70.» «Dove si trova via Marostica?» «Dietro via Washington, dopo piazzale Piemonte.» «Non lavori, vero?» «Cerco di evitare.» «Ti hanno mai messo dentro?» Il vecchio sedette ancora più di sbieco. «Sei stato al riformatorio?» Lui si seccò. «Sono affaracci miei.» «Mezzo milione è mezzo milione, e io voglio sapere chi sei. Se non ti va, fa niente. Dillo, e vattene col dieci. Ne trovo quanti ne voglio, anche meglio di te.» Più che altro era curioso. Non credeva al mezzo milione, non era così stupido, ma voleva vedere dove finiva il corridoio. «Al riformatorio no, sono riuscito a evitarlo, ma ogni tanto mi prendono e mi tengono in frigo in questura un paio di giorni, mi danno un poco di schiaffoni, poi mi buttano fuori.» «Perché ogni tanto ti prendono?» «Per niente. Gioco a boccette nel caffè, loro arrivano e caricano me e un’altra mezza dozzina di ragazze e ragazzi sul furgone. Lì, nel mio quartiere, succedono sempre un sacco di furti e la polizia dà la colpa a noi che giochiamo a boccette. Poi ci sono quelli che fanno lavorare le ragazze, loro non sanno chi sono, e allora prendono tutti, anche quelli che non c’entrano per niente.» «Tu non fai lavorare nessuna ragazza?» «No, io con le donne non ho pazienza. Loro sono matte e io sono nervoso; non ho neanche la ragazza.» Cominciava a scaldarsi e col dieci nel taschino dei calzoni si sentiva un po’ eccitato e in quell’umida frescura riprese il suo antico sogno di ragazzo. «A me, se pagassero bene, mi piacerebbe fare il milite della stradale, su un’Harley Davidson, quelle motociclette fanno anche trecento chilometri all’ora, e se ci fossi io sull’autostrada del Sole su una di quelle robe, ti assicuro che anche le Cadillac tutte d’oro abbasserebbero la coda e seguirebbero il codice della strada come scolaretti.» «Perché, tu le sai guidare?» «Ho degli amici fortunati che le hanno, e me le hanno lasciate provare.» Il dieci nel taschino lo rendeva euforico. «So più stare a cavallo di una Guzzi che andare a piedi.» «Hai fatto bene a dirmelo, può essere utile», disse il vecchio. Guardò passare, sotto un ombrellino giallo, una minorenne che si avvicinò ancheggiando, poi li vide bene e disse, subito scostandosi da loro: «Che schifo». «Va’ dall’ottico», le disse lui, «dovevi vederci prima.» «Lascia perdere», disse il vecchio a lui. «Hai i genitori?» «Sì.» «Padre e madre, e vivi con loro?» «Padre e madre e vivo con loro.» Cominciava a divertirsi con questo vecchio bidonista che gli faceva le stesse domande che gli facevano al commissariato, tra una ceffata e l’altra. «Allora senti. Io adesso controllerò se quello che mi hai detto è vero, i giovani hanno sempre molta fantasia», la voce del vecchio era così giovane che lui cominciò a impressionarsi. «Ci possiamo rivedere dopodomani, qui, a questa stessa ora, nel caso ti interessasse il mezzo milione, e un altro dieci di mancia. Se non t’interessa non venire, non mi offendo.» Lui scosse il capo e disse: «Che buffonata è?» «Cerca di capire che è una cosa seria.» «E come faccio a capirlo?» «Hai mai visto qualcuno che scala i dieci così, come ho fatto io? Se uno lo fa è perché è una cosa seria.» Sentì sincerità nella voce del vecchio, e oltre alla sincerità sentì la forza logica del ragionamento. Prima di dare diecimila lire la gente pretende dieci ore di lavoro. Quello niente. Capì che, anche se era una bidonata, era una bidonata di nuovo genere, e il nuovo gli piaceva sempre. «Che cosa devo fare?» disse, interessato, in fondo era un ragazzo. «Per il momento andartene a casa», disse il vecchio. «Prima però devo darti qualche consiglio. Il più importante è di non parlare con nessuno che mi hai incontrato e di quello che abbiamo detto, e poi di non lasciarti prendere da tentazioni. Magari, dopodomani sera tu arrivi qui, con tre o quattro amici, mi date un sacco di botte e mi portate via il portafoglio, l’orologio, l’anello, il fermacravatte d’oro, e poi scappate. Cerca di capire che non ti conviene, io sono vecchio e piccolo, ma ho dei giovani amici, sono qui intorno anche questa sera, è inutile che guardi perché non li scoprirai. Ma appena qualcuno mi tocca, saltano fuori. Vai a casa e pensaci su, senza dire niente a nessuno e senza fare scherzi. Se hai voglia, dopodomani sera vieni qui, alla stessa ora, ti do un altro dieci e parliamo un poco. Niente altro. Se non ti va, resti a casa e non ci vediamo più. Senza rancore, non farti scrupolo. Solo, ricordati che è una cosa seria. E adesso va’ dalla parte che preferisci, ma va’...» Lui, Carlo Datti, si alzò: aveva diciannove anni, era spavaldo e cercò di dimostrare che non aveva paura, attraversando la strada e andando verso la Stazione Nord, ma aveva paura. Questa fu come l’iscrizione al corso rapido, con la prolusione del preside che spiega agli allievi le finalità dello studio intrapreso. In fondo il vecchio aveva un po’ l’aria del preside. Lui doveva decidere se iscriversi o no. Decise di iscriversi. E andò all’appuntamento, pioveva esattamente come due sere prima lievemente e scocciantemente. Lui si era messo i calzoni neri, il maglione nero, e sopra l’impermeabilino corto corto, bianco. Non c’era nessuno in quel viale di fianco alla stazione, sembrava un paesaggio lunare, ma dopo aver fumato una sigaretta vide dalla svolta che dava nell’interno del Parco apparire il vecchio che gli sedette accanto sulla panchina. Fu così che cominciò la prima lezione. Il vecchio disse: «Sei stato abbastanza sincero: mi hai nascosto soltanto che hai una sorella di sedici anni che è stata fermata quattro volte dalla squadra del buon costume». «Non posso andare a dirlo in giro con la chitarra elettrica...» lui protestò duro. «Lo diresti in giro tu, se avessi una sorella così?» «Non arrabbiarti», disse bonario il vecchio, «te l’ho detto solo per dimostrarti che m’informo e che è inutile tentare di raccontarmi storie. Così, l’altra sera, quando ti ho chiesto se non avevi una ragazza fissa tu mi hai risposto che non avevi nulla di fisso. Invece tu hai una ragazza fissa. Vuoi che ti dica il nome o ti fidi della mia affermazione?» Lui era un ragazzo coraggioso, e qualche cosa di più: era spavaldo. Ma il vecchio e la sua voce giovane, e quelle parole, lo fecero sudare alla nuca, un sudore gelato, sotto quella pioggia. Non era un bidone, era una cosa seria. «Dimmi come si chiama la mia ragazza fissa», disse tirando il fiato. Non si fidava di nessuno. «È una giovanissima vedova meridionale di diciotto anni, il marito di ventidue glielo hanno fatto fuori alcuni suoi compaesani per questioni che non ho avuto voglia di approfondire, insomma si arrangino tra di loro. È una bellissima donna, l’ho vista e ti capisco, si chiama...» «Il nome lo so da me, va’ avanti», lo tranciò, per impedirgli di proseguire, colando sudore alla nuca. «Sei un ragazzo onesto», gli disse il vecchio, «mi hai nascosto solo le cose che ti faceva dolore dire.» Dalla tasca sinistra prese il biglietto da dieci e glielo dette. «Noi combineremo o no, questo non ha importanza, comunque questo è per te, e anche se adesso ti alzi e te ne vai via coi soldi, io non mi offendo. Se vuoi, alzati e va’ pure, i miei amici qui intorno non ti faranno niente. Loro arrivano soltanto quando c’è un traditore, ma se c’è uno che si scioglie dal contratto senza tradire, dico senza tradire, ti lasciano andare e sei sempre libero di scioglierti, quando vuoi. Se non ti va, torna a casa.» Lui si guardò intorno, nell’umidiccio, piovigginoso universo che lo circondava. Non c’era proprio nessuno, eppure sentiva che non erano soli, erano a trecento metri dalla Stazione Nord ma sembrava di essere nella giungla colante umido, con belve dagli occhi fosforescenti, in agguato nel buio intorno, e serpenti che strisciavano verso di lui. «Mi va», disse. «Cosa devo fare?» «Questo te lo spiegherò un’altra volta», disse il vecchio. «Adesso ho bisogno di altre informazioni su di te. Che scuole hai fatto?» «Non crederai che vado all’università. Ho fatto solo le elementari.» «Hai la patente per l’auto?» «Sì. Ma vado meglio in moto.» «L’hai qui?» «Sì.» «Fammela vedere.» Il vecchio guardò la patente, gliela restituì. «Bene. Adesso ascolta: mettiti in mente di parlare come al confessore. Rispondi con sincerità: bevi?» «Mi piace la birra, quella scura forte, la Guinness.» «E liquori forti?» «Molto di rado. Li bevo solo quando gli amici insistono, per non offenderli, mi bruciano in gola.» «Droghe o droghette?» «Senti, io sono stupido, perché uno sempre senza una lira è stupido, ma non fino a quel punto.» «Bravo, e a sport come vai?» «Ho giocato a pallone fino a quattordici anni, poi mi è presa la passione della moto.» «La corsa, volevo sapere. Voglio dire: se devi correre per due, tre, quattro chilometri, tieni il fiato?» «Non mi piace correre a piedi, ma penso di sì.» Con tutte quelle domande lui cominciò a pensare che il vecchio fosse matto. Non si trattava di un bidone, si trattava di pazzia. «Ecco, adesso vai a casa, ci rivediamo dopodomani sera», disse il vecchio. «Domattina però va’ a comprare un libro. È un romanzo giallo. Ricordati il titolo: Ogni volta che ti sparo. Vai in centro, ci sono tante librerie. Leggilo tutto e bene prima di venire da me, perché dopodomani sera ne parliamo.» Era il compito a casa. A lui quel titolo non piacque, Ogni volta che ti sparo, non gli piaceva per niente la parola «sparo», non gli piaceva per niente la pazzia, ma pensò che se riusciva a beccarsi per altre due o tre volte un dieci andava bene. Il giorno dopo comprò il libro, lo lesse e la sera dell’indomani si ritrovò sulla panchina del Parco. Il vecchio era già lì. «L’ho letto», gli disse lui, mostrandogli il libro. Il vecchio tirò fuori il dieci e glielo dette. «Bravo. Tu non hai mai maneggiato una pistola, vero?» «Mai.» «Ti sarebbe piaciuto?» Esitò a rispondere perché adesso aveva capito che non era né un bidone, né pazzia, era una cosa seria. «Non molto.» «Paura?» Il tono del vecchio era una lama di rasoio. Lui, era sempre un ragazzo, sussultò come se gli avessero sputato in faccia. «Se credi che abbia paura, perché non vai a parlare con dei coraggiosi, invece che con me?» «Perché so che non hai paura», disse il vecchio. «Adesso, forse, dopo aver letto quel libro saprai qualche cosa sulle pistole. Ci sono, poco dopo il principio del romanzo, una quindicina di pagine dedicate alla descrizione e al funzionamento di una Smith & Wesson. Ti farò alcune domande: che calibro ha quella Smith & Wesson?» «Si carica con cinque 38 speciali», gli disse lui dopo aver riflettuto un momento. «Bravo. Quanto è lunga la canna?» Gli ci volle quasi un minuto, poi disse: «Cinque centimetri». «Questo che cosa vuol dire?» «Che è una pistola molto piccola, per niente ingombrante.» «E cioè?» Era proprio come a scuola. «Cioè, ecco», disse lui riflettendo, «si può portare indosso benissimo, senza che nessuno la noti.» «Bravo. E qual è il suo difetto?» Non voleva rispondere sbagliato. Ci pensò su e infine ricordò: «L’impugnatura. Una pistola così piccola ha l’impugnatura piccola. E l’impugnatura piccola ha l’inconveniente che non si riesce a tenerla bene in mano». «C’è un modo di ovviare a questo inconveniente?» domandò il maestro. «Sì», disse l’allievo. «Si aggiunge un supporto di legno al calcio, così lo si può impugnare più fermamente.» «Molto bene. Ci sono delle scanalature in questo supporto di legno perché le dita vi aderiscano dentro?» «No, non ci sono.» «Perché?» «Perché si perde più tempo a trovare queste scanalature e a mettervi dentro le dita. Per uno che deve sparare subito, le scanalature sono un difetto.» Si asciugò il sudore alla nuca. Chi sa perché sudava solo alla nuca. «Hai letto con molta attenzione. Grazie. Adesso devo darti due notizie», disse il vecchio. «La prima è che avrai una moto, oltre il mezzo milione, è una Gilera bicilindrica 300, extra, non è nuova, ma corre bene, e se la sai guidare può acchiappare una Ferrari.» «La 300?» lui disse, sentì sotto di sé il duro maschio sellino della moto. Ingoiò come uno che ha fame e gli dicono che stanno preparandogli un pollo arrosto. «La Gilera e il mezzo milione», disse il vecchio, «e anche tutto il costume, la tuta, la fascia renale, il casco, gli occhiali, i guanti, e buoni per cinquecento litri di benzina.» Lui ingoiò ancora. «Che cosa devo fare?» «Te lo dirò dopodomani sera. Adesso sta’ a sentire: domattina comprati una rivoltella ad acqua, in qualche negozio di giocattoli ce ne devono essere ancora, se no pigliati una di quelle che sparano puntine di plastica, prendi un foglio di carta con un punto rosso, attaccalo al muro e spara da vicino, dico un metro, al massimo due, cercando di far centro sul punto rosso.» «Ma da un metro faccio centro per forza», disse lui. «Questo è un errore, e non dovevi commetterlo», disse severo il maestro. «Uno che non ha mai sparato può sbagliare anche da venti centimetri.» Forse aveva ragione. «Ah, ecco, dimenticavo la seconda cosa da dirti. Dopodomani sera, se verrai qui, ti darò il mezzo milione. Io pago tutto anticipato, ancora prima che tu abbia fatto il lavoro che occorre.» Lui non resisté più. «Ma che lavoro è?» «Di preciso te lo dirò dopodomani sera», disse pacato il vecchio, «ma capisco che tu voglia sapere un poco di più, e ti dirò qualche cosa in linea generale.» Il vecchio sedette ancora più di sbieco, in modo da stargli proprio di fronte, come faceva sempre, stranamente. «Ci sono alcuni mariti ai quali non va più la loro moglie, ma non possono ottenere né divorzio, né annullamento. Poi ci sono mogli alle quali non va più il marito perché ne hanno un altro meglio. Poi ci sono dei piccoli ai quali sono antipatici gli alti, dei bianchi che non sopportano i negri, degli altri che non sopportano gli ebrei, e tutta questa gente vuole chiudere la questione per sempre. Forse tu capisci cosa vuol dire “per sempre”. Mettiamo che mentre tu sei qui a parlare con me uno vada a casa dalla tua giovanissima vedova e ne abusi. Conosci il significato della parola “abusare” o te lo devo dire in un altro modo?» «Piantala.» «Mi spiace, ma devo continuare. Questo, insomma, va a casa della tua ragazza, ne abusa, e con la violenza, e tu vieni a sapere chi è. Cosa fai?» «Vado ad accopparlo.» «Giusto. Ma se tu fossi malato, debole, senza forza, senza armi, non potresti accopparlo, avresti bisogno di qualcuno pratico che lo facesse lui per te. Ecco, tu devi fare un lavoro del genere per un altro. Adesso te l’ho detto, e anche adesso tu puoi dire di no, che non vuoi più, ti do altre dieci, e te ne vai a casa. È sì, o no?...» La 300 Gilera: stava pensando a quella, non era l’Harley Davidson 900, ma era sempre un fulmine di macchina, e anche ai soldi pensava, e poi con una moto così scappava a tutti, solo i jet, pensò infervorato, avrebbero potuto prenderlo. Adesso non sudava più, anzi, si sentiva tutto secco, specialmente le labbra. «È sì.» «Sta’ attento: potrai staccarti anche dopo aver detto questo sì, ma senza tradire. Se tradisci, se parli con qualcuno, pensa a quello che capiterebbe a tua sorella e alla tua vedova. Qualche cosa che cerco di farti immaginare.» «Lascia stare mia sorella, lascia stare le donne», disse lui, adesso aveva secca anche la gola. «Non lascio stare. Tu immagina un esercito che entri in una città dopo qualche mese d’assedio e immagina che questo esercito trovi solo due donne, tua sorella e la vedova giovane che ti piace tanto.» Lui stava seduto tutto curvo sulla panchina, guardava le goccioline di pioggia rimbalzare su una pozzanghera ai bordi del viale. «Ci penserò», disse. «Bravo, sei un ragazzo intelligente. Pensaci. Se vuoi, dopodomani sera vieni qui. Se non vuoi, non vieni, nessuno ti farà niente. Ma non tradire, non parlare con nessuno.» Questa fu la penultima lezione. La mattina dopo andò a comprare una rivoltella giocattolo, dicendo alla commessa che era per il suo fratellino di undici anni e lei gliene consigliò una a proiettili piccolissimi di sughero, con vari fogli di carta velina su cui erano disegnati i bersagli. «Sono inoffensivi, anche dovessero andare in un occhio, fanno meno male di un bruscolo.» A casa, per tutto il giorno, nelle povere stanze di casa sua, nei momenti in cui era solo, sparò ai bersagli. Si accorse che aveva ragione il maestro: anche a mezzo metro si poteva sbagliare il pieno centro. Ma insisté tutto il giorno dopo, e alla fine nel pomeriggio, a tre metri di distanza, faceva tre centri su sei colpi, non sempre, s’intende. E la sera verso le dieci si presentò a scuola, alla panchina del Parco vicino alla Stazione Nord. Erano due giorni che stringeva i denti, li teneva stretti con tutta la sua forza, e alla fine, adesso, gli facevano male, ma se non stava a denti stretti si metteva a urlare. Questa volta dovette aspettare parecchio prima che il vecchio arrivasse. Poi arrivò, sedette nel solito modo sbieco e confessò subito il perché. «Sai, mi siedo così perché da un orecchio non ci sento.» Levò ancora il dieci e glielo dette. «Puoi sempre dire di no, se vuoi, e te ne vai con questo biglietto di auguri, e io non ti dico niente: è nel tuo diritto, capisci?» Lui aprì la cerniera dei suoi trentadue bellissimi denti ferini e disse: «Cosa devo fare?» Era fatta. Pensò che su una Gilera 300 nessuno lo avrebbe mai preso. Mai. «Voglio darti tempo di riflettere e potrai ancora dire di no», disse il maestro. «Ti spiego quello che devi fare, e intanto che te lo spiego, tu rifletti. Ecco il compito: a una certa ora una certa persona esce di casa, tu arrivi con la moto davanti al portone di quella casa, a quella stessa ora, fermi la moto, dici: “Per favore”, come volessi chiedere un’informazione stradale, quella persona si avvicina e allora tu tiri fuori la Smith e scarichi tutto il caricatore addosso a quella persona, non un colpo o due, tutto il caricatore ho detto.» Il vecchio alzò il bavero dell’impermeabile per meglio ripararsi dalla pioggerella. «Puoi ancora ritirarti, perché non ho fatto nomi. Ma se dici di sì, dopo, quando avrò fatto i nomi, non potrai più tirarti indietro. Cerca di capire.» «Forza, va’ avanti, non sono mica scemo.» «Tu devi andare in viale Beatrice d’Este, al 44, alle undici. Verso le undici uscirà una donna, di una cinquantina d’anni. La riconoscerai subito perché è molto alta e porta la cuffietta di infermiera, e sotto l’impermeabile la divisa blu di infermiera, infatti va a fare il turno di notte alla Madonnina, una settimana sì e una settimana no. Esce alle undici e va a prendere il tram per il centro. Tu sei lì con la moto davanti al portone. Lei esce e tu dici, cerca di ricordare bene il nome: “Signora Tarelli”. Lei si volta e ti viene vicino, tu hai la Smith nella tasca sopra il serbatoio della Gilera, pigliala e scarica tutto il caricatore. Sta’ attento: tutto. Non un colpo o due, tutto. Tu non sei un primatista di tirassegno, è la prima volta che tieni in mano una pistola. Lasciala avvicinare il più possibile e spara tutti i colpi che hai.» Lui si inumidì le labbra secche passandovi sopra la lingua. «Chi è questa signora Tarelli?» Il maestro disse: «Potrei risponderti che non ti riguarda, ma ti capisco. Alla tua età, per fare, bisogna capire bene che cosa si sta per fare. Te lo dico subito, ma guarda che non puoi più ritirarti da adesso in avanti. È una donna separata da suo marito, da diversi anni. Il marito vuole sposare un’altra e allora fa questo divorzio all’italiana. Adesso hai capito che cosa stai per fare?» «E quando devo farlo?» disse lui. Aveva capito. «Adesso, subito.» Il maestro guardò l’orologio. «Sono già le dieci e mezzo.» Dopo il secco, in bocca e in tutto il corpo, riprese a sudare, fu addirittura inondato. Adesso, subito. «Ma la moto?» disse. «I soldi e la...?» «Tu giri, qui, viale Shakespeare, e trovi subito, appoggiata a un albero, una Gilera 300, nella taschina sul serbatoio c’è dentro una Smith & Wesson e in quella laterale c’è una mazzetta di cinquanta biglietti da dieci. Sulla Gilera c’è la tuta, il casco, la cintura, gli occhiali. Vai, ma prima di avvicinarti alla Gilera apri quattro volte l’accendino. Ci sono i miei amici che ti guardano e che ti lasceranno prendere la moto solo se farai questo segnale. Adesso ripetimi dove devi andare.» «In viale Beatrice d’Este 44.» «Che nome ha la signora che devi chiamare?» «Signora Tarelli.» «Allora va’, è già tardi.» Lui si alzò, s’immerse nella pioggerella, non più protetto dalle fronde degli alberoni, girò a destra e entrò in viale Shakespeare. Vide subito la Gilera, appoggiata a un albero. Levò dalla tasca l’accendino e, camminando verso quell’albero e quella moto, lo fece scattare quattro volte. Non vide nessuno, sembrava non ci fosse nessuno, ma era evidente che qualcuno lo sorvegliava, se lo sentiva sulla pelle. Si avvicinò cauto alla Gilera. Nella taschina sul serbatoio trovò la Smith & Wesson col supporto di legno al calcio per renderne la presa più sicura. Nel tascone laterale trovò la mazzetta di biglietti da dieci. Si mise la mazzetta nella tasca dei calzoni e chiuse la lampo. Poi guardò ancora intorno. Nessuno. Eppure c’era qualcuno. E in quel deserto piovigginoso indossò la tuta, si calcò il casco sul capo e abbassò gli occhiali, erano idrorepellenti, le gocce di pioggia scivolavano via e il cristallo restava sempre libero. Guardò l’orologio: le dieci e trentacinque, e finalmente saltò a cavallo della Gilera: fu un poco come la prima volta che aveva fatto all’amore con quella ragazza di Porta Volta. Girò la manopola e la Gilera gli vibrò magnificamente tra le ginocchia, subito, allora spingendo col piede, senza avviare, si portò sul viale, sotto quella stupida pioggerella, poi girò l’altra manopola. La Gilera sgroppò e partì, fulminea, e lui provò un istante di fulminea felicità. Alle undici meno dieci arrivò in viale Beatrice d’Este 44 e si fermò davanti al portone. Si accese una sigaretta. La finì e ne accese subito un’altra. Questa non riuscì a finirla. La buttò via, perché il portone si aprì. Alle undici meno un minuto, appunto, il portone si aprì e una donna molto alta uscì. Viale Beatrice d’Este è uno dei viali meno illuminati di Milano, ed era assolutamente deserto con la pioggia che diveniva sempre più fitta. Lui riuscì appena a vedere, alla luce del lontano lampione, la cuffietta di infermiera e la lunga gonna blu sotto l’impermeabile. La donna reggeva in mano anche l’ombrello aperto. «Signora Tarelli», lui disse, mettendo la mano nella tasca dove era la Smith & Wesson. Vide che lei si avvicinava, ma molto esitante. Ripeté: «Signora Tarelli». Lei si avvicinò, ancora più alta con quell’ombrellino blu. E allora lui tolse la Smith & Wesson dalla taschina e nonostante l’urto di vomito che aveva in gola sparò tutto il caricatore, e nonostante che il suo corso di tiro si riducesse a poche ore di esercizio con una pistola a sugherini, fece centro, in pieno, e la vecchia donna non ebbe neppure un grido. Lui girò la manopola e la Gilera esplose via, e lui la spronò a destra, verso via Ripamonti, per lasciare Milano, per essere il più lontano possibile dal luogo dove aveva fatto funzionare la Smith & Wesson. Il maestro aveva previsto tutto, tranne due cose: la delicatezza di stomaco di un ragazzo che non è abituato ad ammazzare, e la scivolosità del terreno per la pioggia. Francamente, è molto difficile guidare una moto vomitando, o avendone una impellente voglia. Inoltre, la già criticabile pavimentatura di via Ripamonti, con la pioggia, quella pioggia sottile, viscida, diveniva per una Gilera così scalpitante una pista acrobatica. Carlo Datti, di anni diciannove, abitante in via Marostica 70, con una sorella che esercitava, e una vedova di diciotto anni come grande amore, dovendo frenare per un camion che gli veniva incontro, e frenare in preda ai suoi conati di vomito, di rimorso, di orrore, si rovesciò a cavallo della sua cavalla matta, fece una cinquantina di metri piallando la strada con la sua coscia sinistra, finché tuta, pelle e poi strati grassi e poi muscoli non si dilacerarono e andò a sbattere col capo, col casco, contro la saracinesca di un negozio chiuso di ferramenta, con grande rumore. Vicino c’era un’osteria e lo portarono subito all’ospedale e del resto, in dieci minuti, accorse la polizia, e trovata la moto con su una Smith & Wesson con supporto in legno e addosso a lui mezzo milione in biglietti da diecimila s’incuriosì, e appena i medici lo permisero gli agenti cominciarono a interrogare il ragazzo. Il ragazzo disse tutto, ma era molto poco. Uno dei poliziotti che si alternavano al letto del ragazzo, disse al suo capo: «È un’anonima omicidi fatta con molta intelligenza. C’è un vecchio che recluta giovanotti volta per volta. Non ci sono killer di professione, questi sono troppo pericolosi, troppo conosciuti dalla polizia. Quel vecchio prende un incensurato, di cattive tendenze ma incensurato, lo istruisce e, per una volta sola, lo fa sparare. Il ragazzo non sa nulla del vecchio, ce lo ha descritto, abbiamo fatto l’identikit, ma chi ci dice che è veramente un vecchio? Potrebbe essersi truccato, non ci vuole molto, un paio di baffetti bianchi, le sopracciglia schiarite con l’ossigeno. Il ragazzo ha trattato solo con lui, non ha visto altri che lui, e ha detto davvero tutta la verità, tutto quel che sa...». «Continuate a interrogarlo, forse verrà fuori qualche particolare che ci aiuterà.» Continuarono, vicino al suo letto, un poliziotto dopo l’altro, a interrogare il ragazzo, Carlo Datti, che aveva i muscoli della coscia sinistra smangiati fino all’osso dalla pavimentatura di via Ripamonti su cui era strisciato, gli fecero ripetere dieci, venti, trenta volte il racconto dei suoi incontri col vecchio, alla ricerca del particolare, finché al quinto giorno il ragazzo, Carlo Datti, trovò un altro dei mille particolari di quegli incontri. «Si sedeva sulla panchina di sbieco in modo da stare non di fianco a me, ma come contro di me.» «Perché?» disse il poliziotto. «Ecco», lui ansimò, «l’ultima sera mi disse che ci sentiva poco da un orecchio e per quello stava in quella posa curiosa.» Il poliziotto sussultò. «Sta’ buono, forse abbiamo finito», disse il poliziotto al ragazzo. Benché si trattasse di un giovane assassino, non resisté a fargli una carezza sulla fronte, e corse a telefonare. «È il Sordo...» disse al ricevitore. Il Sordo era un vecchio ladro, conosciutissimo dalla polizia, che adesso si era messo più in grande, negli omicidi. Aveva quaranta anni, ma si era truccato per dimostrarne sessanta al ragazzo. Senza quel particolare, non lo avrebbero mai preso. Invece lo presero. “Non si può mai pensare a tutto”, pensò il Sordo quando entrò in carcere. 17 · Domani, forse E qui appresso diamo il nostro rapporto informativo settimanale. Lunedì: come la settimana precedente la signorina L.L. che per Vs. incarico sorvegliamo, è rimasta la sera in casa. Martedì: la signorina L.L. esce alle undici di casa, sosta in un bar dove s’incontra con un uomo col quale doveva avere appuntamento (i dati di quest’uomo sono riportati nel foglio B a parte). Salgono tutti e due nella macchina della signorina L.L. Arrivo a Como. Sosta all’albergo sul lago, stanza n. 24. Ritorno in città alle 19. Mercoledì: giornata in casa. Giovedì: la signorina L.L. esce alle undici, sosta in un bar dove s’incontra con lo stesso uomo di martedì. Viaggio a Como. Albergo. Camera n. 22. Venerdì: giornata in casa.... «Non andare così in fretta», disse lui all’autista, mentre leggeva il rapporto dell’agenzia investigativa, voleva finire di leggere, prima di arrivare da lei, voleva sapere, prima di farle mangiare quel meticoloso rapporto, di tante pagine, con tanti numeri di stanze d’albergo. Oh, voleva strapparle la pelliccia, i bracciali, l’anello col sasso grosso così, disdire il contratto dell’attico e poi darle una schiaffata in faccia insieme con quella parola che cominciava per «p» e che era il suo nome vero. Anche gli altri tre fogli del rapporto contenevano la stessa roba, un giorno sì e un giorno no, lei se ne andava a Como col suo giovane pappone e un giorno no e un giorno sì si dedicava al vecchio imbecille che era lui. Era arrivato. Scese dall’auto. L’ascensore lo portò fino all’attico. Lei venne ad aprire. Non era molto vestita, gli tolse il paltò, coi bruni capelli sciolti gli coprì il viso rugoso. «Ma che faccia seria che hai, Dodino», disse. Glielo avrebbe detto domani, pensò lui, vinto, glielo avrebbe fatto mangiare domani, il rapporto dell’agenzia investigativa. Domani. Tanto, stasera, a che serviva? Domani, forse. 18 · Sempre la stessa storia Era proprio ubriaco, ogni tanto gli accadeva, e il padrone del bar non gli dava retta, perché tanto raccontava sempre la stessa storia. «Prova tu a fare la maschera al cinema: il tempo non ti passa mai, un film lo danno anche dieci giorni, venti, prendi lavoro alle due e dopo un secolo sono solo le tre e mezzo, dopo un altro secolo sono le quattro... Io tornavo a casa e mi mettevo quasi a piangere davanti a lei: “Irma, non gliela faccio, non resisto, divento matto”, e lei mi diceva: “Va bene, allora torna a fare quello che facevi prima e mi scoppia il cuore...”. Ho resistito tre mesi a fare la maschera, poi una sera ho telefonato al brigadiere e gli ho detto se aveva del lavoro per me. Era appena finita la guerra e c’erano bombe, mine dappertutto e lui mi ha detto: “Pensavo proprio a te...”. Mi ha mandato a disinnescare una bomba d’aereo di trecento chili, rimasta interrata vicino alla ferrovia. Non hai idea di come passa il tempo quando fai quel lavoro, a cavallo della bomba, per disinnescarla, o davanti a una mina magnetica, che devi avvicinarti nudo, perché la minima cosa di ferro che hai addosso, esplode... Poi c’erano anche le mine foniche, se eri vicino e ti veniva da sternutire, scoppiavano. Una volta ci ho messo due giorni, con una mina magnetica, mi sembrarono due minuti... Lei lo sapeva che ero tornato a quel lavoro e cominciò a star male. “Una volta o l’altra salti”, diceva, e le venivano le crisi di cuore, ma io, gli altri lavori, non li sopporto, muoio di noia, e continuo. Il medico mi dice: “La smetta, se no andiamo male”, ma io continuo. A fare la maschera al cinema non ci torno... Così una sera rientro a casa da La Spezia dove avevo disinnescato un siluro, e la trovo morta, l’ho ammazzata, io, ecco come si ammazza una donna, per far passare il tempo in fretta...» Il padrone del bar disse di sì, agli ubriachi è meglio dire sempre di sì. 19 · La prima e l’ultima «Con me non devi mai avere paura», bisbigliò Rosario a Concetto. «Io prevedo tutto. Questa stanza è stata fissata stasera per domani a nome di un tale. Il tale a quest’ora è a Palermo, e tutti lo vedono e ammirano. Questa stanza in cui siamo noi non figura occupata. E noi non abbiamo che da aspettare che i due porci siano stanchi. La serratura della porta di comunicazione l’ho già sistemata. Entriamo, facciamo giustizia, e chi si è visto si è visto. L’unico particolare sgradevole è dover spiare le loro porcherie...» Concetto annuì inutilmente nel buio con la grossa testa riccioluta. Era nudo, continuava a carezzare il coltello a serramanico aperto sulla coscia. Dalla fessura nella porta di comunicazione lui non guardava. Ci guardava Rosario, nudo pure lui, torcendo inutilmente la bocca nel buio. «I porci», disse. «Tengono pure la luce accesa per far meglio le porcherie. Tra poco è finita, per fortuna...» L’avvocato era uno cui l’amore piaceva con la luce accesa. La spense solo quando si sentì stanco. Molto stanco. Si addormentò quasi subito, continuando, comunque, a stringere tra le braccia il ragazzo inesperto, goffo, spaventato, che proprio per la sua inesperienza, goffaggine, spavento lo aveva eccitato più d’uno dei soliti marpioni romani. L’avvocato attaccò a russare, il ragazzo stentava a prender sonno. Era pieno di schifo, anche e soprattutto per sé stesso. Gli amici gli avevano detto di non esser stupido. Un ragazzo doveva ben guadagnare in qualche modo; l’avvocato era un porco, ma pagava bene. Lui aveva bisogno di soldi, aveva una ragazza che gliene mangiava un sacco, così si era deciso. Per una marchetta non si muore mica, gli aveva detto uno degli amici. Lui si era deciso e si era pentito. Non l’avrebbe ripetuto un errore simile. Quella era la prima e sarebbe stata l’ultima volta. Fu, infatti, la prima e l’ultima. Il ragazzo si stava finalmente addormentando quando gli parve che una porta si aprisse. Ma non ne era sicuro nel sonno. La porta di comunicazione si era aperta davvero: i due sicari sostarono un poco a decifrare il buio, poi arrivarono sino al letto sfiorando appena il pavimento con i piedi nudi. Rosario mise una mano sulla bocca dell’avvocato, con l’altra mano gli tagliò la gola. Concetto pensò al ragazzo. Rosario tornò ad accendere la luce per constatare la riuscita del lavoro. Era scrupoloso. Scoprì che il ragazzo gorgogliava ancora, debolmente. «Concetto», disse, «devi imparare a lavorare meglio.» Finì il ragazzo. Rosario spense la luce, lui e Concetto rientrarono nella stanza fissata per quello che a quell’ora era a Palermo a farsi vedere e ammirare da tutti senza sognarsi che a quell’albergo di Roma era aspettato per il giorno dopo. Si lavarono bene da ogni possibile macchia di sangue, si rivestirono. «Se impari, hai una strada davanti a te», promise Rosario a Concetto. 20 · Le chiacchiere L’anestesista fece segno con la mano che andava bene, quel che poteva andare bene per un’anziana squillo che era la terza volta che le rappezzavano l’intestino macerato nell’alcool e tutti la conoscevano nella lussuosa clinica dove arrivava col suo schifoso bassotto e la bottiglia di whisky nella borsa: «Tagliatemene un altro metro, tanto ne abbiamo trentatré, no?...» diceva. «Accendete anche l’altra lampada, bella gente», disse il chirurgo. Col bisturi girò intorno alle altre due precedenti incisioni, aprendo rapido un bello squarcio. «Non voglio, non voglio...» disse l’anziana squillo. «Mamma, adesso ci racconta la storia del cacciatore di leoni che la voleva sposare», disse l’assistente. Anche durante le altre due operazioni, sotto l’anestesia, lei aveva raccontato storie scabrose con un cacciatore di leoni, una specie di Hemingway che si era appassionato a lei. «No, questa volta è diversa», disse l’assistente femmina, sotto la maschera fece una smorfia. «No, Mario, non voglio...» E lei, l’anziana squillo, rivedeva i vasti giardini pubblici, le foglie di primavera di un verde chiaro, ed era una bambina educata bene, ma il ragazzo, uno che si chiamava Mario, il primo, le chiudeva la bocca con un bacio, il primo bacio di lei, quello che le era rimasto più impresso, per sempre, incancellabile. «Fortuna che era una che non voleva...» disse il chirurgo. L’anestesista rise. «Non voglio, non voglio, Mario», lei ripeteva. Poi a un certo punto smise. L’anestesista non rideva più. Il chirurgo si fermò, era l’ultima operazione della mattinata, voleva dire qualcosa ma non sapeva esattamente cosa. Gli venne in mente, mentre si lavava le mani. Una menzogna come commemorazione. «Forse non voleva davvero», mentì a sé stesso. 21 · Di professione farabutto «Sandrone Donatello, fu Pietro e fu Annamaria, di anni 21, nato a Canzo, provincia di Como, di professione farabutto, io adesso ti rimetto in libertà, da questo momento. Tu hai commesso molte grosse fesserie da quando hai cominciato a fumare la prima sigaretta... Insieme con altri compagni a sedici anni hai ucciso un disgraziato per rubargli tutti i soldi, da solo hai tentato la solita rapina a un tabaccaio e gli hai mezzo sfondato la testa con una bottigliata. Te la sei cavata con due anni di riformatorio e un anno di casa di lavoro... Ora sei libero, Sandrone Donatello, e ringrazia l’assistente sociale qui presente, la signorina Matilde Missani, che ha garantito per te e credo che sia la più pericolosa e disperata garanzia che una persona possa prendere. Ora guardami in faccia e ascolta bene quello che ti dico: sei libero, queste sono le tue cose, comprese le settemilatrecento lire che ti sei guadagnato nella casa di lavoro, la signorina Matilde Missani ti ha trovato anche lavoro in un’autorimessa a Milano... E ascolta ancora: fa’ il bravo, se no sei finito. Io sono un semplice brigadiere, ma, se fai altre fesserie, anche solo che rubi un pollo, tu ritorni qui, e allora sei finito perché ci resti almeno cinque anni, più tre anni di casa di lavoro e fanno otto e poi altri due anni perché io non darò mai il mio assenso alla tua scarcerazione... Cerca di capire: delle persone illuse credono al tuo ravvedimento e ti lasciano libero, ti danno lavoro e soldi per cominciare una nuova vita. Io non ci credo, ma sto a vedere. Ho paura che ci vedremo ancora e anche molto presto, e allora vorrà dire non solo che sei un farabutto senza speranza, ma che sei anche stupido...» Il brigadiere firmò il modulo di scarcerazione con la sua grande, chiara firma: Brigadiere Vagarolli Antonio. «Sei libero, esci.» La bellezza del freddo, dell’aria che sa di neve anche se non nevicava ancora ma sarebbe nevicato presto tanto l’aria era pungente. La bellezza del freddo dopo il caldo tropicale in quel trenino della Nord che li aveva portati a Canzo, e la bellezza di camminare con quegli scarponi e quel pesante sacco a spalla, lei un poco buffa nei calzoni aderenti sulle sue forme piuttosto pronunciate e quella grossa sacca che portava a fatica ma orgogliosamente. Attraversarono il paese, a un certo punto lei vide un caffè e disse: «Berrei volentieri un tè». «Sì», lui disse, aggiustandosi la sacca sulle spalle. Lei sentì un tono d’incertezza nella sua voce: «C’è qualche cosa, Donatello?». «No...» lui sorrise, ma era ancora incerto. «Lo sai che sono nato qui, mi conoscono tutti, poi da quando sono stato in riformatorio, si capisce, non ci tengono ad aver a che fare con me, a salutarmi...» «E che bisogno hai dei loro saluti?» lei disse sprezzante. «Adesso non hai più debiti con nessuno, lavori e nessuno può criticarti.» «Sì», disse, sempre incerto. Ma la prese per il braccio e la guidò nell’interno del bar. C’erano sempre i due vecchi padroni di quando lui era ragazzo e andava lì a comprare gli amaretti, e non sembravano molto più vecchi di allora, come statue di cera che non invecchiano mai. Lo guardarono, lo riconobbero, ma volsero subito tranquillamente lo sguardo, e lui allora disse: «Un tè e un caffè». C’erano due ragazze sui diciott’anni, lui le riconobbe, aveva giocato con loro quando erano bambine, la bruna si chiamava Emanuela perché il padre era monarchico, e la rossiccia Silvana. Non tentò neppure un principio di sorriso, come avrebbe voluto, perché le due ragazze, appena entrò, volsero le spalle e uscirono subito dal caffè. Dopo un’ora di cammino per la stradina che scorreva a nastro lungo i fianchi del colle, arrivarono davanti alla casetta sul piccolo altopiano da cui si dominava tutta Canzo e parte della vallata intorno. Era proprio una casetta, non una villa, non una baita, i mattoni erano a nudo e si vedevano le sbavature secche della calce. Non c’era tetto spiovente: era un cubo con due finestre per lato più un portoncino. «L’ha costruita mio padre, si è fatto aiutare solo da un vecchio muratore», lei disse orgogliosa. «Veniva da Milano la domenica mattina e lavorava tutto il giorno. Portava su i mattoni e l’altro materiale con un carretto tirato da un somarello, per questo l’ha chiamata la Villa del Somarello.» Introdusse la chiave nella serratura. «Mi portava qui ogni anno, anch’io sono un po’ dei posti, conosco molta gente a Canzo, conosco anche quei due vecchi del caffè, che non hanno salutato neppure me, non solo te.» Faceva fatica, la chiave non girava bene nella serratura, lui l’aiutò e solo con molto sforzo riuscì ad aprire. Lei disse entrando: «Sono solo tre stanze, una saletta, una camera da letto e la cucina, ma papà ha voluto fare il camino, guarda, e c’è la legna pronta, quando andiamo via da qui per tornare a Milano prepariamo sempre la legna con la sterpaglia secca, per accendere subito il fuoco, quando torniamo...». Le pesanti sacche furono depositate in terra vicino al tavolo nella cucina: la bellezza del freddo, del gelido locale, delle pareti come di ghiaccio, e la bellezza della fiamma che salì alta nel camino appena lui accese la carta e i rametti secchi. Stavano tutti e due accucciati davanti al camino d’improvviso incendiato. Si tolsero i guanti e il cappuccio di lana spessa. Le labbra di lei, alla luce delle fiamme, persero il livido di prima, divennero di un rosa arancio tremulo di luce. Egli le passò una mano alla nuca, le prese un po’ dei corti capelli castani e così stringendola la costrinse a voltare il viso verso di lui. «Irene», disse, «Irene.» Sempre tenendola rudemente per i capelli alla nuca, la baciò rudemente, tra gli scoppiettii e le fiamme sempre più alte nel grande camino, e lei, respirando forte, si lasciò andare all’indietro, sotto quel bacio che la spingeva all’indietro, sul nudo pavimento, che era fatto di larghe assi di legno, non un parquet, ma assi larghe due palmi e lunghe un metro e mezzo, tenute pulite da ripetute lavature e candeggi. «Sei matto, Donatello», lei sorrise rauca, sfuggendogli dopo un poco. Si mise in piedi, le fiamme non erano più alte nel camino, ma due grossi ceppi cominciavano a bruciare su un fondo di brace incandescente, e la cucina era divenuta calda. «Mettiamo a posto tutta la roba, poi preparo da mangiare...» sfuggì da lui che voleva riafferrarla, «no, sta’ buono, sta’ buono, magari dopo.» Svuotarono le sacche e misero tutte le provviste nell’armadietto di cucina, volevano stare lì almeno quattro giorni, fare tante passeggiate, fino alla Valbrona, al lago di Lecco, senza dipendere da nessuno, trattoria o negozio che fosse, avevano portato perfino il petrolio per le lampade, e in cucina c’era già la bombola di gas liquido, e Irene disse che avrebbe fatto il minestrone di verdura, quello già preparato in busta, con la pasta e fagioli. «È proprio la minestra che mi piace, con questo freddo», disse Donatello. Perlustrarono le altre due stanze, la piccola sala, col divanetto e la radio a pile, ma erano scariche perché era dall’estate che non veniva più nessuno lì. E la camera, con i due letti, i materassi erano arrotolati e stecchiti nel gelo, anche lenzuola e coperte, nel cassettone, erano stecchite, le lenzuola sembrarono scricchiolare quando le spiegarono. Con due o tre colpi di ginocchio, Donatello spinse una delle brandine verso l’altra, fino a formare un letto solo. «Fa troppo freddo per dormire separati», disse. Bellezza di quel freddo, di quel gelo, del respiro che si condensava. Tornarono nella cucina, ora così calda. Si tolsero i maglioni, gli scarponi, i calzoni felpati e misero quelli di lana più leggera. Sul fornello a gas liquido cuoceva rapidamente il minestrone di verdura con pasta e fagioli e l’aroma riempiva il piccolo ambiente. La notte era scesa rapidamente, lui aveva acceso il lume a petrolio e lo aveva messo in mezzo alla tavola, senza tovaglia, dove lei aveva già disposto i piatti piani e le scodelle, con le modeste posate prese ai grandi magazzini e la gavetta piena di vino rosso che rifletteva la calda luce delle fiamme del camino e quella ferma del lume a petrolio. «Sono tanto felice», lui disse. Aveva anche tanta fame, ma questo non lo disse, e aspettava il minestrone, e intanto s’era inginocchiato, seduto sui talloni davanti al camino, perché per un attimo, guardando il largo acceso mucchio di brace rossa fiammeggiante, aveva ricordato il riformatorio, la doccia che sapeva di cloro da morire asfissiati, il refettorio con quell’odore continuo di patate marcite e il brigadiere Vagarolli, Antonio Vagarolli, l’uomo più odiato da tutti i ragazzi, che ogni settimana veniva a interrogarli e a informarsi della loro condotta e a siglare le punizioni. Lo ricordò l’anno prima quando era stato liberato dalla casa di lavoro. «Sandrone Donatello, fu Pietro e fu Annamaria», ricordava parola per parola, «di anni 21, nato a Canzo, provincia di Como, di professione farabutto...» Di professione farabutto. Di professione farabutto. Di professione farabutto. E invece no. E invece no, invece no, non era di professione farabutto, era lì, davanti al camino, era un ragazzo che lavorava, aveva la fidanzata che gli preparava il minestrone, si sarebbero sposati a maggio, per questo era felice, e lo ripeté: «Sono tanto felice». E Irene allora spense il gas perché il minestrone era cotto, gli andò vicino, si inginocchiò anche lei davanti al camino, sedendo sui talloni. «Perché dici che sei felice?» Lui la guardò, sorridendole solo con gli occhi, ma non le rispose. Lei non poteva immaginare, non conosceva le cantine con le celle di punizione del riformatorio, le urla dei guardiani al mattino alle cinque per la sveglia, e le liti furibonde coi compagni, e i guardiani che intervenivano solo quando c’era qualcuno mezzo rovinato a pugni e calci. Irene disse: «Vieni, mangiamo, se no la minestra si fredda». «Sì», le disse lui, si rimise in piedi e aiutò lei ad alzarsi e sedettero a tavola davanti alle due scodelle di minestrone fumante, in mezzo il lume a petrolio, e alle spalle la rossa, vivida luce del camino. Sono tanto felice, pensò ancora. La bellezza di stringersi, nella stanza gelida, sotto le lenzuola che al momento erano un velo di ghiaccio, ma che poi subito si scioglievano per l’ardente tepore dei loro corpi e alla fine lui rialzò lo stoppino del lume a petrolio che aveva abbassato al massimo, e nessuno dei due sentiva più freddo, neanche lui a torso nudo, che si accese una sigaretta e poi finì l’ultima sorsata di grappa dalla piatta bottiglietta che era sul comodino. «Ma copriti, Donatello, se no prendi la polmonite.» «Sto bollendo», si alzò, completamente svestito, nella gelida stanza. «C’è un Corriere della Sera sotto il comò, che disordinata che sei, l’hai lasciato dall’estate scorsa.» Si curvò e lo raccolse, sedette sul letto, la sigaretta penzoloni tra le labbra, e lesse svagatamente i titoli alla luce morbida e fumosa del lume a petrolio. D’un tratto ebbe freddo, leggendo un titoletto: Oggi, 2 febbraio 1967, il presidente Johnson ha di nuovo dichiarato che sospenderà ogni bombardamento e che accetterà ogni proposta di trattativa di pace per la guerra nel Vietnam. Ebbe un brivido. Poi un secondo brivido. Guardò la data del giornale. Era: 3 febbraio 1967. «Irene», disse. «Cosa c’è Donatello? Non prendere freddo.» «Irene, questo giornale è di oggi.» Le fece vedere la data: 3 febbraio 1967. «Tu non hai portato giornali qui, oggi, e neppure io.» Lei si sollevò lentamente, avvampando di calore nonostante il gelo della stanza, ma senza capire ancora bene che cosa lui voleva dire. «Irene, questo giornale è stato stampato alle due di questa notte a Milano, è arrivato qui a Canzo forse alle otto di questa mattina, e ora si trova qui, in una casa rimasta chiusa dall’estate scorsa, e dove, teoricamente, non avrebbe dovuto entrare nessuno dall’agosto passato.» Lui ingoiò saliva e paura e freddo. «Questo significa che questa mattina e fino a poco prima che arrivassimo noi qualcuno è stato qui.» Lei rifletté. Capiva, ma non aveva paura come lui. Disse calma: «Ci sono tante case e ville sparse qua e là. D’inverno, quando è sicuro che i proprietari non verranno d’improvviso, qualche paesano, qualche ragazzaccio, forza la serratura e sta qui, con qualche ragazza». «Sì, lo so», disse lui, si rivestì, il grosso costume di lana, i calzoni, il maglione e mentre si metteva gli scarponi disse ancora: «La serratura della porta non funzionava più bene perché era stata forzata da qualcuno. E io vorrei sapere che cosa ha fatto qui questo qualcuno». Anche lei si vestì. Sì, lo voleva sapere anche lei, qualcuno era entrato lì quello stesso giorno, il giornale lo provava, e doveva aver avuto un motivo, e anche lei lo voleva sapere. Lui accese la grossa torcia elettrica che prese dalla sacca, mentre lei teneva il lume a petrolio. Nella stanza da letto non c’era niente di insolito, guardarono anche sotto il letto, aprirono tutti i cassetti del cassettone, l’armadio a muro. Lei osservò e disse: «Non c’è nulla fuori posto». Andarono nella saletta, spostarono il divanetto, le sedie-poltroncine, il mobiletto bar, ed ecco, nel mobiletto bar c’era una piccola bottiglia di grappa rovesciata, il liquido era tutto uscito dalla bottiglia, aveva macchiato il pavimento di assi di legno, scurendolo. Donatello si inginocchiò e annusò quelle macchie scure. L’odore aspro della grappa gli tolse quasi il respiro. «Questa bottiglia è stata rovesciata poche ore prima che arrivassimo noi», disse, «senti come è forte l’odore di grappa.» «L’ho già sentito», disse Irene. Tutta la saletta era impregnata di quel sentore. In cucina non c’era niente che denotasse il passaggio di qualcuno. Quello che era entrato non aveva né acceso il fuoco nel camino, né mangiato qualche scatola di carne o di sardine, lasciata lì dall’estate. «Guardiamo fuori», disse Donatello. Uscirono. La bellezza, della neve, dell’aria meno fredda e di tutti quei fiocchi di neve che scendevano in girotondo nel cerchio di luce della torcia elettrica, e oltre quel cerchio tutto era terribilmente buio e nero, non si vedeva nessuna luce né di Canzo, né dello stradone. «Facciamo il giro della casa», disse lui. «Sta’ attenta se c’è qualche cosa fuori posto.» Girarono intorno alla piccola casa, lei afferrata al suo braccio, lui col fascio di luce della torcia puntato in avanti, immersi nel dolce turbinio dei fiocchi di neve. Un lato, un secondo lato, poi il terzo. Lei disse: «La scala». Lui gettò il fascio di luce della torcia quasi in terra dove era appoggiata una lunga scala di legno, costruita alla buona, non certo comprata in negozio. «Che cos’ha la scala?» domandò. «Papà non la lascia mai fuori, quando chiudiamo e torniamo a Milano», lei disse. «La mettiamo sempre in cucina, prima di partire. È così lunga che la mettiamo per diagonale. Se ci avessi pensato me ne sarei accorta subito, appena entrati, oggi, che mancava la scala.» Lui guardò la scala, già rigata da striscioline di neve, che si depositavano sui pioli e sul primo palo di sostegno. Una scala serve a salire, pensò, guardò allora in alto, il tetto della casa. Non era un tetto spiovente, con tegole, era solo una copertura di mattoni e calce, un po’ in pendenza per lo scolo delle acque, e col comignolo: una specie di terrazzo, insomma. «Io salgo», disse lui. Raddrizzò la scala appoggiandola al muro. «Perché?» lei disse, non comprendendo. «Perché se la scala è fuori invece di essere dentro casa, ci deve essere un motivo», lui disse. «Devono averla usata, e una scala si usa per salire.» «Vengo anch’io», lei disse. Arrivarono sul tetto-terrazzo e videro subito. Era un uomo così piccolo che sembrava un bambino. La neve lo aveva spolverato di bianco, compreso il grosso coltello che l’aveva ucciso. Nel cerchio di luce della torcia elettrica, nello sfarfallio bianco della neve sempre più copiosa, stettero a guardare senza dir nulla per due lunghi minuti e lui si accucciò, anche, davanti al piccolo uomo per guardarlo meglio, poi disse: «Quel coltello è della tua cucina, vero?». Irene rispose con un sussurro: «Sì», lo riconosceva. «Scendiamo, vieni, ti tengo io», disse lui, Donatello. In cucina, solo quando le fiamme nel camino furono alte e sembrò che dovesse bruciare la casa, lei smise di tremare e dopo un poco disse: «Dobbiamo andare a Canzo ad avvertire i carabinieri». Spense il lume perché tanto dal camino veniva luce più che sufficiente. Disse, piano, con una voce che non sembrava neppure sua: «No», e poi disse, sedendo in terra davanti al camino, vicino a lei: «Devo portare il cadavere in qualche posto lontano da qui». Lei tornò a rabbrividire, nonostante il calore che veniva dai grossi tronchi che ardevano, lo guardò terrorizzata. «Perché?» disse. «Perché...» lui tentò di spiegare. Aveva poco più di ventun anni, ma non era né un ragazzo, né un uomo, né un vecchio: quando si passano due anni in riformatorio, forse non si è più neppure esseri umani, ma lupi rabbiosi, che fuggono ululando. «Perché quell’uomo, qui sopra, è el Pinin, tu non sai chi è el Pinin, vero?» parlava lento, paziente. «No, non lo so.» Lento, paziente, lui spiegò, intanto che si accendeva una sigaretta, l’atteggiamento, però, nervoso, irsuto come, ecco, quello del lupo che raddrizza il pelo e gli si gonfia il collo per il furore, sentendo le voci lontane dei cacciatori che lo braccano. «È uno di qui, di Canzo, è molto conosciuto. Lo chiamano el Pinin perché è piccolino, magro, sembra un bambino, ma è invece un delinquente. Vive alle spalle delle donne, quelle del paese e dei dintorni, delle turiste che vengono qui d’estate. Ne approfitta e poi le ricatta, o le deruba. A me non importa niente che lui sia un delinquente, ma c’è un’altra cosa...» Lei si passò una mano sui capelli, il calore del camino aveva sciolto la neve che vi era caduta sopra, inumidendoli. «Che cosa?» «Irene», lui disse pianissimo, «tu sai che cosa ho fatto quando avevo sedici anni. Ti ho confessato tutto, subito. Sono stato immischiato con altri sciagurati come me nell’uccisione di un disgraziato. Io non ho fatto nulla, ma ero insieme con gli altri, ero ubriaco e non ricordo quasi niente. Ma quando fuggimmo dalla villetta dell’invertito, qui a Canzo, un uomo ci vide e ci denunziò ai carabinieri. Quest’uomo era el Pinin. Testimoniò al processo, al tribunale dei minorenni contro di me e contro gli altri. Ora questo Pinin si trova qui sopra, sulla nostra testa, ucciso da una coltellata...» «Donatello, no, non parlare così», lei guardò in alto, istintivamente, e vide, lì sopra le loro teste, il cadavere del Pinin. Lui l’aiutò. La fece sedere sulla dura sedia di legno. «Scusami, Irene, ma devo cercare di farti capire.» Sedette vicino a lei, col suo fazzoletto le pulì le labbra, versò qualche goccia di grappa nel palmo della mano dalla fiaschetta e le bagnò il viso, glielo lavò col liquore. «Se io vado dai carabinieri di Canzo a dire che ho trovato il cadavere di Pinin sul tetto, qui, di questa casa, loro dicono: certo, sei tu che l’hai ucciso, uscito di galera sei venuto a vendicarti di quello che ti aveva denunciato alla polizia e che aveva testimoniato contro di te.» Lei gridò, con tutto il suo amore, tutta la tenerezza che provava soltanto nel guardarlo, perché soltanto lei, come donna, e non solo come sua amante, ma come fosse sua madre, come fosse sua sorella, sentiva che era divenuto un ragazzo giusto, onesto, che si era pentito di tutto ciò che aveva fatto e che non sarebbe mai più caduto in nessun errore, solo lei lo sapeva e allora gridò: «Ma io testimonierò che non sei stato tu, dirò tutto quello che è successo, che abbiamo trovato i l Corriere della Sera nella stanza da letto, che abbiamo fatto il giro della casa per cercare qualche traccia e che alla fine abbiamo trovato quell’uomo, lassù, sul tetto...». Lo gridò con tutta la sua voce. Lui le toccò il capo. «Sta’ calma», le disse, paziente e tenero. «Ogni uomo ha vicino una donna disposta a giurare il falso per lui. Arresterebbero anche te, se non per complicità in omicidio almeno per falsa testimonianza.» Accese una sigaretta e gliela dette. «Se andiamo dai carabinieri a Canzo, io sono finito. E anche tu passi qualche anno in galera... Il brigadiere Vagarolli mi aspetta. Me lo ha detto, anche se soltanto avessi rubato un pollo, mi avrebbe preso e tenuto dentro una diecina di anni. E qui non si tratta di un pollo rubato, si tratta di un omicidio. Io non ho ucciso el Pinin, ma per loro, chi può essere stato, se non io?...» Si alzò, si accese una sigaretta per sé. «Io posso fare due cose. Andare a Canzo e dire tutta la verità», spiegò metodico. «Se faccio questo, salutami adesso, perché sarà difficile che ci si riveda, forse in tribunale, al processo, né ci sposeremo mai più, né staremo mai più vicini.» Buttò la sigaretta appena cominciata nel braciere del camino. «Se invece porto el Pinin lontano da qui, se lo nascondo lontano da qui, dall’altra parte della montagna, se faccio sparire ogni traccia che el Pinin sia stato qui, forse mi salvo.» Senza rendersene conto si accese un’altra sigaretta. «Ci vorranno molti giorni per trovare il cadavere, e quando l’avranno trovato non potranno accusare me...» Aveva fumato solo due boccate della sigaretta e buttò anche questa nel camino. Guardò, dall’alto della sua alta statura, lei, seduta e disfatta. «Irene, devi decidere tu, io farò quello che tu vorrai. Se vuoi, andiamo subito dai carabinieri. Ricordati che bisogna andarci subito. La gente onesta, quando si trova un cadavere in casa, corre subito dalla polizia. O se vuoi, lasciami portare el Pinin al di là della montagna, poi torniamo qui, cancelliamo ogni traccia e facciamo come non avessimo visto nulla. Scegli tu, Irene, io farò soltanto quello che tu deciderai.» Lei pensò: la legge, la giustizia, andiamo alla polizia, ma guardò il viso di lui, illuminato dalla rabbrividente fiamma del camino, e ancora di più illuminato dalla sua interna, spaventosa disperazione, e capì che lui, forse non del tutto a torto, non credeva più né a legge, né a giustizia. Se avesse detto la verità sarebbe tornato nel pozzo senza fine del carcere, per un delitto non commesso. Si alzò e si sostenne con una mano al tavolo. «Voglio che tu nasconda il cadavere», disse fermamente, usando fermamente quella parola cadavere. Lui disse: «Sta’ attenta, Irene, diventi mia complice». Allora lei urlò, alzò le braccia, strinse i pugni: «Portiamolo via e basta! Basta! Basta!». Non è facile il trasporto di un cadavere, senza i mezzi adeguati, specialmente se il cadavere è su un tetto, e anche se piccolo è appesantito dalla rigidezza della morte. No, non era davvero facile, pensò lui salendo la rozza scala di legno con una coperta in braccio e la lampada a pile in mano. El Pinin era sempre lì, adesso quasi già tutto ricoperto dalla neve che continuava a cadere copiosa, escluso il grosso manico del coltello che aveva un pennacchietto di neve solo sul fondo. Lo tirò fuori, il coltellone, bisognava rimetterlo in cucina, dopo averlo pulito al massimo, nel cassetto delle posate. Avvolse el Pinin nella coperta e lo sollevò. Non credeva che una cosa così piccola pesasse tanto, e potesse essere tanto rigida, era come portare un palo di cemento. Discese faticosamente la scala col suo macabro involto sotto il braccio destro e nella mano destra la torcia elettrica, e solo con la sinistra si teneva a uno dei due grossi bastoni tra cui erano infissi i pioli, scendendo ansante e con lo stomaco che ribolliva, piolo per piolo. «Adesso tu va’ avanti», disse a Irene respirando forte, a bocca aperta, tanto che ingoiò qualche fiocco di neve, «il sentiero che porta oltremonte lo conosci?» «Sì», lei lo conosceva, aveva fatto tante passeggiate da quelle parti. «Va’ avanti», lui disse, sostenendo la cosa avvolta nella coperta, che era stata un uomo, e dette la lampada a pile a Irene. «Fa’ come le lucciole al cinema, va’ avanti e butta la luce in terra, vicino ai tuoi piedi...» E lei fece così: la lucciola. Al principio il sentiero scese, poi cominciò a salire. Non si vedeva nulla oltre il piccolo cerchio di luce della lampada a pile e dei fiocchi, di neve, sempre più fitti, compatti, densi. Lungo la salita, per il sentiero sassoso, si fermarono tre o quattro volte, esausti, lui sempre con el Pinin in braccio come un bambino, la coperta scura divenuta bianca per la neve. Finalmente il crinale del basso colle, il sentiero riprese a discendere, ma l’unica luce era sempre quella della torcia. «Fermati», lui disse. «Sta’ attenta, c’è lo strapiombo. Spegni la luce.» Lei obbedì, ferma a mezzo metro sulla roccia a picco sulla vallata verso Asso, spense la luce e attese. Fu una cosa molto semplice: lui svolse la coperta, tenendone saldo un lembo in mano. El Pinin si rotolò dalla coperta, nel buio assoluto, era come essere ciechi, si sentivano solo i fiocchi di neve sul viso, e precipitò per un duecento metri in fondo al dirupo che dava in una forra così folta dove forse neppure i cani da caccia avrebbero potuto entrare. Ci sarebbe forse voluto un mese per scoprire el Pinin. Presero a correre per tornare a casa. Il sentiero era troppo stretto per correre insieme, allora lui corse avanti, facendo da lucciola lui, questa volta, tutte e due col viso impastato di neve dura, ghiacciata. Ogni tanto inciampavano, lui cadde una volta, batté male il polso e urlò per il dolore. «Donatello, Donatello», lei lo aiutò a rialzarsi. «Non è niente», disse lui, con la mano ciondolante, dolente come se gliela picchiassero con un martello. Arrivarono davanti alla piccola casa, il fuoco nel camino stava spegnendosi, vi misero l’ultima legna, poi lei si buttò in terra singhiozzando, davanti alle fiamme che cominciavano a riprendere, piangendo tutto l’orrore che aveva in sé. «Sta’ qui con me, Donatello, chiudimi gli occhi, non voglio vedere e sentire più niente.» Lui si distese in terra accanto a lei, e con le carezze tentò di calmarla. «Stringimi tu, Irene, io ho un polso slogato...» sorrise, e poi scoppiò a piangere, di terrore. Si svegliarono lì, in terra davanti al camino che aveva ancora qualche brace: si svegliarono non per il freddo, perché non faceva freddo, ma per quel rumore, sordo, che riempiva tutta la vallata, in quell’alba gelida di febbraio. Erano due campagnole, ciascuna con due carabinieri a bordo armati di mitra che s’inerpicavano per la mulattiera che portava alla casa dove loro si trovavano. Non tentarono di fuggire, non avrebbe avuto senso, stettero alla finestra, stretti abbracciati, a guardare le due camionette che raggiungevano la piazzola sul colle dove era costruita la casa. «Dimmi dove hai messo il cadavere», disse il brigadiere Antonio Vagarolli. Era un brigadiere piccolo e dall’aria molto acida. «Io non ho visto nessun cadavere», disse Donatello. «Senti, disgraziato», disse il brigadiere Vagarolli, «anche la tua ragazza dice così, che non ha visto nessun cadavere, che non ha visto niente...» «Non ho visto niente.» «Non farmi perdere la pazienza», urlò il brigadiere Vagarolli. «Dimmi dove hai messo il morto o ti rompo tutti i denti uno per uno e a ventun anni avrai una bella dentiera. Sul tetto della casa della tua ragazza c’era un morto ammazzato con un coltello in gola lungo così, noi andiamo a prenderlo e non lo troviamo più. Dove lo hai messo, disgraziato?» «Io non so niente.» Cercò di ripararsi il viso, ma non fece in tempo, gli schiaffi a taglio del brigadiere Vagarolli gli arrivarono in piena faccia, dal naso sprizzò subito sangue, un orecchio colpito in pieno cominciò a friggere nel cervello come una radio durante un temporale. «Cretino, cerca di capire, io ti ammazzo se non mi dici dove hai messo il morto. Era sul tetto, e non l’abbiamo trovato. Parla o sei finito.» Con una mano al naso che gocciava sangue, lui ripeté: «Io non ho visto niente, non so niente». Il brigadiere Vagarolli si sedette, cercando di calmarsi. «Senti ancora, povero disgraziato che non sei altro. Questa notte verso le quattro una donna sui trent’anni, nativa di Canzo, si chiama Adele e ha un negozio di merceria, è andata dai carabinieri e ha detto che a Canzo a Monte, nella Villa del Somarello, dove aveva un appuntamento con el Pinin, ha ammazzato el Pinin, appunto, perché lui la ricattava e le mangiava tutti i soldi del negozio. Ha detto che ha preso un coltello e d’improvviso gliel’ha ficcato in gola, è una donna grossa, robusta, il doppio di el Pinin, poi ha preso el Pinin e l’ha messo sul tetto, e dopo le è venuto il rimorso ed è andata a costituirsi ai carabinieri. Per questo i carabinieri sono venuti su alla Villa del Somarello, mentre voi eravate lì a ronfare, tu e la tua ragazza. El Pinin portava le sue donne quasi sempre in qualche casa o villa di milanesi. Mi stai ascoltando?» «Sì, ma io non ho visto niente.» «Va bene, tu non hai visto niente», disse il brigadiere, stringendo un po’ le labbra, «ma sta’ a sentire che cosa succede se tu non mi dici la verità. Sta’ a sentire bene, disgraziato, perché sei un disgraziato. C’è una tale che dice: “Io ho ammazzato el Pinin con un coltello in gola e l’ho messo sul tetto della Villa del Somarello”. I carabinieri vanno alla Villa del Somarello e non trovano nessun Pinin morto accoltellato, quindi il giudice istruttore dice: visionaria, mitomane sessuale. Però nella Villa del Somarello c’eri tu, che avevi dei vecchi rancori col Pinin. E siccome el Pinin è scomparso, e un giorno o l’altro, magari fra qualche settimana, lo ritroveremo, ucciso, diranno: “È stato Sandrone Donatello”. E tu sarai finito...» «Io non so niente.» «Va bene, disgraziato, tu non sai niente», disse acido il brigadiere. «Allora ti dico io come sono andate le cose. Ti conosco. Sei un povero disgraziato, niente altro.» Lo costrinse a sedere nella poltroncina davanti alla scrivania e sedette lui sulla scrivania. «Sei andato con la tua ragazza, nella casa che il padre di lei ha a Canzo. Tu sei di Canzo, lei fin da bambina viene in vacanza a Canzo, el Pinin è di Canzo, non c’è nulla di straordinario che tu entri nella Villa del Somarello e dopo un po’ scopri che sul tetto c’è il Pinin, il tuo accusatore, quello che ti ha mandato dentro. Allora cosa pensi? Pensi: se trovano qui questo cadavere, pensano che sono stato io ad ammazzarlo. E allora che cosa fai? Lo porti giù dal tetto e vai a buttarlo via, lontano dalla Villa del Somarello, lontano il più possibile, perché nessuno possa pensare che sia stato tu. Va bene, ti capisco, ma adesso cerca di capire tu che c’è una donna che si è accusata lei di aver ucciso el Pinin, quindi tu non c’entri, basta solo che dici dove hai messo il cadavere...» Donatello abbassò il capo. I poliziotti fanno tanti tranelli, dicono una cosa per farti parlare e invece la cosa non è vera. «Io non ho visto niente», ripeté. Contenendo il suo furore, il brigadiere assentì col capo, poi disse, con irosa calma: «Va bene», alzandosi e scendendo dalla scrivania. «Non hai più nessuna fiducia nella legge, nella giustizia. Ti capisco. Ti capisco davvero.» Gli mise una mano sulla spalla. «Va’, sei libero. Potrei tenerti dentro anche dei mesi, per occultamento di cadavere, ma lascio perdere. Va’. In corridoio c’è la tua ragazza, andate a farvi benedire tutti e due, disgraziati che non siete altro. Se tu mi avessi detto dove hai nascosto il morto, risparmierei settimane di ricerche in tutto il Canzese. Pazienza. Mi arrangerò da me.» Lo sospinse verso la porta. «Va’, sei libero.» Gli aprì la porta, alzò la voce: «Fuori!». Nel corridoio c’era lei, Irene, vicino a un agente. Ma lui non uscì, anzi, rientrò nell’ufficio del brigadiere e chiuse la porta. Poi disse, con voce ben chiara, nitida: «Ho trovato un Corriere della Sera di ieri in una stanza. Questo voleva dire che c’era stato qualcuno nella casa. Allora siamo andati a vedere e abbiamo trovato el Pinin sul tetto. Ho avuto paura che dessero a me la colpa di averlo ucciso. Allora l’ho nascosto, come ha immaginato lei, signor brigadiere. L’ho buttato nella Buca dei Cani, dal monte che dà su Asso». Il brigadiere Vagarolli riaprì la porta che dava sul corridoio, così lui, Donatello, poté vedere ancora Irene, ferma nel corridoio vicino all’agente. «Lo sapevo che era così. Adesso risparmiamo tempo nelle ricerche. Va’. Non andate troppo lontano, ci sarà un processo e parecchie storie, ma cercherò di aiutarvi.» Lo spinse fuori. «Sei un bravo ragazzo...» Gli disse così, non come l’altra volta che gli aveva detto: Sandrone Donatello, di professione farabutto. 22 · Qualcuno non si diverte Il pubblico continuava a ridere e i due comici sul palcoscenico dovevano interrompersi, aspettare che tornasse un poco di silenzio e poi riprendere. Facevano la parodia di una scuola di recitazione. Quello piccolissimo, con le code del frac che gli toccavano terra, era il maestro, quello lungo, con i polsini che gli arrivavano ai gomiti e gli occhiali che gli conglobavano le orecchie, era l’allievo. «Ma no, scusi: è tutto sbagliato», disse il maestro. «La sua è la parte di un marito che torna improvvisamente da un viaggio, entra in casa, e trova sua moglie a letto con un altro. Siccome è un tipo amaro, sbotta in una risata amara, fa: ih, ih, vedendo i due... Ha capito?...» «Si», disse l’allievo, «eh, eh...» «Ma che ih, ih, lei ha fatto eh, eh...» disse il maestro, e il pubblico rise forte. «Lei non ha fantasia. Lei deve immaginare che lì, in quell’angolo, ci sia la sua stanza da letto, il talamo nuziale...» il pubblico continuava a ridere, sempre più forte. «E lei, tornando improvvisamente da un viaggio, trova sua moglie a letto con un altro. Allora fa ih, ih...» «Eh, eh...» disse l’allievo. «No, ih, ih», disse il maestro, il pubblico rideva fortissimo. «Lei non ha il senso della gelosia né dell’amarezza: ih, ih, non eh, eh...» A furia di ridere, qualcuno del pubblico tossiva, strozzandosi. «Eh, eh...» ripeté l’allievo. «A me non viene di fare ih, ih se trovo mia moglie a letto con un altro...» Il pubblico tempestava. Tutti ridevano. Non tutti. Tutti meno uno. Meno lui in una poltrona all’undicesima fila del cinema-teatro rionale dove si era rifugiato, appunto dopo aver trovato sua moglie a letto con un altro. Era scappato per non commettere inutili pazzie, inutili violenze. Però, non era proprio sicuro di non averne commesse, come s’era rotto le nocche di quella mano? Aveva molta confusione in testa. Non ricordava neppure se avesse fatto ih, ih oppure eh, eh. Non era sicuro di niente, o quasi. L’unica cosa di cui era sicuro, era che non riusciva assolutamente a ridere, non si divertiva affatto. Succhiò il sangue sulle nocche rotte della mano destra. 23 · Intanto va’ dentro «Le hai rotto due denti e fatto un occhio nero», disse il commissario, e si fece vento con una cartolina postale che aveva sulla scrivania, perché dalla finestra, anche se dava sul mare, non veniva aria, solo caldo, fermo, come un fermo ferro da stiro rovente. «Non si picchia così una povera ragazza. Che ti aveva fatto?...» Lui, a torso nudo, in calzoncini da bagno, appena portato lì dal poliziotto, dopo la scenata sulla spiaggia, stava a capo basso. «Si era messa il due pezzi», disse, «gliel’avevo detto che se si metteva il due pezzi era peggio per lei.» «E allora, se sei geloso, vatti a cercare una che porta il paltò anche al mare, ma non devi mandare all’ospedale quelle che si mettono in due pezzi...» disse il commissario. «Ce ne sono a centinaia sulla spiaggia, che portano il due pezzi, se tutti le dovessero prendere a pugni, addio.» «Per lei è diverso», disse il giovanotto, cocciuto, peloso, ancora cosparso, qua e là, di sabbia. «Perché è diverso?» disse il commissario agitando la cartolina postale. Lui non rispose subito, poi disse, rauco: «Perché fa lo spogliarello, ecco perché». Il commissario smise di farsi vento con la cartolina. «Eh?» disse. Poi si riprese. «Ma se lavora agli spettacoli di spogliarello dovresti essere abituato che la vedano un po’ svestita, o dico male?» Riprese a farsi vento. «No, è diverso», disse lui, cocciuto, velloso e sabbioso. «Lì è lavoro, quando fa lo strip è come me quando vado in ufficio, per la paga. Ma qui al mare con me gliel’ho detto: stai coperta, se no va a finir male... Lei invece si è messa quasi al nudo per farsi vedere, anche se non è lavoro, e io allora gliele ho date. È diverso, quando fa lo spogliarello...» insisté. Erano ragionamenti troppo sottili per il commissario, con tutto quel caldo. «Intanto va’ dentro», gli disse per troncare. 24 · La strega «Quanto vuole, signorina?» Il capo degli Uffici Acquisti non era un delicato diplomatico, ma avevano mandato lui dalla ragazza perché sapeva trattare gli affari, non più di due milioni, gli avevano detto, quella ragazza è una strega che mira solo ai soldi, e lui non si sarebbe lasciato prendere dalle smorfie e dagli occhi umidi di lacrime della strega. La ragazza scosse la testa, disperata: «Io non posso lasciarlo, io gli voglio bene...». Non era vero che gli voleva bene, lei lo sapeva, ma aveva tanti soldi quel ragazzo, non ne aveva mai visti tanti, una sera aveva pagato cinquemila lire tre rose, in un locale notturno, per darle a lei. «Così non combiniamo nulla, signorina», disse il capo degli Uffici Acquisti. Doveva strappare Arimanti dalle braccia di quella strega. Il portiere si stava istupidendo con lei, non faceva quasi più allenamenti, non voleva andare ai ritiri, e l’ultima partita si era beccato due goal che li avrebbe parati anche una vecchia zia. «Mi dica quanto vuole, e vedrà che ci guadagniamo tutti e due», insisté, era disposto ad arrivare anche a tre milioni, ma bisognava salvare la squadra. La strega alzò il capo, ora rabbiosa. Volevano comprarla? E allora l’avrebbero pagata cara, pensò alla cifra più alta cui riusciva a pensare. «Centomila lire», disse. Veniva da un paese dove con quella somma una famiglia viveva tre mesi. Centomila lire per lasciare per sempre quel ragazzo e tornarsene al paese, se no lì in città finiva per rovinarsi davvero. All’udire quella cifra, il capo degli Uffici Acquisti si accorse che la strega era solo una povera montanara, una ragazzina sciocca, scesa per sbaglio dal suo altopiano. Arimanti l’avrebbe dimenticata subito. «Va bene, le firmo l’assegno», disse con freddezza solo apparente. 25 · Zampa di Giaguaro e Nuvola Rosa Il giovanotto si mise la giacca e finì di accomodarsi il nodo della cravatta, dallo specchio vedeva la ragazza, seminuda sul letto, bella, ma un poco cara, comunque levò il portafoglio e mise i due biglietti, discretamente, sulla sedia, vicino alla sua vestaglia e alle sue calze; e solo allora vide, chi sa perché non l’aveva vista prima, la profonda cicatrice che lei aveva al braccio destro. «Cos’è?» disse. Il viso di lei s’indurì, divenne buio. «Niente», disse. Glielo domandavano tutti, chi prima e chi dopo, con quell’aria cretina, e le riaprivano crudelmente i grandi portali del passato: Enzo, ragazzo, a torso nudo, un gonnellino di tela cerata alle reni, il nastro rosso attorno alla fronte con una sola penna di tacchino tenuta dal nastro, e il grande arco che si era fabbricato lui stesso, con la lunga freccia con un chiodo in punta; era Zampa di Giaguaro e nel gioco agli indiani aveva sgominato tutti i bianchi, era rimasta solo lei, la fragile bianca che lui chiamava Nuvola Rosa, sfuggita al massacro dei Comanches, e correva per la boscaglia, quel poco d’erbaccia alla periferia, gridando anche di paura vera non solo per gioco, inseguita dall’invincibile Zampa di Giaguaro che dopo averle urlato terribilmente di fermarsi si era inginocchiato e aveva teso l’arco fabbricato nelle lunghe ore in cui avrebbe dovuto studiare, aveva mirato e l’aveva colpita, lì, al braccio, e al suo primo urlo di dolore, le era corso vicino, l’aveva favolosamente, incredibilmente abbracciata e baciata e aveva pianto e si era dato pugni in viso per il rimorso: «Nuvola Rosa, Nuvola Rosa...». L’aveva chiamata, e di tutto il favoloso incredibile tempo, non era rimasto niente di niente. C’erano solo cretini come quello che domandavano cos’era la cicatrice, e le ventimila lire mezzo nascoste fra la vestaglia e le calze sulla sedia. 26 · Come i gatti Il cavalletto era sistemato all’interno della stanza, quasi in mezzo, era molto simile a un robusto treppiedi da fotografo, ma non sosteneva una macchina fotografica, sosteneva un Winchester M. 2 semiautomatico, una delle più potenti carabine moderne. E sulla canna era montato il cannocchiale, e la carabina era puntata verso la finestra e prendeva d’infilata corso di Porta Nuova, a quell’ora di mezzogiorno così piena di sole. Faceva molto caldo. Paolo si mise al calcio del Winchester e guardò attraverso il cannocchiale, spostando lentamente l’arma. Si vedeva nitidamente a oltre duecento metri, lesse senza fatica un manifesto che invitava a uno sciopero, manovrando col calcio del fucile si ravvicinò a cinquanta metri, quasi all’altezza del bar, e inquadrò un barboncino bianco tenuto al guinzaglio da una donna di cui vedeva soltanto le gambe, molto belle, si passò la lingua sulle labbra e seguì quelle gambe, spostando il Winchester, quando quelle gambe attraversarono la strada, seguite dal barboncino bianco, per andare sul marciapiede opposto, e d’un tratto con un colpo brusco abbassò il calcio del fucile per alzare il cannocchiale in modo da poter vedere il viso di quelle gambe. Maledetta, adesso stava di profilo e vide solo la lunga banda nera dei suoi capelli, ma per un attimo, nitidissime, intravide le labbra di un rosso mattone, pronunziate, e allora ebbe più caldo, poi vide, sfocato, il muro della casa di fronte, gambe e labbra erano uscite dall’angolo visuale del cannocchiale. Riportò la carabina in posizione da dominare ancora, centralmente, corso di Porta Nuova. Nessuno poteva vederlo, sia perché il Winchester era sistemato all’interno della stanza, sia perché la serranda della finestra era abbassata quasi a venti centimetri dal davanzale della finestra, ma lui con quel cannocchiale mirava a oltre duecento metri e adesso distinse nettamente l’orologio al polso, col quadrante nero, di un giovanotto che teneva il braccio fuori del finestrino dell’auto e se fosse andato più piano avrebbe potuto quasi leggere l’ora. A proposito: guardò l’ora al suo orologio, era mezzogiorno passato da pochi minuti. Di solito Tullio Marone Isombardi veniva a prendere Beatrice pochi minuti prima dell’una, cioè quando lei finiva il suo orario. Veniva dai Bastioni con la sua Abarth nera che usava per i piccoli giri in città e si fermava lungo il marciapiede, in sosta vietata, ma Tullio Marone non era persona che usasse spendere il suo tempo nel leggere la segnaletica stradale, e restava al volante, e qualche minuto dopo dal bar dall’altra parte della strada usciva Beatrice, sedeva vicino a lui, torcendosi gentile come una gatta gentile addosso a lui, li aveva visti tante volte a occhio nudo, e questa volta li avrebbe visti meglio con quel cannocchiale. Non che Tullio Marone venisse tutti i giorni, poteva passare anche una settimana senza che si vedesse e allora Beatrice usciva dal bar e se ne andava in via dei Giardini a prendere il filobus. Comunque adesso era appena mezzogiorno, e faceva in tempo a scendere al bar a bere l’aperitivo. Si staccò dalla carabina e dal cannocchiale come con un certo rimpianto, svitò una leva del cavalletto e sbloccò il Winchester dal gancio, poi, come gli aveva insegnato il sergente O’Hirt, dette un colpo secco col taglio della mano sul bottone a molla a metà dell’arma tra il calcio e la canna: la carabina si piegò in due, ormai stava benissimo in una qualunque sacca da viaggio, insieme col treppiedi che rientrò sulle sue gambe fino a ridursi della misura di uno di quegli ombrellini da donna che si portano al polso. E la sacca era già lì, era la sacca delle gite di fine settimana, la sacca tranquilla con dentro il pigiama, la busta col sapone e il dentifricio e il rasoio, in quella sacca però adesso c’era un Winchester M.2, quello in dotazione alla NATO col quale si potevano sparare dai cinquanta ai sessanta colpi al minuto, alla distanza anche di duecento metri, pesava 2 chili e 700 grammi, era di calibro 7,62 e, nelle mani di un esperto, era più temibile di un mitra. Paolo non era un esperto ma, per quello che doveva fare, il sergente O’Hirt gli aveva insegnato abbastanza. Mise un paio di maglie sulla sacca, poi tirò la chiusura lampo, mise la sacca nell’armadio, chiuse a chiave l’armadio, mise la chiave nel gancio del portachiave che teneva nella tasca sinistra dei calzoni, e uscì dalla stanza. Erano le dodici e otto minuti. «Torno subito», disse a Michelina, la vecchia domestica. Dette un’occhiata nello specchio dell’anticamera chiuso in una severa cornice ovale di legno scuro: il grigio così chiaro gli stava bene, la cravatta color terra di Siena aveva una somiglianza di tonalità coi suoi capelli, non era alto, questo no, lo sapeva benissimo, era un poco, anche se assai poco, inferiore alla media, e non erano poche le ragazze più alte di lui. Però era un Donati Sorel: Paolo Donati Sorel. «Sì, dottore», disse Michelina aprendogli le portine dell’ascensore interno. «Se telefona mamma, per cortesia, le dica che richiamo io», disse alla vecchia domestica dall’interno della cabina. Mamma era a Sanremo e telefonava due volte al giorno e se non lo trovava aveva le crisi. «Sì, dottore», disse Michelina. Fuori, via Annunciata era in ombra, ma appena attraversata la strada, in corso di Porta Nuova, il sole lo schiacciò come un ferro da stiro rovente, restò correttamente rigido, non si affrettò, ma si sentì meglio quando raggiunse il bar ed entrò nell’ombra freddolina di aria condizionata del locale. «Un Cointreau», disse mettendo il biglietto da mille sul vassoietto della cassa. Non alzò lo sguardo, non aveva bisogno di guardarla in viso per sapere che era Beatrice, ne sentiva le onde sensuali, come lui fosse un transistor che riceve dei segnali, era venuto per sentirla, più che per guardarla, prima di ucciderla. «Corretto gin», aggiunse, ma lei aveva già battuto lo scontrino, perché sapeva già che cosa avrebbe ordinato, dato che da quando lei aveva cominciato a lavorare lì come cassiera lui non beveva che Cointreau corretto gin. Con la sua grassoccia, sensuale mano gli dette il resto, tutto in monete da cento. Si fermò nel caffè quasi mezz’ora, come faceva sempre, col bicchiere di Cointreau tintinnante di ghiaccio in mano, cercando di guardare Beatrice quando lei non sapeva di essere guardata: non era bella, c’era qualche cosa, nella struttura fisica, di tozzo, di volgare, ma era un’esplosione di femminilità, non si poteva essere più donne di come era donna lei. Vi erano degli idioti, li aveva sentiti, lì, al caffè, che dicevano che era brutta; forse, secondo Botticelli, avevano ragione, ma bisognava essere degli incapaci per non sussultare appena muoveva per caso il braccio indietro così che il seno d’improvviso si sollevava ancor più di quanto già era sollevato. “Sei un maniaco sessuale”, si disse finendo il primo Cointreau, seduto nel caffè deserto, c’era solo lui, il barista, e lei: Beatrice. “Sì, sono un maniaco sessuale, non è che una volgarissima sciacquapiatti, però oltre che a me è piaciuta a Tullio Marone. Ma quello te le ha sempre portate via per dispetto, appena vede una con te, chiunque sia, te la porta via.” Andò alla cassa a prendere lo scontrino per un altro Cointreau, guardò la mano di lei che gli dava il resto e sentì come se quella mano lo carezzasse sul collo, e allora, intenerito, alzò il viso per guardarla. Sperò che sorridesse, ecco, almeno un sorriso, ma lei non sapeva, in quel momento, che sarebbe stato meglio sorridere a quel piccolo, per non morire, come avrebbe potuto saperlo? anzi restò col volto rigido, indispettito da quel suo sguardo. “Bene”, lui pensò prendendo il resto dal vassoietto, “fra venti minuti sei un cadavere.” Gli sarebbe bastato un sorriso. Andò col suo bicchiere di Cointreau al tavolino in fondo al bar e pensò che doveva calmarsi e lasciar perdere; era stato un bel divertimento farsi dare il Winchester dal sergente O’Hirt, e anche provarlo alla finestra, per giorni e giorni, ma sparare davvero era diverso. Paolo Donati Sorel non poteva rovinarsi per una sciacquapiatti, che andasse pure con tutti i Tulli Maroni che voleva. Era assurdo scoppiare solo per quei 60 chili di carne di sesso femminile. “Sì”, si disse bevendo un altro sorso di Cointreau nel caffè deserto e silenzioso in quell’ora bollente. Sì, voleva dire che avrebbe riportato subito il Winchester al sergente. O’Hirt e poi, visto che era un maniaco sessuale, avrebbe cercato altre donne, ce ne erano tante, il mondo ne era pieno. Infatti, proprio in quel momento, entrarono quattro studentesse con vistosi fagotti di libri sulle braccia, la più anziana non aveva sedici anni; col bicchiere in mano e il capo basso, lui guardava con abilità le ragazze, pur essendo del tutto normali, se non bruttine, c’era in ciascuna un particolare bruciante: gli occhi impudenti della brunetta vestita di rosso che beveva un succo di pomodoro: lei non sapeva che il suo sguardo era impudente, specialmente quando guardava gli uomini, erano decine di millenni di femminilità che le dettavano quel modo di guardare gli uomini, se era colpa, non era sua colpa, ma della geobiologia, della zoologia, dell’antropologia. E il nasino carnoso di quella quindicenne che rideva arricciando, appunto, il piccolo naso, come un cucciolo che gioca col padrone e tutto questo indicava un temperamento amorosamente battagliero e portato agli uomini. E non insisté a guardare il seno di quella che doveva essere la più anziana, anche se la meno bella, un maniaco sessuale deve sapersi controllare. C’erano troppe donne nel mondo, era idiota tagliarsi le gambe per una sciacquapiatti qualsiasi. Che Tullio Marone se la tenesse, presto la puzza di sciacquatura di piatti sarebbe arrivata fino a lui. Si alzò, posò il bicchiere vuoto sul banco del bar e andò ancora alla cassa, guardò un momento il dietro di una delle studentesse che stavano uscendo e disse a lei, Beatrice: «Un Cointreau corretto gin». Lei aveva già battuto lo scontrino e glielo dette, lui non aveva più spiccioli, dal portafoglio levò un biglietto da diecimila e mentre lei contava il resto per darglielo, quasi barcollando, non per quello che aveva bevuto, ma sotto le ondate che lei gli trasmetteva e che gli facevano perdere ogni dignità, le disse: «Ti porto a casa io, oggi, vieni, Beatrice». «Sei, sette, otto, nove, dieci», contò lei, dandogli il resto, e poi: «No». Lui prese i biglietti da mille, le monete di metallo, andò al banco e disse al barista: «Un Cointreau, corretto gin». Cercò di ingoiare l’orrenda umiliazione di quel no, oh, fosse stato soltanto un no, era stato un «basta», volgarissimo, era stato un «ma non hai ancora capito che è no», e del resto glielo aveva già detto quella sera in auto: «Ma stai fermo con queste mani e portami a casa, non mi piacciono i nanetti». «E allora perché sei salita in macchina?» «Perché piove, nanetto, e per andare a casa devo prendere due tram.» Col bicchiere di Cointreau in mano ritornò al suo tavolino, beveva rapido, un sorso dopo l’altro. Guardò l’orologio: erano le 12 e 35, guardò senza timidezze o inquietudini lei, Beatrice, chiusa nel chioschetto della cassa, monumento sessuale di cui sentiva sempre, come un transistor, le onde di femminilità, onde che però adesso si convertivano, anziché in amore, in odio. “Sei morta”, pensò, “fra venti, venticinque minuti.” Aveva finito il Cointreau, si alzò, depose il bicchiere sul banco del bar e uscì, nell’aria che era come metallo. Gli bastò attraversare la strada e fu davanti al portone di casa sua, in via Annunciata. «Ha telefonato mamma?...» disse a Michelina. «No, dottore», disse la vecchia. Entrò nella sua stanza, studio, salotto, camera da letto, quando non aveva voglia di isolarsi nella faraonica stanza del peccato, con quel letto così vasto, come la chiamava, perché era solo e gli bastava il divano sotto l’arazzo rappresentante ninfe e fauni, in settecentesche, ambigue giaciture. Con la chiave aprì l’armadio, dall’armadio levò la sacca, tirò la chiusura lampo per aprirla, levò le due maglie di copertura e tirò fuori il Winchester e il treppiedi. Con un colpo secco, il sergente O’Hirt aveva insistito: «Un Winchester non è una signorina da accarezzare sulle chiome, va trattato a colpi secchi, certe volte mi arrivano delle reclute tubercolose che danno dei colpettini da ridere, tossicchiando, il Winchester non si monta e non si smonta coi colpettini: ci vuole un taglio secco, così», e lui dette il taglio secco, nel punto esatto e il Winchester, con un sonoro scatto metallico, si ricompose in tutta la sua lunghezza. Poi allungò il treppiedi, ne regolò l’altezza sul misuratore e fermò la livella al numero 27 che era l’altezza esatta, dopo prove di molti giorni, e quindi fece scattare il gancio sulla testa del treppiedi e nel gancio ad H infilò il Winchester e subito controllò al cannocchiale se la posizione era giusta. Era giusta, perfetta: la carabina prendeva d’infilata corso di Porta Nuova, esattamente al centro, sull’estremo limite di destra del campo visuale si vedevano le due porte d’ingresso del caffè dal quale sarebbe uscita Beatrice, e a sinistra del campo visivo c’era il paletto col segnale di sosta vietata sotto cui regolarmente sostava l’Abarth di Tullio Marone. Abbassò ancora un poco la canna dell’arma. Guardò l’orologio, erano le dodici e quarantanove. Si accese una sigaretta e, mentre l’accendeva, suonò il telefono. Era Michelina. «La signora la chiama da Sanremo, le passo la comunicazione.» «Sì, grazie.» Aspettò, fumando, e guardando il Winchester. E sudando per le vampate di caldo che entravano dalla finestra aperta. «Paolo...» «Sì, mamma.» «Oh Paolo, è successa una cosa terribile.» Per mamma tutto era terribile, non accadeva nulla nella vita che non fosse terribile. «Sta’ calma, mamma.» «Oh, è terribile davvero, Paolo, mi vergogno a dirtelo, ma mi sono dimenticata che oggi è il quinto anniversario della morte di tuo padre. Sarei venuta a portargli un po’ di fiori, a guardare il ritratto, oh, Paolo, mi vergogno, mi vergogno, ma sono vecchia e non ho più memoria, per niente...» «Mamma, sta’ calma, prenderò io i fiori per papà.» «Oh, sì, Paolo, ma valle a prendere tu, le rose rosa.» La voce di mamma si spezzò, come stesse per piangere, si spezzava spesso, ma non piangeva mai, Paolo non conosceva nessuna persona più gelida e calcolatrice di sua madre, infatti era l’unica giocatrice fissa di Sanremo che coi suoi sistemi e sistemini riuscisse a guadagnarsi la settimana. «Sì, mamma, le vado a prendere io, le rose rosa», erano quelle che piacevano a papà. «Come stai, mamma?» «Va tutto storto, Paolo, non solo ieri sera ho perso sempre, ma ho finito anche il libretto degli assegni, ho telefonato in banca a Milano ma mi hanno detto che fino a domani non possono farmi avere un libretto di assegni nuovo.» La voce le si spezzò ancora. «Così stasera non posso neppure giocare.» «Ma fatti prestare qualche cosa dalla direzione dell’albergo, mamma...» «L’ho fatto, Paolo, mi hanno dato solo centomila lire, mi hanno detto che il regolamento vieta prestiti superiori.» Questa volta sembrava davvero che stesse per piangere. «Con centomila lire, se va male, gioco solo dieci minuti.» «Su, mamma, non fare così, domani ti arriva il libretto degli assegni.» Schiacciò il mozzicone della sigaretta nel portacenere. «Senti, per favore, hai potuto parlare col colonnello Drew?» «Oh, vedi come sono vecchia, non ho più memoria, nessuna memoria, certo che ho parlato col colonnello Drew e lui ha già firmato il congedo per il sergente O’Hirt, volevo telefonare per dirtelo, poi me ne sono dimenticata.» La lasciò parlare, ma guardava inquieto l’orologio: le dodici e cinquantacinque, le dodici e cinquantasette, alle dodici e cinquantanove poté riattaccare il ricevitore e si mise subito dietro il Winchester e guardò nel cannocchiale. L’Abarth di Tullio Marone Isombardi era lì, sotto al segnale di sosta vietata. Tullio Marone era al volante e aspettava. Attraverso il cannocchiale ne vedeva la faccia, meglio che se gli fosse stato davanti, a parlare insieme, e quella faccia, in qualunque modo l’avesse vista, col cannocchiale o a occhio nudo, aveva sempre destato in lui ricordi spiacevoli o umilianti. E guardandolo, guardando quella faccia, spinse lo scorrevole della sicura e sbloccò il grilletto: adesso sarebbe bastato anche soltanto soffiare sul grilletto e il colpo sarebbe partito. Odiava quella faccia perché sembrava quella di un grande uomo, di un capo, uno guardava Tullio Marone e sentiva subito che era un comandante, anche se così giovane, e la odiava, appunto, perché lui comandava, comandava anche lui, gli aveva sempre fatto fare le cose che voleva lui, andare a una festa piuttosto che a un’altra, perfino comprare l’orologio di una marca e non di un’altra. E odiava quella faccia perché era una faccia che piaceva alle donne, le donne lo vedevano e cominciavano a corrergli appresso, lasciavano tutto, marito, fidanzato, amante, e anche figli. A lui portava via regolarmente le ragazze, era arrivato al punto di dirglielo, sfottente: «Non hai ancora capito che non devi farti vedere da me in giro con una donna?». Beatrice non era che l’ultimo caso, il più clamoroso perché ci si era messa anche la volgarità della donna che lo aveva chiamato nanetto. Bene: adesso il nanetto sparava. Guardò l’orologio. Le tredici e due minuti. Tornò a guardare nel cannocchiale: Tullio Marone fumava quieto seduto al volante, ogni tanto guardava verso il caffè, e alle tredici e cinque minuti Beatrice, in uno stretto vestito bianco, a grandi fiori neri e gialli, uscì dal caffè, attraversò la strada ancheggiando e lui seguì col cannocchiale il morbido movimento dei fianchi di lei coperti da quelle macchie nere e gialle e la vide salire sull’Abarth vicino a Tullio Marone. Adesso bisognava fare presto, prima che la macchina ripartisse, e Tullio aveva le partenze rapide. Fece presto, l’occhio incollato al cannocchiale sfiorò il grilletto e partirono due colpi, uno dopo l’altro. Era proprio peggio di un mitra, non l’avrebbe mai immaginato. I due colpi polverizzarono il cristallo del parabrezza, per un attimo non vide nulla, poi i frantumi di plastica si sciolsero, si volatizzarono, e oltre il vuoto lasciato dal parabrezza comparve nitidissimo sotto la lente, come sotto un microscopio, il viso sanguinolente di Tullio Marone, o quelli che erano i resti di quella faccia odiosa di comandante, che ormai non comandava più nulla, irrimediabilmente morto. Vicino a lui, nel fondo nitido luminoso come un cinemascope del cannocchiale, vide Beatrice che gli aveva messo una mano sul petto per sostenerlo e che ora si guardava, inorridita, la mano colante sangue, come l’avesse immersa in un barattolo di vernice rossa. «Nanetto. Perché pioveva e devo prendere due tram per andare a casa, ecco perché sono salita in auto con te. Nanetto.» Il morbido viso di lei era inquadrato in fondo al cannocchiale, la crocetta di collimazione centrava proprio lo spazio tra lo zigomo e l’orecchio destro. Il sergente O’Hirt gli aveva detto di far piano: «Ecco, in questo, sì, il Winchester assomiglia a una bella donna sensibile: appena la sfiora salta su. Più tocca forte, più il Winchester spara colpi, se vuole sparare solo un colpo o due deve appena sfiorare il grilletto.» Lo sfiorò appena, tenendo l’occhio attaccato al cannocchiale e vide il viso di Beatrice diventare una rosa rossa, come in certe pubblicità a colori, al cinema. Solo che qui non si trattava di pubblicità: la rosa era di sangue. Si staccò di colpo dalla carabina, andò alla finestra e lentamente abbassò tutta la tapparella. Non voleva vedere; era un maniaco sessuale, non un assassino e non un sadico. E del resto era facile immaginare quello che stava succedendo. Cominciava a tremare, si vide le mani tremare mentre staccava il Winchester M.2 dal suo treppiedi, e lo aveva preveduto, ma sarebbe passato, il tremito, con del Cointreau. Il sergente O’Hirt lo aveva detto: «Anche se il cinghiale vi passa davanti correndo con tutte le sue gambe, e lei non ha mai visto un’arma, neppure una sputapalle di ovatta, pure, dottore, lei, con un Winchester fisso sul suo cavalletto, non può sbagliare, il cinghiale cade fulminato appena spara se passa in fondo al cannocchiale», perché ovviamente avevano parlato di caccia al cinghiale, e il sergente O’Hirt era troppo educato per mettere in dubbio le parole di un giovane gentiluomo milanese. E infatti non aveva sbagliato, neppure lui che non aveva mai sparato neppure ai tirassegni del luna park. Tremando dette il colpo secco, col taglio della destra, al punto giusto, e la carabina gli si divise in due tra le braccia, la mise nell’apposito astuccio e solo allora si ricordò di spegnere la radio che aveva lasciato accesa piuttosto alta per coprire il secco tec tec del Winchester. Con mani tremanti fece rientrare il treppiedi, lo ripose nel suo astuccio, mise l’astuccio nella sacca, insieme con l’astuccio del Winchester; mise nella sacca, questa volta, invece che le maglie, sopra al Winchester e al treppiedi, una ventina di pacchetti di sigarette Camel che aveva già preparato. Tirò la chiusura lampo, mise la sacca nell’armadio, chiuse a chiave l’armadio, si mise la chiave in tasca, aprì la porta, uscì nel corridoio, le mani che gli tremavano, e anche il passo era come tremante, ma si controllò; dalla finestra, sia pure con le tapparelle abbassate, veniva un vocio confuso e nervoso: era normale, ma chiuse la porta dello studio salotto, e non lo udì più. Andò in sala da pranzo, suonò il campanello, si preparò un Cointreau, lo bevve a piccoli sorsi cercando di contenere il tremito della mano, gli pareva di sentire ancora del vocio dalla strada, ma non era possibile, la sala da pranzo dava dall’altra parte sui giardini di via Giardini. Comparve Michelina. «Porto subito, dottore.» Fece colazione, cioè col cucchiaio sminuzzò il midollo di bue contenuto nel brodo ristretto, senza assaggiarlo neppure; poi tagliuzzò la sogliola, senza mangiarne un filo, mangiò invece l’insalata di rapa cruda alla Graubünden, quel sapore fresco, pepato della rapa immersa nella senape, lo sollevò un poco dalla prostrazione della paura. E bevette molto vino, un onesto chiaretto veneto di vigne di suoi amici che alla fine gli fece passare il tremito. E quando il tremito fu passato guardò il quadro di suo padre. Era a grandezza naturale, ed era stato dipinto da Sciltian, e stava in fondo alla troppo vasta sala da pranzo, vicino al finestrone più grande da cui il dipinto, già paurosamente somigliante e veridico, riceveva una luce che gli dava un rilievo, e a volte sembrava perfino un movimento, come se suo padre intendesse scavalcare la cornice e venire a sedersi a tavola, la sua inflessibile aria di inquisitore, lo sguardo inflessibile di un Donati Sorel. “Sì, papà”, pensò guardandolo, “sono un anormale e un delinquente. Avevi ragione.” Bevette ancora un po’ di chiaretto e lo guardò ancora. “E anche un bastardo.” Suo padre gli aveva detto queste cose quando lui aveva quattordici anni, prima di mandarlo a studiare a Londra. Gli aveva detto che non era a Londra che avrebbe dovuto mandarlo, ma a un riformatorio, e gli aveva detto che non solo era un anormale e un delinquente, ma anche un bastardo, perché sua madre era una così e così, e non aveva usato eufemismi, e quindi lui non poteva essere che un bastardo, figlio di un qualsiasi giardiniere, o autista, o bagnino che sua madre doveva aver intrattenuto brevemente, e questo discorso che si era sentito fare a quattordici anni era rimasto dentro di lui. Era cresciuto, con quelle parole-pallottole in corpo, anormale, delinquente, bastardo, e figlio di così e così, si era anche divertito, ma le parole pallottole c’erano sempre. Suonò il piccolo campanello di porcellana. “Sì, papà, sono un anormale, un delinquente e un bastardo”, pensò. “Ora ne hai la prova.” Michelina entrò. «Per cortesia, Michelina, portami il telefono.» «Sì, dottore.» Il volto della vecchia, grassoccia e flaccida donna, sembrava un poco alterato. «Oh, dottore, sapesse, proprio qui davanti casa hanno ammazzato due persone, adesso adesso: è passata un’auto, hanno sparato dall’interno dell’auto e i due sono morti, un uomo e una donna, il nostro portinaio ha visto l’auto con l’uomo che sparava dal finestrino, ma non ha potuto prendere il numero della targa...» Paolo Donati Sorel cominciò a recitare, da allora in avanti avrebbe dovuto recitare molto. «Adesso? Qui davanti?» Pensò al portinaio che aveva «visto» l’auto dalla quale erano stati sparati i colpi. Michelina staccò l’apparecchio telefonico dal fondo della sala, lo portò sul tavolo lungo e ovoidale, sì, l’architetto aveva pensato a un tavolo quasi a forma di uovo, e innestò la spina nella presa a terra, sotto il tavolo. «Sì, proprio qui davanti a casa, c’è ancora un sacco di gente», le tremava la voce nel parlare. «Grazie, Michelina», disse. C’era la possibilità che da un momento all’altro la polizia salisse in casa sua e lo arrestasse: era molto remota, comunque non poteva farci niente. Bevette un altro poco di chiaretto, e fece tre telefonate. Per primo chiamò Vicenza, la caserma della NATO. «Urgente», disse alla centralinista della Stipel. Poi chiamò il fiorista. «Sono Donati Sorel, per favore, signor Carlo, mi faccia avere nel pomeriggio trentasei rose rosa.» «Rosa? Oh, dottore, dovrò cercarle, io ne ho appena una dozzina.» Gli disse con estrema cortesia di cercarle ma di fargliele avere prima delle cinque. Poi telefonò al garage, riconobbe subito la voce della ragazza dal grosso seno che faceva la dirigente amministrativa della grande autorimessa. «Donati Sorel, per cortesia, mi faccia mandare subito la Ferrari.» «Sì, dottore, faccio riempire il serbatoio?» Al suono di quella voce, nonostante il tremore di terrore che internamente lo pervadeva, la sensazione di morbido di quel seno lo sommerse. «Sì, signorina, molte grazie.» Poi suonò ancora il campanellino di porcellana, e attese Michelina. «Per favore, Michelina, porta qui, non adesso, più tardi, il vaso Baviera. Nel pomeriggio arriveranno delle rose da mettere davanti al ritratto di papà.» «Sì, dottore.» Il vaso Baviera era un vaso di cristallo alto uno e sessanta, quattro centimetri più di lui; lo si metteva, pieno di rose rosa, davanti al ritratto di papà, negli anniversari della sua morte. Idea di mamma, quella così e così. Poi andò nella sua stanza, aprì la porta, aprì l’armadio, prese la sacca con dentro il Winchester, scese in strada, senza guardare davanti, in corso di Porta Nuova dove aveva sparato. La Ferrari era già lì, pronta, buttò la sacca con la carabina nei sedili di dietro e, pazientemente risalì in casa. «Chiamano da Vicenza», disse Michelina aprendogli la porta. «Grazie.» Prese il ricevitore del telefono che Michelina gli porgeva. «Per cortesia, Sezione 11, sergente O’Hirt», disse. «Sì, signore.» Lungo, molto lungo silenzio, poi una voce: «Sergente O’Hirt, chi parla?». «Sono Paolo», disse lui. «Fra due ore, due ore esatte, sono lì.» «Sì, signore.» Tolse la comunicazione senza neppure salutare. Scese, salì sulla Ferrari, erano le due e mezzo, in corso Buenos Aires si fermò davanti a una banca, non era molto regolare, ma il direttore conosceva troppo bene i Donati Sorel per inimicarseli e gli dette mille e cinquecento dollari in biglietti da venti dollari. Alle due e cinquantadue entrava nell’autostrada MilanoVenezia e dopo qualche centinaio di metri cominciò a premere l’acceleratore, sempre di più, fuori era un caldo orribile, ma lui aveva aperto l’aria condizionata e stava bene. Gli piaceva guidare, e guidava bene, e la Ferrari corre bene, e lui viaggiò sempre in corsia di sorpasso e due ore dopo, precisamente due ore, usciva alla stazione di Vicenza est e duecento metri dopo lo snodo ecco, sullo stradone provinciale, la jeep del sergente O’Hirt. La sorpassò e si fermò qualche metro davanti, restando fermo al volante, il finestrino aperto, e quindi l’aria condizionata chiusa, nella vampa di caldo che veniva dallo stradone. Il sergente O’Hirt scese dalla jeep e corse da lui, il viso grassoccio e gli occhi così celesti. «Prendi la sacca, lì dietro, ho messo delle sigarette per coprire.» Non lo guardava neppure. «Sì, signore», il sergente O’Hirt sudava dai baffetti rossi, allungò la mano nell’interno dell’auto, dal finestrino che lui aveva aperto e prese la sacca. «Grazie, signore.» «Il colonnello Drew ha firmato il congedo, fra una diecina di giorni al massimo potrai tornare a casa tua, negli Stati Uniti.» «Grazie, signore, il furiere mi ha già detto che sono stato congedato. Grazie, signore, sono molto contento.» «Questi sono mille e cinquecento dollari», gli dette la busta. «Tu non mi hai mai veduto, non mi conosci, non mi hai mai incontrato, neppure per caso, non mi hai mai prestato un Winchester. Cerca di ricordarlo: ti conviene.» Abbassò netto una mano come volesse tagliarlo in due. «Va’ via e ricordati quello che ti ho detto.» Partì dolcemente, fece tutto lo stradone fino a raggiungere lo snodo dell’autostrada dalla parte Vicenza-Milano, e alle sette e un quarto era in via Annunciata, a casa sua. Andò in sala da pranzo per prepararsi da bere: le rose rosa erano arrivate, troneggiavano nel gigantesco vaso Baviera di cristallo, quattro centimetri più alto di lui, davanti al ritratto di suo padre. Cominciò a bere Cointreau guardando le rose e suo padre, e aspettando di vedere che cosa sarebbe accaduto. Accadde quello che lui aveva preveduto: sparando da una finestra del secondo piano, l’angolazione è così bassa che neppure l’autopsia più scrupolosa può sospettare dall’angolo di incidenza che il colpo sia stato sparato dall’alto, da una finestra. Per di più un portinaio, proprio il portinaio di casa sua, aveva visto un’auto dalla quale avevano sparato. E questo era uno. Il due era, come aveva preveduto, che la polizia si era buttata addosso alla traccia del Winchester. Un Winchester M.2 non si vende nelle cartolerie, o nei negozi di profumi, e tanto meno nei negozi per cacciatori e pescatori. Il Winchester M.2 è un’arma di guerra in dotazione alle truppe della NATO, non è in commercio neppure per gli appassionati di caccia grossa, e Paolo Donati Sorel immaginava la sorpresa del perito balistico della questura, quando il professore che aveva fatto l’autopsia gli aveva inviato i proiettili estratti dai cadaveri: tutti Borrough Chicago Winchester M.2. La polizia, siccome l’arma era militare, seguiva una traccia di spionaggio, tutte le caserme della NATO, in Italia e in tutta Europa, stavano per essere setacciate, comunque seguivano una strada sbagliata. E l’aveva previsto. Inoltre, al quarto giorno, le rose rosa non erano ancora sfiorite, che già i giornali non parlavano più della storia. Entro certi limiti aveva preveduto anche questo, ma riconosceva che era stato aiutato dalla fortuna. Fu al nono giorno, quando già da tempo aveva fatto togliere il vaso Baviera, non è divertente essere più basso di un vaso, ed era un caldo, sonnolento pomeriggio, che Michelina gli telefonò nel suo studio salotto. «C’è un signore che desidera parlare con lei», disse. «Ha detto che è un amico del sergente O’Hirt.» Per un poco, una vertigine lo rese quasi cieco. Poi si riprese. Con voce molto lenta disse: «Fallo passare in sala da pranzo». «Sì, dottore.» «Prima, però, metti il telefono sul tavolo, dalla parte grande del tavolo.» Vi sono persone che possono sentirsi imbarazzate a sedere davanti a un tavolo a forma di uovo, e dalla parte della punta dell’uovo, e lui sentiva che il visitatore era una di queste persone. Andò in sala da pranzo: l’uomo era lì, in piedi, goffo e volgare come aveva previsto, in quel cosiddetto fresco tutto stazzonato, bluastrino, e quel naso camuso, da negro, e quei labbroni, da negro. «Sono un amico del sergente O’Hirt», disse quella specie di negro. «Si accomodi», disse. Lo invitò a sedere, dalla parte della punta dell’uovo, e vide subito che lui si sentiva a disagio. Pur nella sua avvelenata disperazione ebbe voglia di ridere. Era un bianco, ma sembrava nativo della Beciuania. «Sono un amico del sergente O’Hirt», disse il beciuano. Lo guardava fissamente, perché lui capisse che era un amico del sergente O’Hirt. «Sì», ammise lui, signorilmente, guardando il ritratto di suo padre che assisteva al colloquio, pronto a scavalcare, per magia di Sciltian, la cornice. «Sì, e che cosa desidera?» «Il sergente O’Hirt beve», disse il beciuano, fissandolo: più che con le parole sembrava abituato a parlare con gli occhi, occhiate cariche di sottintesi, come nelle comiche dei film muti con torte in faccia. «E allora?» lui domandò al beciuano. Poteva darsi che il sergente O’Hirt bevesse, erano assai rari i sergenti astemi. «Quando ha bevuto parla.» «E poi?» «Io sono suo amico.» «Questo lo ha già detto. Soltanto che io non conosco né lei né questo sergente O’Hirt.» «Il sergente O’Hirt beve molto e quando beve parla con gli amici. Io sono suo amico, io lavoro nelle cucine della caserma della NATO, a Vicenza. E mi ha detto che tornava a casa, congedato, per questo si prendeva una sbornia.» «E allora?» «Allora ha detto anche», disse il beciuano coi suoi labbroni, e mentre parlava i basettoni scuri, lunghissimi, si muovevano goffamente, «che c’era stato un signore che gli aveva fatto avere il congedo e in più mille e cinquecento dollari, per un piccolo favore.» «Sì», disse cortese, con molta paura, ma cortese, come lo è sempre un gentiluomo, e si mostrò curioso. «E che piccolo favore era?» «Un Winchester M.2 prestato per qualche giorno», disse il beciuano, occhieggiando, basettando, con le basette nerissime e foltissime. Paolo Donati Sorel si volse un momento a guardare il ritratto del padre che lo irrideva. Non era mai stato così stupido da pensare di compiere un delitto perfetto, solo i cretini pensano al delitto perfetto, e lui era tutto, anche bastardo e figlio di una così e così, ma non cretino. «E io che c’entro, in tutto questo?» disse cortese, e paziente. Gli occhi occhieggiarono, le folte sopracciglia nere vibrarono, le basette ondeggiarono, le mani e le braccia si mossero come in una bracciata di crawl, e il beciauno disse: «Lei è il signore che si è fatto prestare il Winchester col cannocchiale e il treppiede e che col Winchester ha ucciso quei due dalle finestre di casa sua. Io leggo i giornali». Paolo Donati Sorel abbassò lo sguardo sull’apparecchio telefonico che aveva davanti a sé, e disse, rialzando subito lo sguardo. «Non ho capito quasi nulla di quello che lei dice. Comunque: che cosa vuole da me?» «Io sto per sposarmi e volevo comprare l’appartamentino a Cologno Monzese. Costa dieci milioni.» Gli fece segno di sì, che capiva: uno che si sposa ha bisogno dell’appartamento, non può mica fare la notte di nozze al Parco Ravizza. «E almeno un trecentomila al mese, per i primi tempi», disse il beciuano. «Non so se ho capito bene, ma lei vuole da me dieci milioni subito, e poi trecentomila lire ogni mese. È così?» «Sì, è così.» «E perché io dovrei darle tutti questi soldi?» «Perché se no, io vado in questura e racconto tutto.» Lo guardò, guardò quella melma sotto forma umana. «Non occorre che lei vada in questura», conosceva troppo bene la sua sorte, dal momento in cui in fondo al cannocchiale del Winchester aveva inquadrato Beatrice e Tullio Marone, e aveva sparato, sapeva che non c’era scampo. Presto o tardi lo avrebbero preso. Si era voluto soltanto vendicare. «La chiamo io, la polizia.» Il beciuano rise, banalmente. «Voglio vedere.» Paolo Donati Sorel compose il 777 senza rispondergli, e intanto i fianchi di Beatrice, coperti dall’abito bianco coi grandi fiori neri e gialli, gli tornarono alla mente. «Venite subito in via Annunciata 4, secondo piano, sono in mano di un uomo che mi minaccia e mi ricatta», disse al milite e depose subito il ricevitore. Era il miglior sistema per farli accorrere subito. Il beciuano alzò una spalla, mosse ancora le braccia come nuotasse il crawl, alzò le sopracciglia, fece ondeggiare le basette, e poi rise: «Signorino, non fate lo spiritoso, voi non avete telefonato a nessuno, voi avete fatto finta di telefonare, per spaventarmi, ma io non mi spavento. Datemi i soldi se volete vivere tranquillo». Quando arrivarono i militi della volante, il beciuano non lo credeva ancora, e quando se ne convinse, cominciò a gridare: «Lui ha ammazzato quei due, con un Winchester, gliel’ha dato il sergente O’Hirt, per il congedo e mille e cinquecento dollari...», lo gridò con tutta la sua voce, per quasi un’ora di seguito, schiumante rabbia beciuana per il mancato ricatto. Un brigadiere disse a Paolo Donati Sorel: «Che cosa dice?». Lui smise di pensare ai fianchi di Beatrice. «La verità», disse. Un signore, come i gatti, deve sempre cadere in piedi. 27 · La moglie innocentista Al principio aveva avuto tanta paura di essere scoperto, si era nascosto due mesi in casa dei futuri suoceri, la fidanzata gli appariva sempre più squallida, ma in confronto a trent’anni di galera era Venere e Minerva insieme. Poi, a Firenze, durante il viaggio di nozze, lesse sui giornali che avevano arrestato il feroce assassino della passeggiatrice, e dopo cominciarono a pubblicare le fotografie sulle riviste, di quell’assassino. Il processo durò dei mesi, lui, con la squallida moglie vicina, leggeva i giornali, le testimonianze di accusa, e dalla paura di essere scoperto passò allo sgomento, lo sgomento di qualche cosa di soprannaturale: era proprio evidente, secondo le testimonianze, che era stato quello lì, ad ammazzare così ferocemente la passeggiatrice, d’altra parte, sapeva di essere stato lui, così sbronzo quella sera, col cric dell’auto. O forse era tanto sbronzo da aver sognato di averla uccisa? E a poco a poco dallo sgomento passò al sospetto. Il processo continuava, per mesi e mesi, e il sospetto diveniva sempre più fondato: non poteva essere stato lui a uccidere la mondana. L’aveva uccisa quell’altro, quello sotto processo, e certo si trattava di un’altra mondana. E lui, così sbronzo com’era quella sera, si era messo in mente, invece, di essere l’assassino. Il sospetto divenne certezza, quando condannarono quell’altro, ma la squallida moglie, che seguiva anche lei il processo, lo raggelò, il giorno della sentenza: «A me non mi convince, questa sentenza, deve essere stato un altro, lo sento...» disse squallida e intuitiva, senza sapere niente, ma convinta innocentista. 28 · La rabbia e la vita L’agente Scapurro entrò in acqua, fremente ancora di rabbia, l’acqua era fredda, e lui sperava di calmarsi. La spiaggia era poco affollata, quasi nessuno faceva il bagno quella mattina. Solo dopo qualche bracciata si accorse che c’era qualcuno che nuotava dietro di lui, si volse e distinse la faccia impudente della bambinaia, che lo guardava con grandi occhi angosciati. Allora stette a galla, quasi fermo, ad aspettarla, sotto il cielo nuvoloso, dondolando tra le onde. Anche lei si fermò vicino a lui, e d’un tratto, bravissima, scoppiò a piangere. «Se gli dice la verità mi ammazzo», disse. Oh, no, che non si sarebbe ammazzata, pensò l’agente Scapurro. Guardò verso la spiaggia, la capannina del bar, dove quel vecchio cretino del suo amico beveva aranciate, e faceva girare il juke box, felice. L’aveva incontrato sulla spiaggia, dopo diversi anni che non lo vedeva, si era sposato, gli aveva detto, una bella ragazza, che prima faceva la bambinaia, una che pensava solo alla casa e al marito, era tanto felice e dopo un po’ lei era arrivata e l’agente Scapurro aveva riconosciuto nella pretesa bambinaia la più scatenata squillo con cui avesse avuto a che fare nella sua lunga carriera di poliziotto. E questa era la moglie che il suo amico si era beccato. Per la rabbia li aveva lasciati e si era buttato in acqua, altrimenti sarebbe scoppiato. E lei lo aveva seguito. «Allora va’ subito ad affogarti», le disse, «perché appena torno in spiaggia apro gli occhi a quel povero fesso...» Lei smise di piangere e tentò: si tirò giù le spalline del costume, fino alla vita e tese un braccio verso di lui. L’agente Scapurro si guardò in giro, la rabbia gli divenne languore, poi con gli occhi fissi su di lei disse: «Andiamo più avanti.» Erano troppo vicini alla spiaggia. 29 · Peccato normale L’azienda era grande, aveva migliaia e migliaia tra operai e impiegati. Aveva il nido d’infanzia per i bambini dei dipendenti, il circolo aziendale coi biliardi e la palestra, e aveva infine anche il Centro Psicologico. Nessuno poteva essere assunto o licenziato senza il parere del direttore del Centro Psicologico che studiava il carattere, il comportamento dei dipendenti. Una mattina di gennaio il direttore del Centro trovò sulla sua scrivania una pratica di licenziamento, nella solita cartella grigia. Il capo dell’ufficio vendite proponeva per il licenziamento uno dei suoi sessantotto impiegati, il signor Alessandro Marchini, di anni diciannove, computista, essendosi egli fatto trovare in una stanza dell’archivio sezione 2 a dare fastidio in modo aggressivo e indecente a un’impiegata quarantenne che gli aveva chiesto di tenerle la scala mentre lei saliva per prendere delle pratiche da un armadio. Il direttore del Centro prese da uno scaffale la pratica Marchini Alessandro , guardò la fotografia, e i dati, e le note personali. Il Marchini Alessandro, entrato nell’azienda a sedici anni, era quello che lui considerava il mostro dei giovani. Non aveva mai ritardato, arrivava sempre un quarto d’ora prima dell’orario, usciva mezz’ora dopo, non aveva mai commesso nessuna infrazione; anche per l’aspetto, con quegli occhiali, sempre vestito di scuro, sembrava già vecchio, sfinito padre di famiglia, senza gli slanci, le turbolenze della giovinezza. Ed ecco che finalmente, con quell’assalto alla quarantenne, mostrava di essere giovane e normale. «Droppi, non licenziarlo», telefonò al capo dell’Ufficio Personale, «vuol dire che è normale, se dà fastidio alle donne...» 30 · La schiava Attraverso le lenti a contatto e il fumo della sigaretta sul posacenere, vide il giovanotto attraversare la lunga sala della pasticceria e venire verso di lei. Portava il paltò sulle spalle, una lunga sciarpa di lana grigia, che gli arrivava quasi alle ginocchia e aveva molti, molti capelli, forse troppi. Il giovanotto le si fermò davanti, aspirò una boccata dalla sigaretta tenuta nel pugno quasi chiuso, mormorò svogliato, stanco: «La signorina Franca?» fissando la catenina di platino che lei teneva al collo, chiusa da un brillante. «Sì», disse lei, al di là, oltre che dei quarantacinque anni, anche della vergogna, ormai. Lui sedette, comodo, come fosse stato invitato, il paltò gli scivolò da una spalla, in terra, ma lui non se lo rimise a posto, aspirò ancora una boccata e disse: «Mi manda Piero, lui non ha potuto venire, dice che telefona», buttando fuori fumo dalle labbra, tra parola e parola. Un cameriere in frac scavalcò, ignorandolo, il mezzo paltò scivolato dalla spalla del giovane quadrumane, più che uomo, che ingombrava il passaggio, e lei abbassò gli occhi. Prima di Piero aveva conosciuto Giovanni, un fattorino di una profumeria; dopo un poco, nonostante i regali, Giovanni aveva mandato all’appuntamento un amico, Piero, Giovanni non poteva venire, diceva che avrebbe telefonato. E adesso Piero le mandava questo sciarputo giovane animale della giungla. Era troppo schiava della sua debolezza. «Vuole bere qualcosa?...» disse. 31 · L’ultimo regalo Si svegliò per il solletico sul viso degli splendidi capelli biondi di quella ragazza che gli dormiva a fianco. Scrollò il viso guardando le lunghe spalle nude di lei voltata dall’altra parte, troppo lunghe, forse, e sorrise, tirandole su la coperta perché non si svegliasse. Si trovò in quella grande stanza di grande albergo in una grande città, coi finestroni larghi come le vetriate delle cattedrali gotiche, la moquette rosa pastello, gli specchi rotondi dalle cornici dorate che sembravano piccoli laghi d’argento sulle pareti. Il bagno era tutto scintillante di cromi. Si buttò nella vasca con l’acqua bollente, sommerso quasi anche col viso, poi aggiunse la fredda, così che dovette schizzare fuori dalla vasca per i brividi, ma il grande asciugamano che aveva poggiato sul radiatore subito lo riscaldò, e cominciò a vestirsi. La rivoltella, che era appesa a uno speciale gancio dei calzoni, gli ricordò che quella mattina del 22 aprile, alle 11, era stato fissato l’appuntamento per il colpo al largo Promessi Sposi, a pochi passi dall’inizio dell’Autostrada dei fiori. Si vestì tutto, esclusa la giacca, e uscì dal bagno odoroso di lavanda. Erano le 8,40 e lui doveva avvisare Simona che andava via subito, che lei continuasse a dormire finché voleva, poi pagava il conto, ecco i soldi, le avrebbe detto, e se ne andava. Si sarebbero rivisti di lì a qualche giorno, avrebbe telefonato lui. «Uh, Simona, sveglia», sedette sul letto, le tuffò una mano nei capelli, «ehi, marmotta, morta di sonno», lei aveva il viso coperto dal lenzuolo, lui tirò via il lenzuolo e allora vide quelle labbra. Erano quasi nere. Non che fosse dottore, non occorreva essere dottore per capire che era morta; Simona gli aveva accennato un paio di volte che soffriva di cuore e quella era morte per paralisi cardiaca. Le ricoprì il viso col lenzuolo, si alzò, si allontanò il più possibile da lei, in fondo alla stanza, nell’angolo salotto vicino all’anticamera, e guardò l’orologio. Erano soltanto le otto e quarantacinque. Sedette sul bracciolo della grossa poltrona di velluto celeste pastello, pensando. Non aveva mai dato tanta importanza a Simona, era una delle diverse ragazze fisse che andava a trovare secondo gli umori. Eppure, adesso che era morta, gli sembrava che fosse qualche cosa di più delle diverse ragazze. Guardò l’orologio: le otto e cinquanta. Sul tavolino davanti alla poltrona c’era ancora la bottiglia di sambuca nera, che era la passione di Simona, forse le aveva fatto male quella roba, ne aveva bevuta parecchia prima di andare a letto. Non aveva l’abitudine di bere al mattino, lui, ma si attaccò alla bottiglia e mandò giù, cercando di non guardare in fondo, dove era il letto, e dove, sotto la coperta celeste pastello, si scorgeva la piccola massa della piccola Simona, come se lei soltanto dormisse, mandò giù finché non gli venne da tossire. Poi si alzò: aveva pensato abbastanza e uscì. Non chiuse a chiave la porta della stanza, non aveva nessuna importanza, ormai. Uscì dall’albergo. Era una giornata di primavera, ventosa. Un tassì lo portò presto ai grandi magazzini di Porta Vittoria. Salì sull’ascensore e si ritrovò al bar dell’ultimo piano, completamente deserto. Solo sulla terrazza, in piedi davanti alla balaustra, c’era un uomo alto, ossuto, con molti capelli castani, da giovane, anche se il viso non era più giovane, che guardava Milano ai suoi piedi, i capelli mossi dal vento che lassù era ancora più forte. Lui si avvicinò a quell’uomo: «Scusami, sono in ritardo». «Non fa niente, abbiamo tempo», disse l’alto e ossuto. «Mi è successo un guaio. Non potevo prevederlo.» L’alto gli si volse nervoso, anzi quasi rissoso. «Che guaio? Oggi non ci devono essere guai.» Lui gli raccontò che cosa era successo. Simona era morta, e stava lì morta in albergo. L’altro rifletté, poi disse: «Non è un guaio, non è niente». «Come, non è niente? C’è Simona morta in quella stanza, presto o tardi la scoprono, il portiere dell’albergo ha i nostri nomi, anche se non pensano a un assassinio, cercheranno il compagno di quella morta, e il compagno sono io.» «E a te che te ne importa? Ti lasci cercare. Scopriranno che Simona è morta solo verso mezzogiorno, e ora che ti vengono a cercare è pomeriggio, se non sera.» «Va bene, ma quando mi vengono a cercare, io che cosa racconto?» «Tu racconti che sei uscito dall’albergo senza esserti accorto che lei era morta, credevi che dormisse. Non ti possono fare niente, se ti tengono dentro qualche giorno, meglio.» «Ah, sì, per te è meglio? E perché?» «Non sei molto intelligente, se ti fermano per la morte di Simona, la polizia ti sospetterà per la morte di Simona, ma poi dovrà rilasciarti perché Simona è morta da sola, ma non ti sospetterà per la rapina alla Caravel. Hai capito?» Sotto il nome di Caravel, una modesta, ignota, ma organizzatissima società privata si interessava del trasporto di valori da un punto all’altro della Val Padana, dal Veneto al Piemonte fino all’Emilia. Molte volte delle grandi aziende hanno bisogno di trasportare ingenti quantità di denaro dalla sede madre alle filiali, e per ragioni varie non possono servirsi delle banche. Poi vi sono i gioiellieri coi loro campionari del valore anche di miliardi. Facevano parte del servizio Caravel una squadra di una dozzina di ex poliziotti, tra i più duri, anzi troppo duri, e per questo forse dimessi dalla polizia statale, pratici del maneggio di qualsiasi arma, dalle minirivoltelle alla Panzerkraton. Vi erano anche una mezza dozzina di autisti, tre erano ex corridori, capaci di guidare un camion in pieno centro cittadino a centodieci all’ora, riuscendo a farsi strada, senza arrotare neppure un ciclista. Inutile dire che quella ventina di uomini coltivavano intensamente anche vari sport, di preferenza i più violenti, il judo, la lotta greco-romana, la boxe, il catch e il karate. La Caravel usava un sistema particolare per il trasporto di valori. Nel camioncino blindato veniva caricata una cassaforte speciale contenente il denaro liquido o i preziosi. Questa cassaforte poteva essere aperta solo con tre chiavi che possedevano tre diversi funzionari dell’azienda che riceveva i valori così trasportati. In altre parole, anche se fossero stati aggrediti, anche se i rapinatori avessero avuto il sopravvento e avessero aperto il camioncino, i rapinatori non avrebbero trovato dentro le solite cassette di sicurezza contenenti i soldi o i brillanti, cassette facili da trasportare, ma avrebbero trovato una cassaforte sola, del peso di quasi due quintali e mezzo. E se anche fossero riusciti, i rapinatori, a portar via la cassaforte, caricandola con grande fatica su un loro camion, la cassaforte era munita di una piccola radio segnalatrice che avrebbe trasmesso un segnale ovunque i rapinatori l’avessero trasportata. In quel mattino del 22 aprile, grigio, ventoso, il convoglio della Caravel percorreva la via Chiesa Rossa, lungo il Naviglio. Il convoglio era costituito da un robusto camioncino blu, al volante del quale era un ragazzo biondo, e vicino a lui c’era un altro giovanotto con un rivoltellone grosso così sotto la giacca. Nell’interno del camioncino c’era la cassaforte e seduti sulla cassaforte c’erano due con corti mitra a tracolla sui grigi abiti borghesi, che guardavano pigramente dalle feritoie il rilucere plumbeo delle acque del Naviglio sotto il cielo grigio di quella giornata di aprile. E davanti al camioncino c’era una «milleottocento», blu anch’essa, carica, oltre che del guidatore, di due uomini armati come si deve. Questa «milleotto» faceva da staffetta e da protezione in avanguardia, e gli uomini erano pronti a sparare. Alle dieci e cinquantanove minuti, il camioncino e la «milleotto» arrivarono a cento metri da largo Promessi Sposi. La cassaforte quel giorno conteneva centotrentasei milioni in biglietti di vario taglio, perfino da cinquecento lire. In largo Promessi Sposi, alla stessa ora, cioè alle dieci e cinquantanove, lui era nell’interno della sua Giulietta e cercava di non pensare a Simona. Doveva solo guardare verso via Chiesa Rossa per vedere quando arrivava il camioncino della Caravel con la sua macchina di scorta. Dall’altra parte del romantico largo manzoniano c’era la Citroën con l’alto e ossuto, il capo, e altri tre robusti ragazzi. Invece al di là del largo c’erano altre due auto, una Simca e una Cinquecento. Nella Simca c’erano quattro forti giovanotti ben armati, e nella Cinquecento c’era solo un giovanottino pallido, anche per la paura, che attendeva quasi all’angolo con viale Giovanni da Cermenate. Erano le undici esatte: la «milleotto» che faceva da staffetta al camioncino coi centotrentasei milioni sboccò nel largo. La lasciarono passare. Subito dietro veniva il camioncino blu: non lo lasciarono passare. La Citroën s’infilò tra la «milleotto» staffetta e il camioncino con la cassaforte, bloccandogli la strada e costringendolo a fermarsi. C’era molto traffico a quell’ora, su quella strada, anche se non era la principale per andare a Pavia, e le macchine costrette a fermarsi perché lui, anche se pensava a Simona, dietro il camioncino coi soldi aveva messo la sua auto per traverso in modo da bloccare il traffico, e questo era il suo compito, quelle macchine ferme continuavano a strombettare innervosite. Tutto avvenne in poco più di un minuto e mezzo, il poco più era un ritardo sul programma stabilito. I giornali parlarono la sera stessa di un’operazione di guerra, contro un trasporto di valuta. Centocinquanta milioni, i giornali esagerano sempre, rapinati con una azione da commando di marine. Nel servizio i giornali spiegavano che i banditi avevano bloccato il camion con la cassaforte, separandolo dall’auto staffetta. Gli uomini della «milleotto» erano stati aggrediti, prima che si rendessero conto di quello che succedeva, da una squadra di giovanotti discesi da una Simca che li avevano storditi con violenti colpi al capo. Intanto il guidatore del camioncino e il suo compagno erano stati immobilizzati e storditi con lo stesso sistema da quattro uomini tra cui uno alto e ossuto. I due uomini nell’interno del camion, minacciati da un mitra puntato attraverso lo sportello della cabina di guida, non avevano potuto fare nulla se non arrendersi, erano stati storditi con violenti colpi alla testa e buttati fuori del camion. Un istante dopo il camion con dentro la cassaforte e i milioni, guidato dai banditi, sterzava violentemente a destra in via Francesco De Sanctis, e subito dietro di esso la Simca sbarrava la via De Sanctis, mettendosi per traverso, in modo che il camion non potesse essere inseguito, e così il camion scomparve tranquillamente. Dopo un minuto e trentadue secondi, tutto era finito, il traffico era completamente bloccato, non passava più nessuna macchina, da piazzale Carrara a largo Promessi Sposi era un caos, in quell’ora di traffico intenso. Esclusi quelli che si erano messi alla guida del camioncino blu, i banditi si erano allontanati a piedi, lasciando le loro auto a bloccare le strade, la Citroën sbarrava il traffico proveniente da viale Cermenate, la Giulietta quello da via Chiesa Rossa, e la Simca la via De Sanctis. Quando arrivarono vigili e polizia e quando gli uomini di guardia al camion e alla «milleotto» si furono ripresi dai colpi presi in testa, era troppo tardi, il camion con la cassaforte era già lontano, e dove andava non era difficile immaginarlo: andava in una officina abbastanza nascosta dove con tutto comodo i banditi avrebbero potuto scassinare la cassaforte. Tutto si era svolto con estrema precisione, il capo alto e ossuto faceva poche cose, ma le faceva bene. Il primo giorno qualche quotidiano uscì con grandi punti interrogativi: Come mai la radio di segnalazione applicata alla cassaforte non ha funzionato? La radio avrebbe dovuto indicare coi suoi segnali, in qualunque momento, dove si trovava la cassaforte, quindi dove la stavano portando via i rapinatori. Invece la radio aveva fatto una cosa strana, aveva segnalato il regolare percorso che doveva compiere il camion fino alla grande azienda dove i centrotrentasei milioni dovevano essere consegnati e lì, come di regola, la radio veniva chiusa. Il miracolo, la polizia e i giornali lo avrebbero scoperto solo molto dopo; la radio applicata alla cassaforte era stata staccata e uno degli uomini l’aveva immediatamente passata al giovanottino pallido che era al volante della Cinquecento all’angolo di via Cermenate. Sia pure con molta paura, il giovanottino, con la preziosa radio a bordo, aveva fatto lo stesso percorso che il camion con la cassaforte faceva normalmente per arrivare alla grande azienda dove doveva essere consegnato il denaro. Era stato pagato bene, solo per tale lavoro. Il giovane si era fermato davanti alla grande azienda alla quale dovevano essere consegnati i centrotrentasei milioni, e solo allora, secondo gli ordini, aveva chiuso la radio, se l’era messa in tasca ed era andato via a piedi. Tutte le macchine, quella Cinquecento, la Giulietta, la Simca, la Citroën, erano ovviamente macchine rubate e non portavano impronte perché i banditi sono persone raffinate che usano i guanti. Chi ha informato i banditi con tanta precisione di tutti i particolari riguardanti il trasporto dei centotrentasei milioni? e i giornali facevano anche altre domande. Quanto sono costate ai banditi le informazioni avute per poter commettere la rapina con tanta precisione? Tutte domande che avrebbero ricevuto risposta troppo tardi, quando ormai la risposta non serviva più. L’informatore dei banditi era un’informatrice, una giovane ragazza che era fidanzata a uno degli accompagnatori dei trasporti Caravel, uno dei più giovani e dei più vanagloriosi e chiacchieroni, il quale alla ragazza aveva raccontato le sue gloriose imprese di accompagnamento e protezione della Caravel, in particolar modo del «Viaggio 22», cioè di quello che si svolgeva il ventidue di ogni mese per portare delle ingenti somme, dai cento ai duecento milioni, a una grossa azienda milanese. Il prezzo di queste informazioni era stato molto basso, si erano spese solo centomila lire per le bustine di waritene, una polvere che la ragazza metteva nelle bevande del suo amico della Caravel, durante le loro sedute amorose, per renderlo più loquace, e infatti il ragazzo della Caravel con lei era stato loquacissimo, le aveva raccontato tutto della sua vita, fino dalla prima infanzia, ma lei aveva tenuto conto solo di quanto riguardava i trasporti Caravel e aveva riferito tutto. Non rendendosi conto dell’importanza delle sue rivelazioni, la ragazza aveva chiesto solo mezzo milione. Il capo le aveva dato trecentomila lire, e lei era stata contenta lo stesso. Erano le undici e undici minuti. C’era sempre vento. A piedi, camminando rapidamente, lui era arrivato in piazzale Belfanti, entrò nel bar all’angolo e chiese una sambuca nera. Non l’avevano, allora bevette un chinotto. Il suo compito era finito, lui aveva bloccato il traffico dietro il camion della Caravel, poi si era sganciato, e per questo lavoro, semplice ma importante, gli sarebbero toccati 5 milioni. Arrivato a casa, disse a sua sorella che era stanco e che andava a dormire, forse aveva preso l’influenza, le disse. La sorella, che era nubile, lo guardò e disse: «Ogni volta che la sera esci con Simona, al mattino dopo torni balordo». La mattina dopo non fece a tempo a radersi che già c’erano alla porta i due della polizia. «Nome?» chiese il poliziotto. Lo portarono lì in questura, ed erano in due intorno a lui. Lui dette tutti i suoi dati. Poi uno dei poliziotti, il meno importante, arrivò al dunque: «Lei conosce una certa Simona Darelli, di ventitré anni, di professione manicure?». Lui recitò benissimo: «Certo che la conosco, è la mia fidanzata». «Quando l’ha vista l’ultima volta?» «Due giorni fa, perché?» L’altro poliziotto, quello più importante, dal suo angolo disse: «Le domande le facciamo noi». L’impiegato meno importante continuò l’interrogatorio: «Dove l’ha vista due giorni fa?». Lui finse di essere imbarazzato, poi confessò: «In un albergo, sa, lei ha dei genitori severi...». Il buffo è che era vero, i genitori di Simona erano all’antica, anche se Simona riusciva sempre a imbrogliarli: «Non era facile vederci...». «Che albergo era?» disse l’interrogante. Gli disse il nome dell’albergo, poi finse abbastanza bene: «Ma perché volete saperlo?». Dal suo angolo, il poliziotto più importante non gli ripeté che le domande le facevano loro, ma venne avanti e sedette a un lato della scrivania e lo fissò. Poi disse: «Quella che lei chiama la sua fidanzata è stata trovata morta ieri mattina appunto nell’albergo che lei ha nominato un momento fa». «Morta!» disse lui, recitando abbastanza bene. «Non è possibile.» «Perché non è possibile?» disse il poliziotto, sospettoso. «Perché io ho lasciato l’albergo che era ancora viva.» «E come fa a saperlo, che era ancora viva?» gli occhi rotondi, sporgenti, da gallina, del poliziotto lo fissavano increduli. Lui si mostrò impacciato: «Come faccio a saperlo, ecco, lei dormiva. Io mi sono alzato prima, non l’ho svegliata perché a svegliarla diventa nervosa. Dovevo andare a casa, facciamo sempre così, le lascio nella borsetta i soldi per il conto dell’albergo, lei si alza tardi perché lavora come manicure soltanto nel pomeriggio, il suo parrucchiere non ha soldi per tenerla tutto il giorno...». I due che lo interrogavano lo guardarono per un po’, poi il poliziotto più importante disse: «In settimana avremo l’esame necroscopico. Spero che la morte della sua fidanzata sia dovuta a semplice paralisi cardiaca, ma, se la perizia accertasse tracce di veleno o di soffocamento, o altro, di assassinio intenzionale, credo che lei si troverà in una brutta situazione». Era invece in una bella situazione, lo pensò subito nella cella di isolamento dove lo rinchiusero. Lui non aveva ucciso Simona, e presto anche la polizia se ne sarebbe convinta. Ma il sospetto che per qualche oscuro motivo l’avesse uccisa gli giovava moltissimo. In quei giorni tutta la polizia e i giornali erano scatenati contro i banditi della rapina alla Caravel, e non trovavano nulla, nonostante le decine di identikit costruiti sulle descrizioni dei testimoni della rapina. Lui invece era al sicuro in una cella della questura, sospettato di un delitto che non aveva commesso, perché non era un delitto la morte di Simona. Lo tennero quattordici giorni lì dentro, al mattino del quindicesimo il poliziotto più importante lo chiamò nel suo ufficio per fargli firmare alcune carte e gli disse che era libero. «L’esame necroscopico ha dato esito negativo, la sua fidanzata è morta di morte naturale dovuta a debolezza di cuore.» Tornò subito a casa, non salutò neppure sua sorella, e si mise a letto dopo aver preso tre pastiglie di sonnifero. «Hanno portato questo panettone per te, che idea mandare un panettone a maggio», gli disse la sorella, entrando nella stanza mentre lui ingoiava il sonnifero. «Grazie», le disse, la mandò subito via e prima di addormentarsi aprì l’artistica confezione di quel panettone così meneghino. L’involucro, come sapeva, non conteneva un panettone: in mezzo alla paglietta c’erano tanti biglietti da diecimila: la sua parte. Prima d’addormentarsi pensò che, fra tutte le donne che aveva conosciuto, Simona era stata sempre la più gentile, era morta di paralisi cardiaca proprio la notte sul 22 aprile, come se avesse voluto proteggerlo; forse c’erano dei poliziotti che sospettavano ancora, nonostante la perizia necroscopica, che lui l’avesse uccisa, ma non c’era nessun poliziotto che sospettasse che lui aveva preso parte alla rapina della Caravel. Simona gli aveva regalato l’alibi. 32 · Trecento milioni Il vecchio stava seduto solo, sul divano, era vestito molto modestamente, le mani erano coperte di peluria nera, la fissava da molto attraverso un povero paio di occhiali e le scarpe erano anche un poco impolverate. Doveva avere oltre quaranta anni, forse quarantacinque, la ragazza non capiva perché dovessero invitare anche simili ruderi a una festa di giovani, e, quando lo vide alzarsi, e capì che veniva verso di lei per chiedere di ballare, all’idea di quelle mani vellose sulle sue spalle si sentì quasi male. Si volse a Fredi che le era vicino. «Non dovrò mica ballare con quel coso», quasi gemé. Fredi posò il bicchiere con l’aranciata, guardò avanzare il vecchio, piccolo e dimesso, fra tutte le coppie giovanissime che ballavano. «È Pozzani», mormorò «la settimana scorsa l’ho visto fare una piccola spesa, ha comprato uno yacht e ha firmato subito un assegno di trecento milioni...» Il vecchio era arrivato davanti a lei e dai modesti occhiali la fissò. «Sono Matusalemme», disse, «vuole sacrificarmi questo valzer?...» Ma lei non udì, era già tra le sue braccia, delicatamente stretta da quelle mani, così forti, così virili, pensò, e poi non era vecchio per niente, era un uomo, e lei era stanca di quei bambocci minorenni come Fredi: la vita per un uomo comincia a quarant’anni, e poi lui non era neppure piccolo, era così forte, così uomo, che dava l’impressione, come Napoleone, di essere grande. Travolta dai trecento milioni, appoggiò la guancia a quella del non più meschino, ma luminoso uomo, sognando suoi quei trecento milioni, quello yacht, e tutto, così giovane e già così intimamente disonesta. 33 · Verso mezzanotte Suo marito dormiva dalle dieci, verso mezzanotte lei si alzò, senza timore di svegliarlo, in bagno si rivestì, prima dell’una sarebbe stata da Paolo e per le sei sarebbe tornata, era sicura che suo marito non si sarebbe svegliato, dopo quasi quindici anni di matrimonio lo conosceva meglio di sé stessa, così anche quando la spazzola dei capelli le cadde in terra, non si angosciò, stette solo ad ascoltare e fin lì nel bagno le arrivò, regolare, l’ansito rauco di lui che continuava a dormire. Allora raccolse la spazzola, finì di prepararsi, e uscì. La porta di casa cigolò, nel silenzio della notte, e anche aspramente, ma lei non vi badò. Non era preoccupata che suo marito si svegliasse, era in ansia solo per il dubbio se potesse essere ancora abbastanza bella per un giovane come Paolo, e anche lo scatto della portiera dell’ascensore non la turbò, schiacciò il bottone per il pianterreno: l’ascensore scivolò dolcemente per due piani, poi ebbe un sussulto, e si fermò, tra un piano e l’altro. Al momento lei quasi non capì, perché stava mettendosi alcune gocce di profumo alle orecchie e alla nuca, poi si rese conto. Chiuse di nuovo bene la portiera, forse si era aperta da sola e tolto il contatto, schiacciò di nuovo il bottone, ma non accadde nulla, l’ascensore rimase fermo. Non voleva suonare il campanello d’allarme, anche perché a quell’ora il portinaio era a dormire, ma dopo un quarto d’ora, inquieta e impaurita, lo suonò, ma dopo quasi mezz’ora smise, un po’ di nausea per la paura di rimanere lì tutta la notte e per il profumo troppo intenso in quella cabina troppo piccola. Solo alle quattro e mezzo una guardia notturna riuscì a liberarla, ma ormai non aveva più voglia di andare da Paolo e tornò nell’appartamento. Suo marito dormiva sempre. 34 · Un alibi d’acciaio La sposa, col suo velo bianco, qualche chicco di riso ancora qua e là tra le vesti, era finita anche lei nell’ufficio di polizia, il viso livido, senza lacrime, lo sguardo pieno di odio verso il funzionario che, da dietro la scrivania, le spiegava: «È inutile che dite che non è vero, mamma santissima, che vi dispiace si capisce, ma la verità è la verità, e voi dovete saperla... Lui è uscito di casa sua questa mattina alle nove per venirvi a sposare. Era tutto calcolato, preciso, premeditato. Esce di casa con la macchina, ripeto, per andare alla chiesa dove si deve celebrare il matrimonio. Ma è appena salito in macchina che compare la sua vecchia amica, e lui lo sapeva che sarebbe comparsa. Fammi salire, gli dice la vecchia amica, tu non vai a sposare quella lì, tu vieni con me. È un’esaltata, una pazza, lui lo sa, da due anni lei lo tormenta, lui non ne può più, la fa salire, l’ammazza subito, poi, prima di venire a sposare voi, passa per il parco, butta il cadavere dietro una siepe e corre in chiesa, a fare lo sposo, che aspetta la sposa... Voi arrivate, si celebra la cerimonia, andate al rinfresco, e lui sta quieto quieto, perché ha l’alibi di ferro, di acciaio, vi dico. Anche se lo prendiamo e gli domandiamo: “Dove eravate la mattina del 29 aprile?” lui risponde: “Ero a sposarmi”. Come fa uno che va a sposarsi, nello stesso tempo ad ammazzare una donna?... Ma lui non poteva immaginare che la macchina gli perdesse l’olio proprio stamattina. Vicino alla donna strangolata c’è una pozzetta d’olio, noi andiamo dietro le gocce d’olio come nelle favole e arriviamo alla chiesa... dalla chiesa arriviamo all’albergo dove continua ancora il rinfresco, domandiamo di chi è la macchina e la macchina è dello sposo, e lo sposo ha confessato, signora, mi dispiace tanto, signora, ma la verità è la verità...». Nel suo velo bianco, lei, però, continuò a guardarlo con odio. 35 · Quei manifesti, e basta Gli occhiali da sole erano veramente troppo grandi, rotondi come erano di moda, ma più grandi del tollerabile, forse potevano essere briosi d’estate, su una spiaggia, quasi un invito allo scherzo, ma era inverno, dai finestroni dello studio fotografico si vedeva il viale, una specie di cimitero di piante scheletriche, lucido di pioggia gelida. E anche i capelli coprivano troppo la fronte, anzi la coprivano tutta, toccando la montatura degli occhiali, e il viso appariva ancora più sottile, inesistente, sotto quella calotta di occhiali e capelli. Giarrotti, appena la vide entrare, capì che era lei, anzi, la indovinò, come un numero al lotto, e si alzò, le corse incontro, al solito espansivo e falso: «La mia Tristana, la mia Tristanella...». L’abbracciò, attento a non spostarle gli occhiali o scompigliarle i capelli: l’ultima volta che l’aveva veduta, in clinica, era a viso nudo, con la fronte devastata da selvaggi segni rossi, dopo l’agghiacciante incidente d’auto che le era accaduto. Lei si liberò, cortese ma ferma, dal bugiardo abbraccio, vagando con lo sguardo sulle pareti dello studio tappezzate di vecchi manifesti con enormi visi di donna, quasi tutti il suo viso, il suo viso di prima dell’incidente, la modella che aveva fatto vendere milioni di saponette e di dentifrici. Nell’incidente Giarrotti non si era fatto nulla, lei si era rovinata per sempre. Stavano andando a un alberghetto sul lago, perché Giarrotti, nel compenso delle foto per i manifesti, pretendeva anche quello. «Volevo solo un poco di quei manifesti», gli disse lei, niente altro, solo quei manifesti di quando era bella: né elemosine né scivolose parole di conforto, o illusioni. Quei manifesti, e basta, la prova che un tempo era stata bella. 36 · Un poliziotto, una bambina, un capretto «Hai sessantasei anni, e un occhio solo. E conciato in questo modo, all’alba dei settant’anni, ti vuoi rimettere a fare il poliziotto, vuoi cercare ancora l’assassino di una bambina che, se è morta, è morta cinque anni fa?... Ma non far ridere...» Il vecchio poliziotto scosse il capo. È difficile parlare con un figlio di quarant’anni, importante dirigente di un’importante azienda. «Io so chi è l’assassino della piccola Kristie, e vado a prenderlo.» «Ah, sì?» scattò il figlio e alto dirigente. Perché i padri rimbambiscono e rendono nervosi i figli, «e, se sai chi è l’assassino, perché non lo dici alla polizia?» «L’ho detto, ma non mi credono.» «E a te che te ne frega?» disse duramente suo figlio. «Tu gli dici chi è il colpevole, loro non ti credono, e buonanotte.» Il vecchio poliziotto sussultò a quella brutalità. «Io parto», disse, «sono venuto solo a dirti questo.» «Benissimo», disse suo figlio. «E per curiosità, chi sarebbe l’assassino della piccola Kristie? A parte il fatto che non hanno mai trovato il cadavere e che Kristie potrebbe essere ancora viva?» «La piccola Kristie è morta, l’ha uccisa il N.H. Domiziano Doravanti, dopo averle usato violenza», disse seccamente l’alto uomo dalla benda nera sull’occhio come Dayan. «Ho lavorato quasi per quaranta anni in polizia e, se dico una cosa di questo genere, è perché posso dirla...» «Ma scusa, papà, perché cinque anni fa non hanno preso questo N.H. Domiziano Doravanti, non lo hanno interrogato?» «Lo hanno preso e interrogato, perché gliel’avevo detto io che era lui l’assassino, ma non si è trovato il cadavere della piccola, lui era una persona importante e aveva importanti avvocati, non si poteva accusare di assassinio una persona quando non si sapeva ancora se c’era stato un assassinio o no. E poi non c’era nessuna prova contro di lui, si sapeva solo che dava fastidio alle ragazzine, ma gli avvocati riuscirono a dimostrare che lo faceva innocentemente, paternamente. Una madre, di una bambina di due anni, dichiarò di ricevere centomila lire al mese dal nobil uomo, nel paese, e nella zona il N.H. Domiziano Doravanti era noto per la sua generosità, e così lo hanno lasciato stare.» Il figlio quarantenne portò ancora pazienza, sospirò con rispetto filiale: «E come mai dopo cinque anni ti riprende questo prurito di arrestare l’assassino della piccola Kristie Kalin?». «Questo prurito l’ho sempre avuto», disse il vecchio poliziotto, parlando per un momento lo stesso brutto linguaggio del figlio. «Sono cinque anni che scrivo lettere, che telefono, alla questura di Torino, ai carabinieri di Ciriè, ai miei colleghi, sono andato due volte a Torino, mi sono fatto ricevere anche dal questore, e a tutti ho detto che l’assassino della piccola svedese non poteva essere che quel delinquente che loro chiamano N.H. Domiziano Doravanti.» «E loro che cosa ti hanno detto?» disse il maturo figlio paziente. «Sempre la solita stupidaggine. Che non si ha la minima prova di colpevolezza, il minimo indizio, e che oltre tutto non si sa neppure se la piccola Kristie sia stata uccisa, e che quindi non si poteva incolpare di assassinio alcuno, non sapendo ancora neppure se vi fosse stato assassinio o no. Queste sono vere stupidaggini.» Il poliziotto, vecchio e orbo, si passò una mano sull’unico occhio, e si alzò. Il figlio, alto dirigente della grossa azienda, si alzò anche lui da dietro la grossa scrivania, del tutto proporzionata alla grossa azienda. «Esiste una legge, papà», disse commosso, per l’occhio umido del suo vecchio padre, «non si può accusare nessuno, se non ci sono delle prove, tu accusi uno dei notabili più importanti della zona, di stupro e di assassinio di minore, tanto minore che è una minore di sette anni. Papà, tu sei stato per quarant’anni dalla parte della legge, perché non capisci che senza prove non si può accusare nessuno?» Il vecchio poliziotto si asciugò l’occhio umido col fazzoletto. «È appunto dopo quaranta anni di mestiere che ho imparato che vi sono due specie di prove, quelle tecniche, le impronte digitali, le tracce di sangue, il calibro dei proiettili, e delle prove di sensazione.» «Prove di sensazione?» disse il figlio, facendo molto sforzo a comprendere, anzi, non comprendendo affatto. «Che cosa vuoi dire?» «Una sensazione», disse il vecchio poliziotto. «Per esempio, io ho la sensazione che tu sei un bravo ragazzo, anche se non molto intelligente, e che non ruberai mai i soldi qui in questa azienda, né che porterai via la moglie ai tuoi amici, o che corromperai delle dodicenni, io sono sicuro di questo, io ho la sensazione, ma come faccio a dimostrare alla polizia che è così, a dare le prove? Lo sento, e basta.» Il figlio assentì. Coi vecchi è assolutamente inutile discutere. «Sì, papà», disse. «Sai, Enrico, ero venuto qui anche per un poco di soldi», il vecchio poliziotto leggermente arrossì. «Sì, papà.» Il figlio si portò una mano alla tasca posteriore dei calzoni e tirò fuori il portafoglio. «Mi bastano cinquantamila lire», disse il padre. Era un vecchio, onesto, inflessibile piemontese, di professione poliziotto in pensione, di nome Vittorio De Stefanis. «Sì, papà», disse il figlio. Tolse dal portafoglio i cinque biglietti da dieci. «Grazie», disse Vittorio De Stefanis, mettendosi accuratamente nel portafoglio i cinque michelangeli. «E scusa.» «Non te la prendere troppo per quella storia, papà», disse il figlio, era ancora un poco commosso, dall’occhio umido di suo padre. «No, me la prendo», disse recisamente il vecchio poliziotto. «Scusa.» Uscì. Da basso aveva la sua «Seicento», che guidava ancora baldanzosamente, fece tutta via Roma con guida nervosa, era la sua guida, voltò a destra poco prima della stazione, poi ancora a destra, poi a sinistra e fermò davanti a una vetrina che esponeva canne da pesca e fucili. L’insegna era antiquata, «Bottega delle armi». Entrò. C’era un vecchio, dietro il banco, più vecchio di lui, che subito gli sorrise. «Allora è venuto proprio a prendere la Herter’s?» «Certo, e qui ci sono i soldi...» tirò fuori le cinquantamila lire che gli aveva dato suo figlio. Guardò la rivoltella che il vecchissimo armaiolo gli mostrava aprendo un prezioso astuccio di pelle. «Questa non è una rivoltella», diceva l’armaiolo, «è un cannone. Anche se ferite uno al braccio, quello scoppia tutto come avesse urtato contro una mina. Questa è una Herter’s Power Magnum 401, ha idea di che cosa è una Herter’s 401? La usavano i cow-boys per seccare a dieci metri di distanza le vacche che impazzivano dopo giorni di cammino nella tormenta.» Vittorio De Stefanis sapeva benissimo tutte queste cose sulla Herter’s. L’aveva scelta appunto per quelle sue qualità. Un orbo non può tanto sperare di far centro, ha bisogno di qualche cosa che rassomigli a una granata, e la Power 401 Magnum della Herter’s è appunto una granata travestita da rivoltella. Cinque anni prima nelle vicinanze di Ciriè, in una specie di vallata tutta verde, tre svedesi, col permesso del contadino proprietario del terreno, avevano impiantato una tenda. Lui era il professore di matematica Hovas Kalin, sua moglie si chiamava Luzi ed era professoressa di ostetricia e di chirurgia ginecologica. Avevano una bambina di sette anni, Kristie. Si erano portati dalla Svezia, su un’auto enorme, una tenda enorme, grande quasi quanto quella di Eisenhower quando sbarcò in Normandia. La piccola aveva dei capelli non solo biondissimi, ma lunghissimi, il padre diceva che non si poteva prendere l’arbitrio di tagliarglieli, doveva essere sua figlia, quando avesse avuto l’età della ragione, a decidere che fare dei suoi capelli. Era la più bella bambina che avessero visto nella zona: quando i tre svedesi andavano a Ciriè per compere, erano guardati tutti e tre, per la loro bellezza cinematografica, ma soprattutto la piccola Kristie dai lunghi capelli biondi. Dal fornaio le regalavano le paste, dal droghiere le caramelle, dal fruttivendolo le ciliegie o le pesche. Una donna, che non poteva avere figli, era la moglie di un macellaio, le regalò un capretto cucciolo, che avrebbe dovuto essere sacrificato per la macelleria, ma che invece saltò, vivo e felice, intorno alla piccola Kristie, correndo dentro la tenda, o con lei lungo il ruscello che passava lì vicino. Poi, un tramonto – quell’estate del ’63 fu favolosa per la straordinaria dolcezza del tempo – la piccola Kristie e il suo capretto non tornarono alla tenda. Il padre non avvisò subito la polizia. Lui e la moglie con una grossa torcia elettrica, perlustrarono tutta la notte la zona, ma non trovarono né la bambina, né il capretto. All’alba, allora, avvisarono i carabinieri. E cominciarono allora le battute. Giorno dopo giorno, carabinieri e polizia, mute di canipoliziotto, sommozzatori, ispezionarono chilometri e chilometri quadrati della zona, i sub scesero nei torrenti e dragarono i ruscelletti. Squadre di poliziotti venuti da Torino setacciarono la provincia, interrogando quasi cittadino per cittadino, vicini e lontani dalla tenda dei Kalin. Tra questo branco di poliziotti piovuti da Torino, ce ne era uno, abbastanza vecchio, aveva sessantun anni e una benda sull’occhio sinistro, uno scioperante a Genova gli aveva cavato un occhio con uno di quei ganci che servono per tirar su le casse dalle stive delle navi. Si chiamava Vittorio De Stefanis, era un vecchio, duro piemontese e doveva ormai andare in pensione, anzi lo consideravano già pensionato, e lo mandavano in giro ogni tanto, quasi solo per fargli prendere un po’ d’aria. Questo vecchio orbo, dopo qualche giorno d’indagini, disse al magistrato che dirigeva le indagini che il colpevole della scomparsa della piccola Kristie, poteva essere uno solo, il N.H. Domiziano Doravanti, proprietario di una villa a neppure due chilometri dalla zona dove sorgeva la tenda degli svedesi. Le ragioni per cui pensava questo, erano due. Non solo non si ritrovava la ragazza, ma non si ritrovava neppure il capretto. Se uno avesse rapito la bambina, per portarla lontano, certamente non si sarebbe portato via anche il capretto, che seguiva sempre Kristie. L’altra ragione era che il N.H. era noto in tutta la zona per la sua preferenza per le minori. Le sedicenni, e anche meno, della provincia, se di scarsi principi morali, frequentavano la sua villa, ricevendo lauti compensi. Il magistrato inquirente vagliò questi indizi, forniti dal vecchio poliziotto orbo, interrogò il N.H. Domiziano Doravanti, autorizzò la perquisizione della sua villa, ma non si trovò nulla, non trovarono nulla neppure i cani-poliziotto, né i cervelloni della scientifica. Quindi al poliziotto orbo venne detto di stare calmo, perché la sua ipotesi era nettamente sbagliata e, comunque, non vi erano le minime prove giuridiche della sua colpevolezza e quindi non si poteva fare nulla. Ma Vittorio De Stefanis non si era messo calmo. Continuò a insistere coi suoi superiori che il N.H. aveva violentato la piccola Kristie, l’aveva uccisa e l’aveva seppellita in qualche luogo. Andò in pensione, ma continuò a dirlo, con lettere, con telefonate, andò a scocciare anche tutti i colleghi più giovani. Ma nessuno gli dava retta, era vecchio, era orbo, parlava sempre della stessa cosa, di quella bambina svedese, Kristie, gli dicevano di sì, sì, e lo lasciavano perdere. Ma lui non aveva lasciato perdere, ed ecco, adesso, col tondo, goffo muso della sua «Seicento» che guidava ancora baldamente, era alle soglie di Ciriè, davanti alla villa del N.H. Domiziano Doravanti. Alla parola «polizia», il custode aprì subito il cancello e il domestico, sempre alla parola «polizia» e alla vista della tessera – ormai scaduta da tanti anni ma lui non lo sapeva – condusse il visitatore nella sala dove c’era abbandonato su un divano il nobil uomo Domiziano Doravanti. Tutta la villa era arredata con profondo gusto e ricchezza. Si sentiva che Domiziano Doravanti era signore da secoli, da lunghe generazioni, lo si sentiva fin nell’ultima poltroncina che arredava la sala, vicino alla larghissima finestra che dava sul vasto pianoro verde, dove, cinque anni prima, c’era una grande tenda, con dentro tre svedesi, un professore di matematica, una professoressa di chirurgia ginecologica e una bambina di sette anni di nome Kristie. Ah, più un capretto che non aveva nome. Ecco, era finalmente davanti al suo uomo. «Sono venuto qui solo per farle una domanda, una sola domanda», disse il vecchio poliziotto Vittorio De Stefanis guardando fisso il nobil uomo col suo unico occhio. «La domanda è questa: dove ha seppellito il cadavere della piccola Kristie Kalin che lei ha stuprato e ucciso cinque anni fa?» Il nobil uomo aveva un viso gelido, un’espressione sprezzante. «Lei è pazzo», disse gelidamente. «Le ripeto la domanda», disse paziente il vecchio poliziotto, «dove ha seppellito la piccola Kristie, dopo averne abusato e averla uccisa?» «E io le ripeto che lei è pazzo», disse gelidamente il patrizio. «Va bene», disse allora il vecchio poliziotto, e levò dalla tasca della giacca dove la teneva, così, sciolta, alla buona, la fiammante Herter’s 401 Power Magnum, tutta carica di proiettili dirompenti, «allora ragioniamo in un altro modo. Questa è una rivoltella e ho già tolto la sicura, appena premo il grilletto lei salta come fosse investito da un treno. Cinque anni fa non potevo fare così. Ero un poliziotto regolare, allora. Ero convinto che lei avesse assassinato la piccola bambina svedese, l’ho detto a tutti, ma non avevo le prove, e tutto è finito in niente. Neppure adesso ho le prove, ma ho questa rivoltella e le do tempo due minuti per dirmi dove ha nascosto il corpo della piccola Kristie. Se entro due minuti lei non mi dice dov’è il corpo di Kristie, io le sparo...» Puntando la Herter’s sorrise dolcemente con il suo unico occhio. «Si metta nei miei panni, sono un vecchio poliziotto in pensione di sessantasei anni. O lei mi dice dove ha nascosto il cadavere della piccola Kristie, o io l’ammazzo. Se l’ammazzo, e guardi che sono decisissimo a farlo, cosa vuole che mi possano fare? Mi possono condannare all’ergastolo, ma a un vecchio di sessantasei anni l’ergastolo fa ridere. Le rimane ancora poco più di un minuto per dirmi dove ha seppellito la bambina. Trascorso il tempo io sparo.» Domiziano Doravanti guardò la lunga canna della Herter’s puntata verso di lui. Aveva delle vertigini. «Vede, cinque anni fa io dovevo seguire la legge», disse il vecchio poliziotto, «adesso sono libero da tutto, sono solo un povero vecchio che sta per morire, ma, prima di morire, l’ammazzo se non mi dice dove è il cadavere della piccola Kristie Kalin.» «Io non l’ho uccisa», disse Domiziano Doravanti. Era lucido di sudore freddo. «Mancano solo venti secondi», disse Vittorio De Stefanis, vecchio, orbo ma inflessibile nella sua volontà di giustizia che lo spingeva da cinque anni. «Sai, quando ero un poliziotto legale non potevo interrogarti così, e allora te la sei cavata. Ma adesso non te la cavi. Se vuoi vivere, parla.» «È in cantina», disse Domiziano Doravanti. «C’è anche il capretto, seguiva sempre la bambina, io l’ho portata qui e il capretto le veniva dietro, allora ho dovuto far entrare anche il capretto, qui in villa, ma poi faceva rumore, voleva la sua padroncina, ho dovuto ammazzare anche lui. Sono in cantina, sotto la botte grande, ho lavorato tutta una notte e ho coperto tutto di canfora, così anche quando hanno portato i cani-poliziotto non hanno sentito nulla, la canfora copre tutti gli altri odori...» La squadra di specialisti venuta apposta da Torino, trovò effettivamente in cantina, sotto la botte grande, lo scheletrino della piccola Kristie e del suo capretto, in un polverume bianchiccio che aveva ancora, dopo cinque anni, un vago odore di canfora. «Allora secondo lei non occorrono prove legali per imputare qualcuno di un delitto?» domandano molti giornalisti all’ex poliziotto Vittorio De Stefanis. La risposta è sempre la stessa: «Ma lasciatemi in pace». 37 · È evidente «Mi scusi, dottore», l’uomo aveva un fragile colorito, una pelle lisa, benché fosse giovane ancora, tendeva il foglio di carta, «ha fatto lei questa analisi?» «Sì», disse il dottore, «Personalmente lei?...» disse l’uomo. Il dottore riguardò il foglio solo per gentilezza, per forza le faceva personalmente lui, le analisi. «Sì», disse, e aveva già compreso, non era la prima volta che accadeva così, nella sua lunga carriera aveva visto tutto, era stanco di vedere. «Personalmente», disse. Gli occhi dell’uomo sembrarono sciogliersi, non vi fu più né pupilla, né bianco. «Non può esserci un errore in questa analisi?» disse, ma come senza speranza. Il dottore stava per scuotere il capo, ma si controllò e rimase immobile. Teoricamente sì, poteva esserci un errore, ma era quasi del tutto improbabile. In realtà, poi, l’errore era escluso, e anche uno scambio di analisi era impossibile: da oltre due mesi tutte le donne che avevano fatto l’analisi aspettavano effettivamente un bambino, non c’era stata nessuna analisi negativa, quindi era assolutamente certo che la moglie di quell’uomo alla quale era stata fatta l’analisi, aspettava un bambino. Ascoltò, gentile e stanco, quello che l’uomo gli diceva: «Perché vede, dottore, io non posso fare bambini, ho un certificato, da anni, e a mia moglie non l’ho mai detto, mi vergognavo, non mi avrebbe sposato, se lo avesse saputo...». In piena menzogna, sicuro del contrario, il dottore sorrise: «Ma allora è evidente, deve esserci un errore». Si alzò, la stanchezza non ha limiti, la gentilezza sì. 38 · La vittoria «Ih, ma quella me la ricordo», disse il poliziotto, «batteva più di dieci anni fa, alla fine della guerra; andiamo a vedere...» Camminò col collega verso la donna che stava ferma, per la strada deserta, nel torrido caldo della tarda notte e che li aveva già visti, e li vedeva ora arrivare, ma non si mosse, pur sentendo dentro, anche nell’aria calda brodosa della città addormentata un pugno di ghiaccio nello stomaco, l’agghiacciante memoria della sua vita passata che non si scioglieva mai nella dimenticanza. «Sei proprio tu, la Trude...» disse il poliziotto orgoglioso di averla riconosciuta, la strada era solitaria, la fila di macchine vuote. «I documenti li avrai, ma vieni lo stesso un momentino con noi al commissariato, sei scomparsa per tanti anni, e adesso sei tornata a galla, meglio vedere perché...» «Non ho documenti», disse lei, triste ma vittoriosa, il viso fortemente ma non volgarmente truccato, «ma sta arrivando mio marito.» L’uomo, il grande generoso uomo che era suo marito, arrivava in quel momento dall’angolo della strada col grosso pacco delle scatole di latte in polvere che aveva comprato in farmacia per il loro bambino, allungò iroso il passo vedendola con i due, e chiese pronto a scattare: «Cosa c’è?». «Sono della polizia, volevano i miei documenti», disse la donna, triste di quel richiamo al passato, ma vittoriosa, aprendo lo sportello della grossa auto vicino a lei e sedendo dentro: vittoriosa, di non essere più, mai più, la Trude che era stata, mentre suo marito mostrava ai poliziotti la sua tessera di ingegnere del Comune, lei da molto ormai, era un’altra donna. 39 · Nessuno deve ridere L’avvocato cercava di capire, ma per difendere quel bruno, peloso, anziano uomo che non sarebbe mai incanutito, doveva capire bene, e non era facile. «Questo quando è avvenuto?» disse. «Sette anni fa», disse l’altro, nella squallida cella del carcere. «Allora tua moglie era stata quasi un anno con un altro uomo, poi era tornata pentita e tu te l’eri ripresa», disse l’avvocato. «Perché l’hai perdonata?...» L’individuo fuori del tempo alzò le spalle. «La gente non sapeva niente, io avevo detto che lei era andata a Roma da sua madre e tutti ci avevano creduto... A me faceva comodo una donna in casa. Il bambino non potevo mica continuare a guardarlo io...» «Ma non t’importava che tua moglie fosse stata un anno con un altro uomo?» Lui alzò le mani coperte di peli, non disse niente, parlavano le mani, da sole, ma volle farsi capire bene e allora aggiunse: «La gente non sapeva niente». Perciò, dicevano le mani, che doveva importargliene? L’avvocato guardò l’orologio, era lì da quasi un’ora e non capiva ancora bene. «Ma allora perché il mese scorso tu hai preso a coltellate tua moglie dicendo che lei ti aveva tradito, sette anni fa, era stata, sette anni fa, con un uomo?» L’altro alzò ancora le mani, appariva stanco della futilità delle domande: «Ma perché mia moglie, dopo sette anni, lo ha confidato a un’amica, che era stata con un altro, e la gente così lo ha saputo e mi rideva in faccia. L’ho ammazzata come se l’avessi saputo solo allora, delle corna, perché a me nessuno deve ridere in faccia, nessuno...». 40 · Notte di distruzione Solo verso le due del mattino, dopo aver frugato in tutti i cassetti, in tutte le scatole, e aver buttato sul letto ogni lettera che trovava, e averne scorso qualcuna, ritrovando in questa o quella frase un momento del suo passato, un uomo antico, Ferruccio, di quando aveva sedici anni, o molto, anche troppo recente, come Sergio che aveva continuato a frequentare anche mentre cercava il nuovo appartamento da sposa; solo a quell’ora, si rese conto dell’enormità del problema. Il letto era tutto coperto da uno spesso strato di lettere, ostinatamente conservate dall’adolescenza per quasi diciotto anni, attraverso tutti i traslochi, prima, di suo padre ispettore, e poi di lei divenuta hostess, così in qualche lettera c’erano le raffinate scurrilità di David, poeta e teddy boy londinese, o le morbose fantasie orientali di Rahy, studente in fisica nato a Calcutta e residente a Parigi, e perché avesse avuto la mostruosa costanza di conservarle lei non sapeva, ma adesso, a trentaquattro anni, non poteva portarsele in casa dello sposo, doveva distruggerle. Ma come? Bruciarle, ma dove? Nelle riviste d’arredamento c’è sempre una sala col caminetto, ma in quel marziano, cementizio quartiere vicino all’aeroporto nessun architetto vi aveva pensato. A bruciarle sul gas, un poco per volta, sarebbe morta asfissiata e aveva paura di mandare a fuoco la casa. Guardò l’ora: le due e un quarto, esausta e rassegnata sedette sul letto, sulla coltre di parole amorose e sensuali, e cominciò a stracciare una per una, minutamente, le lettere: avrebbe visto sorgere il sole. 41 · Troppo tardi Zoppicava un poco, ma appena appena, pochi se ne accorgevano guardandola camminare. Chiese del dottor Cavenari al custode della lussuosa portineria, che la guardò, ma solo per un attimo: quel segno alla mascella, rotta, e quel gonfiore allo zigomo destro, rotto, coperto dai bei capelli rossicci, ma non sufficienti a nascondere tutta l’asimmetria del viso; in fondo, per una che si era buttata dal terzo piano, le era andata ancora bene; all’ospedale il chirurgo aveva detto: «Ma io non ci credo, questa è scivolata su due scalini, non dal terzo piano: non si è fatta niente». E lei aveva tanto rimpianto di non essersi fatta quasi niente, aveva proprio sperato che buttandosi da quella finestra sarebbe tutto finito, invece non era finito niente. Poi il custode, dopo averla guardata, le disse: «Chi devo annunziare?». «Sono sua moglie», lei disse. La voce le si era molto arrochita, come immaschilita, perché aveva battuto col collo, per fortuna di striscio, contro il ramo di un albero, però cadendo dal terzo piano era uno striscio che le aveva lasciato quella profonda cicatrice al collo e le aveva leso tutto l’apparato vocale, così alcune volte parlava come un vecchio signore, in tono baritonale, e altre volte, al contrario, diveniva una supersoprano. Il custode, era un uomo che aveva imparato a vivere, non disse nulla. Staccò il ricevitore del citofono, attese, poi disse: «Avverta il dottore che sta salendo la sua signora». Lo disse in un modo, con un tono, come se mettesse assolutamente in dubbio che si potesse trattare della signora del dottor Cavenari. Lei ascoltò, premendo le dita del piede destro, molto fortemente, in terra, perché era il piede leso e premendolo così si sentiva un po’ meglio. Aveva in mano un grande pacco lungo, uno scatolone. Il custode, riguardandola un poco, pensò che forse poteva essere la signora del dottor Cavenari, ma d’un tratto al citofono gli arrivò la voce gentile ma fermissima del dottor Cavenari: «Non desidero ricevere questa persona. Le dica che non ci sono, anche se ritornasse le dica sempre che non ci sono». “Ah”, pensò il custode, “ho fatto bene a non farla salire subito.” Riattaccò il ricevitore del citofono. «Il dottore non c’è», disse. Lei guardò il viso piatto del custode, era come guardare una sedia. Poi guardò il lungo scatolone che aveva in mano. Doveva essere pagato bene quell’uomo da suo marito: non l’avrebbe mai lasciata passare, per arrivare alle vette eccelse di suo marito. «Grazie», disse. Col suo lungo scatolone se ne andò, da quella faccia senza nessuna espressione, scese zoppicando i tre scalini che portavano sulla strada, era riuscita a parcheggiare la macchina quasi davanti al portone, aprì la portiera della lunga Jaguar blu scuro, e avviò l’auto. “Lisetta”, pensò, “Lisetta.” Ormai non era neppure più un pensiero, era sempre come un piangere. Guidò piano, col lungo scatolone sul sedile di fianco, guardando più lo scatolone che la strada, la leggera ma lunga cicatrice al collo nascosta da una pesante collana d’oro, e aveva molte altre collane, ugualmente pesanti, ma di stile diverso, sempre per nascondere quella cicatrice. Arrivò in piazza della Repubblica e guidò la Jaguar davanti all’entrata dell’Hôtel Palace. Il portiere accorse subito, insieme con un valletto. Lei scese, prese lo scatolone, il valletto tese le mani per portarglielo lui. «Grazie, lo tengo io», lei disse con gentilezza. Attraversò il salone dirigendosi verso gli ascensori, il lift appena la vide, ma zoppicava appena appena, lei, bloccò l’ascensore e si offrì anche lui di tenerle lo scatolone. «Grazie», lei disse, sorridendo gentile e un poco asimmetrica per quel gonfiore allo zigomo destro. Uscì dall’ascensore, percorse il corridoio, appartamento 92: bussò. La porta si aprì dopo un poco, ma solo uno spiraglio. Gli occhi celesti di un giovane biondissimo, sembrava platinato come una donna, ma si capiva che si trattava del colore naturale dei suoi capelli, la guardarono, e allora la porta si aprì completamente e lei entrò senza dire nulla, come non aveva detto nulla il giovane, attraversò l’anticamera, entrò nella sala, e andò a sinistra, nella sua camera, il giovane biondo la seguiva, ma lei gli chiuse la porta in faccia, sempre senza parlare, e poi girò la chiave. Sedette sul letto, col suo scatolone, respirò profondamente un paio di volte, poi aprì lo scatolone, cioè lo svolse dalla carta bruno oro, strappò con rabbia il cordoncino oro, con rabbia e amore, con rabbia e lacrime che non piangeva, perché ormai non piangeva più, tolse il coperchio della lunga scatola a fiori, strappò con violenza la carta velina, uno strato, due, e sotto c’era la bambola. La tirò fuori dalla scatola. Era una bambola molto grande, era forse un poco più grande di una bambina vera e se la tenne sulle ginocchia, piegandola in modo che sembrava tenere una bambina vera sulle ginocchia. Era una bambola che aveva all’interno un registratore a pile. Schiacciò il bottone. Al momento non successe nulla, si udì solo uno sfrigolio di rotismo che gira, nella grande, lussuosa camera, dal grande lussuoso armadio bianco crema filettato d’oro, dalle tende che occupavano un’intera parete dal soffitto al pavimento, poi una voce, una voce infantile, di una bambina di tre anni o poco più, cantò: «Per un ditino nel telefono... Sono successi tanti guai... Conosce poco i numeri e leggere non sa... Arrivò la polizia e portò via il mio papà...». Era una delle canzoni cantate alla televisione nel programma «Lo Zecchino d’Oro», e lei l’aveva fatta incidere sul nastro del registratore, insieme ad altre dello stesso genere. Sembrava proprio che fosse la bambola a cantarla, e lei ascoltava, con la bambola sulle ginocchia. «Conosce poco i numeri e leggere non sa», alzò il volume perché la botta presa buttandosi dal terzo piano le aveva leso anche l’udito. «...Arrivò la polizia e portò via il mio papà.» Bussarono, ma lei non sentì, anche per la bambola che cantava, poi bussarono più forte e allora udì, posò la bambola sul divano e andò ad aprire. Lui entrò, era molto alto, un po’ magro, un po’ legnoso, aveva un impermeabile nero aperto sull’abito grigio chiarissimo e i capelli rasati quasi a zero. Restò ad ascoltare la bambola che, seduta sul divano, tutta da sola, continuava a cantare. «Conosce poco i numeri e leggere non sa... Arrivò la polizia... e portò via il mio papà.» Allora lui andò vicino al divano, vicino al divano, come per ascoltare meglio. «Non hai potuto vedere Lisetta?» disse a lei che era alle sue spalle. «No», lei disse. «Non ho potuto neppure lasciare la bambola.» «Per un ditino nel telefono... sono successi tanti guai...» Lui schiacciò il bottone sulla schiena della bambola, il registratore si fermò. «Sarebbe stata tanto contenta, Lisetta, di questa bambola.» Parlava con tanta calma. Poi disse: «Te l’avevo detto però che non sarebbe servito a niente. Con quell’uomo niente serve a niente». Sedette sul divano accanto alla bambola. «Carla, io ti voglio bene», abbassò il capo, come per pudore, dicendolo, «e appunto per questo devo parlarti francamente: tu non rivedrai mai più la tua bambina. Conosco quel genere di uomini», abbassò la voce, si tolse l’impermeabile, «è l’uomo onesto e spietato, cioè è peggio di me. Io almeno sono un delinquente dichiarato, sono uscito di galera quattro mesi fa, insieme con te, tutti sanno chi sono, se rubo, se sparo, se ammazzo qualcuno, nessuno si meraviglia, ma lui è la statua dell’uomo onesto, del professionista di valore, ma è un assassino, non ammazza sparando, come ammazzo io, lui ammazza senza armi, lui lo sa benissimo che se non ti fa vedere la bambina è come se ti ammazzasse, e non te la fa vedere apposta per ammazzarti. Ti sei già buttata dal terzo piano, per morire, perché non potevi vedere Lisetta. E una volta o l’altra potresti ripetere il salto.» Parlava sempre più ringhiosamente, andò a sedersi sul letto, guardò il sole che attraversava le tende come nebbia luminosa. «Non posso vederti in quello stato, mi fai stare male, pensa che la tua bambina sia morta, lasciagliela, lasciala all’onorato notaio, che se la tenga, e non ci pensare più.» Lei non diceva nulla, ma ascoltava attenta. Le piaceva il viso magro di lui, e la sua voce, e soprattutto le gonfiava il cuore di tenerezza, la sua rabbia, in quel momento, mentre le parlava, così a bassa voce e ringhioso, e che dimostrava il trasporto che aveva per lei, da anni, e nessuno poteva supporre tutta quella sensibilità in un uomo che in ogni questura di ogni città d’Italia aveva il cartellino segnaletico con la foto e le impronte e la definizione pericoloso. Ma anche se non diceva nulla, pensava. E pensava: «Io rivedrò Lisetta». Lui si alzò, la guardò, l’espressione dura per nascondere quello che lei soffriva. «Forse domani o dopo dobbiamo andar via da qui, molto lontano», si avvicinò alla porta e l’aprì. «Cerca di dimenticare, è l’unica cosa che puoi fare.» Uscì, e richiuse la porta, ma delicatamente, perché era un violento, ma al momento giusto e con le cose giuste, non con le porte. Si può dimenticare la propria figlia? Non era la prima volta che Stefano glielo diceva. La prima volta gliel’aveva detto quando, precipitandosi per le scale, l’aveva raccolta, come sfasciata, sul marciapiede, sotto la finestra dalla quale si era buttata. «Dimentica, dimentica, dimentica.» Ma una figlia non si può dimenticare. E quando lui fu uscito, da un cassetto dell’armadio prese la busta di carta da lettere, dalla borsetta prese la penna e sul piccolo tavolo davanti alla grande tenda che occupava tutta la parete, accesa del sole del pieno mezzogiorno, si mise a scrivere. Caro Paolo, lo so che non ti piace che io ti scriva, e che ti scriva «caro Paolo», ma tu sei il padre della mia Lisetta, e io non posso fare a meno di chiamarti così. Questa mattina sono stata a casa tua, volevo soltanto portare una bambola a Lisetta e vedere un momento la bambina. Tu mi hai fatto mandare via dal portinaio. Hai ragione tu, lo so benissimo, io sono il disonore della tua vita, e di tutta la tua famiglia, del tuo nome, che non posso più portare perché il tribunale, grazie ai tuoi avvocati, me lo ha proibito. Tu hai avuto la sfortuna di sposare una donna che, dopo pochi anni di matrimonio, ha lasciato il marito e una bambina piccola per andare insieme con un contrabbandiere ricercato dalla polizia e ogni tanto arrestato, così che alla fine sono stata in carcere anch’io, che porto il tuo nome. Io sono indegna di portare il tuo nome, sono indegna di essere tua moglie, sono indegna di tenere la bambina, e infatti non ti ho chiesto mai di tenerla, non ho mai preteso di averla, anche se così piccola potrei tenerla meglio io che le tue bambinaie, ma io vivo con un delinquente e quindi non posso tenere una figlia, lo so, e penso che sia giusto così. Io ti chiedo solo di lasciarmela vedere, per cinque minuti, solo cinque minuti, una volta ogni tanto, quando tu vorrai, ma almeno vederla. Lasciamela vedere, lasciami parlare con lei solo cinque minuti, lascia che le possa portare qualche giocattolo, lascia che le possa parlare, solo cinque minuti, lei lo sa che io sono la sua mamma le dirò che la mamma deve viaggiare tanto, che va tanto lontano, e per questo può vederla solo così poco. Lasciamela vedere, Paolo, te lo chiedo soprattutto per me, ma anche per Lisetta: una bambina non può crescere bene senza vedere mai la sua mamma. Lasciamela vedere, Paolo, solo cinque minuti. Ti prego. L’altra volta ti ho minacciato che mi sarei uccisa se non me la lasciavi vedere, e infatti mi sono buttata dalla finestra. Ma questa volta non ti minaccio, ti prego soltanto: lasciami vedere Lisetta, è più di un anno che non la vedo, lasciami, lasciami vedere la mia bambina. Domani alle tre del pomeriggio sarò ai Giardini pubblici, dall’entrata di piazza Cavour, vicino alla fontana. Mandami Lisetta, accompagnata dalla bambinaia, solo per cinque minuti, solo per vederla, per sentire la sua voce. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, lasciami vedere la bambina. Capì di aver scritto troppi ti prego per il gusto di Paolo che era un uomo molto raffinato e non amava le ripetizioni ma non ne cancellò neppure uno. Scrisse il suo nome sotto l’ultima frase: lasciami vedere la bambina. Carla; chiuse la busta, telefonò al centralino. «Per favore, posso avere subito un fattorino per la consegna di una lettera?» disse. «Sì, signora», rispose la ragazza del centralino. «Le mando subito il fattorino.» Al ragazzotto che venne dopo pochi minuti lei dette la lettera. «La consegni personalmente al dottor Cavenari e gli dica che è urgente...» Poi andò a sedere nella poltroncina vicino alla finestra, ad aspettare l’indomani. Fu molto lento, un indomani non arriva subito subito, è sempre un indomani. All’una bussò alla porta della camera il biondino platinato. «Vieni a mangiare, se no Stefano si arrabbia.» «Sì, Gianni.» Accompagnata da Gianni salì alla terrazza-ristorante. Stefano era già lì, al solito tavolo, l’impermeabile nero ripiegato su una sedia, e forse da seduto si vedeva meglio quanto era alto. Un poco zoppicando sedette alla tavola, tentò di presentargli un’espressione non troppo sofferente, ma sapeva che non poteva ingannarlo. «Cerca almeno di mangiare», le disse Stefano. «Sì, Stefano», gli sorrise, sorrise anche a Gianni, il biondissimo. «Fettuccine, col ragù», disse al cameriere. E anche la sera, ancora sulla terrazza-ristorante, da cui si dominava dall’alto una Milano illuminata come una processione, ordinò cose sostanziose, lo stufato con la polenta, così Stefano non si sarebbe irritato, a Stefano non piaceva se lei non mangiava e aveva l’aria triste. E dopo pranzo si ritirò nella sala dell’albergo dove c’era il televisore, perché Stefano le disse che doveva andare con Gianni in un certo posto, e lei vide tutto il programma, per aspettare l’indomani, e poi andò in segreteria e un impiegato l’informò che la sua lettera era stata consegnata personalmente al dottor Cavenari dal fattorino dell’albergo, e allora andò al bar e tentò di ubriacarsi, ma riuscì a bere abbastanza da sperare di poter rivedere Lisetta l’indomani. Per sperarlo ancora più vivamente bevette finché non cominciò ad aver mal di stomaco, poi, abbastanza felice e malferma sulle gambe, ritornò nell’appartamento numero 92. Dovette attendere un poco più del solito, poi oltre la porta udì la voce di Gianni: «Chi è?». «Sono io», lei disse. Il biondissimo aprì e lei entrò, attraversò l’anticamera, andò nella sala, vide di spalle Stefano, senza giacca: quando era seduto, con quel biancore vivissimo della camicia, sembrava ancora più imponente. Poi, oltre di lui, sul tavolo rotondo vicino alla finestra-terrazzo, vide quella cosa. Non che gliene importasse molto, così piena di whisky come era, così piena delle speranze che forse l’indomani avrebbe rivisto Lisetta, ma insomma era sempre un mitra, e un mitra è sempre una cosa che si guarda, specialmente se è su un tavolo in un appartamento di uno dei primi alberghi di Milano. E guardò Gianni che da una scatola vicino al mitra levava un pennellino, e con quello si metteva come a pulire, o meglio a dipingere, la stecca del caricatore, mentre Stefano da una borsa che era in terra levava un altro mitra, identico a quello che era sul tavolo. Un poco vacillando lei si avvicinò ancora di più al tavolo. «Perché queste robe?» disse, voleva dire i mitra. Lui non rispose alla sua domanda, ma le disse: «Hai bevuto?». «Sì», lei disse. «Allora prendi un sonnifero e va’ a dormire», lui disse lavorando intorno al mitra che aveva tirato fuori dalla borsa in terra. «Sì, Stefano», lei disse. L’alcool la rendeva conciliante, serena, ubbidiente, andò nella stanza grande, prese due pastiglie di sonnifero e si mise a letto, e per pochi minuti vide Lisetta che le correva incontro, ma sullo sfondo c’erano dei mitra, come dei corti fucili, e la lunga magra mano di Stefano ne teneva uno sollevato, e anche Gianni teneva il mitra in alto, steso per tutta la lunghezza del lungo braccio, poi arrivò il sonno come una mazzata, e non vide più nulla. A un certo punto vide la mano di Stefano che le passava sugli occhi. «Sono le undici, hai preso troppo sonnifero, svegliati, Carla», le diceva la voce di Stefano. Si svegliò, solo per la frase «sono le undici». Questo voleva dire che mancavano solo quattro ore al momento di andare ai Giardini e attendere di vedere Lisetta. La doccia di acqua miscelata calda e fredda, gli aperitivi ghiacciati che scuotono, poi la sostanziosa colazione con Gianni a sinistra e Stefano a destra, sotto il sole che accendeva tutta la terrazza: erano arrivate le due e mezzo. «Dove vai?» le disse Stefano quando si alzò. «Vado a fare due passi ai Giardini.» «Non stare via molto, devo parlarti, perché domani partiamo.» «Sì, Stefano», sorrise anche a Gianni e scese a pianterreno. Non usò la Jaguar, i Giardini erano lì, bastava attraversare la piazza. L’attraversò, col suo lieve, quasi innotabile zoppichio, entrò, più felice che ansiosa, quasi certa di rivedere Lisetta e andò nel largo dove era la fontana, vi erano due panchine libere, scelse quella più in vista, in modo che la bambinaia e Lisetta arrivando la vedessero subito e del resto chiunque l’avrebbe notata per il giallissimo abito e il foulard bianco al collo, allacciato alla boy-scout. Attese fino alle cinque, in un continuo, graduale scolorire della sua felicità. Alle tre e un quarto era ancora felice perché sperava ancora, Paolo non poteva rispondere con un rifiuto alla lettera che gli aveva scritto. Non era possibile. Va bene, lei viveva in giro per gli alberghi con un bandito e col suo compare, era stata in galera con loro, era stata lei ad abbandonare la bambina, per andare con quell’uomo, ma perché non lasciarle vedere Lisetta? Alle quattro capì che la bambinaia non sarebbe più venuta con Lisetta, ma per una decina di minuti tentò di illudersi che forse la bambina aveva dormito un poco di più nel pomeriggio, e così gliel’avrebbero portata in ritardo. Poi capì che voleva illudersi, e decise di aspettare fino alle cinque: per principio. Perché Paolo non potesse dire che le aveva mandato la bambina in ritardo e che lei non aveva avuto la pazienza di aspettare. Ogni tanto si alzava e faceva un breve giro intorno alla fontana, non vi erano molti bambini, quei pochi erano più grandi di Lisetta, non poteva neppure, guardando qualcuna di quelle bambine, pensare per un istante che fosse la sua Lisetta. E alle cinque esatte si allontanò dal luogo del non avvenuto appuntamento, tornò all’Hôtel Palace, entrò in una delle cabine telefoniche della sala. Aveva tanto pensato in quelle due ore di attesa. Formò il numero di telefono dello studio di Paolo, sapeva che a quell’ora lui era in ufficio, e sapeva come ottenere di parlar con suo marito. «Studio Cavenari. Prego?» disse la voce dell’impiegata, era una nuova, per fortuna, che non poteva riconoscere la sua voce, del resto non più riconoscibile. «Segreteria del commendator Gabbi. Per favore il dottor Cavenari all’apparecchio. Il commendator Gabbi deve parlargli», recitò lei con voce fredda. Il commendator Gabbi era il più importante cliente di suo marito, era l’amministratore delegato della VAR, ed era l’unica persona di cui il suo superbo e onnipotente marito avesse quasi timore. Infatti l’impiegata disse agitata: «Subito, signorina, subito». Paolo doveva averle spiegato a lungo l’importanza del commendator Gabbi. E fu veramente subito che le arrivò la voce di suo marito: «Pronto?». Esitò un attimo, sapeva che suo marito si sarebbe terribilmente infuriato di quel tranello, ma la disperazione la spingeva e disse con voce acuta che Paolo non avrebbe potuto neppure riconoscere: «Sono Carla, per pietà, lasciami vedere ogni tanto la bambina, per pietà, per pietà, per pietà...». Si mise a piangere, ma la cabina era completamente isolata, e temette che lui togliesse la comunicazione e allora tra le lacrime gli gridò: «Non staccare, non staccare, ascoltami, solo qualche minuto ogni tanto, anche ogni due o tre mesi, ma lasciamela vedere, non staccare». «Non stacco», lui disse, «perché devo avvertirti che ho incaricato il mio avvocato di denunziarti per molestie. Vieni a infastidirmi a casa, mi scrivi lettere minacciose, e mi fai queste telefonate trabocchetto immischiando il nome del commendator Gabbi...» «Paolo, Paolo, non voglio molestarti», suo marito si era proprio infuriato, «ti chiedo solo, per pietà, di lasciarmi vedere Lisetta... non staccare per pietà, Paolo.» «Non tolgo la comunicazione», lui disse con quella sua calma insultante, «perché non hai ancora capito che cosa significa per te la denunzia per molestie. Significa che domani sera torni in carcere», il tono insultante divenne anche carico di odio, «tu e i tuoi amici siete vigilati dalla polizia, anche se riuscite a cavarvela perché avete soldi e protezioni misteriose. Ma una denuncia fa saltare tutte le vostre protezioni...» Lei non lo ascoltava, forse non capiva, ripeté ancora: «Lasciami vedere Lisetta, per pietà... sono la sua mamma...». E la voce di lui, insultante e carica di odio, disse: «Tu non rivedrai più Lisetta. Tu non sei una madre, sei una sporca donna, una...». Allora fu lei a troncare la comunicazione. Aveva compreso. Nel chiuso della cabina si. asciugò bene gli occhi, mentalmente continuò a ripetersi: «Non sono una madre, sono una sporca donna, una...». Poi uscì. Aveva deciso, sapeva ciò che doveva fare, e uscendo dalla cabina fu come se vi lasciasse dentro quel ramoscello di ulivo col quale, in segno di pace, di pentimento, di umiltà, si era fino ad allora inginocchiata davanti a Paolo, per poter rivedere la sua bambina. Adesso basta. Salì con l’ascensore, appartamento numero 92. Bussò. «Dove sei stata tutto questo tempo?» le disse Stefano. «Avevi detto che tornavi subito.» «In giro», lei disse. «Vieni, Stefano, ho bisogno di parlarti...» Andò nella sua stanza, egli la raggiunse subito, in quell’abbagliante camicia bianca, e sedette sul letto, e lei andò a sedersi vicino a lui. Lo guardò, senza lacrime negli occhi, senza commozione nel viso. «Stefano, è un discorso molto importante, devi rispondermi senza pietà. Non voglio pietà.» «Avanti», lui disse brusco. Conosceva già il soggetto di quella conversazione. «Stefano, tu lo sai», lei disse, e questa volta la voce le divenne bassissima e rauca, come da uomo, «io non riesco a vivere se non vedo la mia bambina. La prima volta ero ingenua e mi sono buttata solo dal terzo piano, ma qui, in questo albergo, se mi butto dalla terrazza-ristorante, non sbaglio più.» «Non parlare in questo modo, se no ti do uno schiaffo», lui disse, fissandola inquieto, eppure intenerito. «Puoi darmi tutti gli schiaffi che vuoi, ma se io non vedo la mia bambina mi ammazzo.» Riprese fiato, cominciava ad ansare, e la voce ora strideva acuta, ora era bassa e roca. «Non lo so perché ti interessi tanto di me, adesso sono proprio un rottame, si vede dalla faccia, si sente dalla voce, e ho sempre la testa presa dalla bambina, e non ti guardo neppure, e così non so neanche perché mi tieni, ma se ti importa qualche cosa di me, se non vuoi che mi ammazzi, aiutami.» L’espressione le si indurì. «C’è un mezzo perché io possa rivedere Lisetta, e non solo rivederla, ma averla sempre con me. E solo tu puoi aiutarmi.» «Avanti.» «Ammazzalo», lei disse, con distacco, senza agitazione. «Se il padre muore, la figlia viene affidata alla madre. Io sono la madre e Lisetta sarà affidata a me.» Lui la guardò negli occhi. La conosceva, sapeva che voleva veramente che lui lo ammazzasse. «Se non rivedo Lisetta non posso vivere, e l’unico mezzo per rivederla è che lui muoia.» Allora lui disse: «Calmati.» «Sono calma, tu lo sai.» «Lo so, hai ragione. Ma dimmi che cosa è successo.» Lei glielo disse. «Ti avevo avvertito che lui non ti avrebbe mai lasciato rivedere la bambina.» Stefano si alzò. Disse calmo, anche lui era molto calmo: «Avevo già pensato anch’io di ucciderlo. Non ti posso più vedere in questo stato. Ti darei un sacco di botte dalla mattina alla sera, o ti butterei fuori, non so perché ti tenga, dopo tutto quello che mi hai fatto passare da quando hai tentato di ammazzarti. Cosa vuoi che me ne importi della tua bambina, non è mia figlia, e cosa vuoi che me ne importi di una come te, impazzita perché non può avere la bambina. Hai fatto impazzire anche me con questa storia. Vattene pure, ucciditi pure. Io non resisto più. Lo ammazzerei davvero per averti ridotta in questo stato, ma non ho voglia di andare in galera per una faccenda che non mi riguarda. Fa’ quello che vuoi, ma lasciami in pace». «Sì, hai ragione», lei disse, alzandosi, ed era così piccola in confronto a lui. «Andrò via.» Prese la borsetta, non aveva bisogno di valigie, per il luogo dove intendeva andare, e andò verso la porta. Lui la fermò, afferrandola così forte alle braccia che lei gemette. «Non ti lascio andare via, lo sai bene, ma non fare impazzire anche me», l’abbracciò, soffocandola. Lei non riuscì a piangere, lo avrebbe voluto, tanto, ma non era più possibile: le lacrime che aveva pianto prima erano state davvero le ultime. Poté soltanto dire, col capo appoggiato sul suo petto: «Perché mi vuoi così bene? Io non sono più nulla, ormai». Lui allentò la sua stretta, ma le carezzò il capo, i lunghi capelli rossicci. «Adesso andiamo via», le disse, «dobbiamo andare in Inghilterra, qui non possiamo più stare, uno dei nostri è stato arrestato, è il più stupido, finisce per confessare tutto alla polizia e allora siamo di nuovo nei guai. Cerca di dimenticare, Carla, cerca di lasciar passare il tempo...» Ma vide lei che alzava il capo e gli faceva cenno di no. E capì che aveva ragione, una madre non può dimenticare la sua bambina. «Va bene», le disse allora, «ma adesso riposati un poco, partiamo fra poche ore e dobbiamo fare un lungo viaggio. Mettiti qui sul letto, io vado via un momento, poi ci rivediamo», dal modo come lei annuiva e ubbidiva passivamente, capiva anche troppo bene quello che pensava. La obbligò a distendersi sul letto. «Ciao, ci vediamo fra poco.» Era irrigidito anche lui, come lei, tremava dentro, di furore e di tenerezza. Uscì dalla stanza e andò nella sala. Gianni stava chiudendo una delle loro due valigie. Si accese una sigaretta e gli disse: «Va’ subito da Carla. Non lasciarla un minuto, vuole ammazzarsi, come l’altra volta». Gianni fece cenno di sì, tirò tutta la lampo e mise la valigia in terra. «Sì, ho capito», disse. «Dovresti farla curare da un medico, tenerla in una clinica, non è più normale.» «Tu pensa agli affari tuoi.» «Scusa», disse Gianni, in fondo era un timido, anche se sapeva sparare così bene. «Partiamo sempre stasera alle otto e mezzo?» «Certo. Alle otto e mezzo fatti trovare pronto, con la tua macchina qui davanti all’albergo. Io adesso devo uscire, va’ subito da Carla e non lasciarla un attimo. Appena volti l’occhio lei è capace di spaccarsi la testa contro il muro. Stai attento, se no me la prendo con te.» Uscì dal Palace con la Jaguar di Carla e con uno dei due mitra avvolto nell’impermeabile. Sapeva dove andare, un uomo conosce tutto del marito della donna che ama, a volte perfino gli orari. Per esempio il dottor Cavenari usciva dall’ufficio al massimo verso le otto, ma di solito prima, quindi lui ebbe tutto il tempo per condurre la Jaguar al posteggio della Stazione Centrale e di andarsene a piedi, con l’impermeabile sul braccio col corto mitra sotto, come un placido turista che ha paura della pioggia, in cerca di un’auto da rubare. Aveva cominciato a quindici anni a rubare auto, quindi nulla, in questa scienza di impadronirsi di un’auto, gli era sconosciuto. Trovò presto una bella Giulietta scura di cui aprì la portiera e sbloccò l’antifurto col ferretto apposito e con pochi gesti precisi, e poco dopo le sette, sull’imbrunire, nella luce falsa del crepuscolo, era sul piazzale di Porta Romana e fermava la Giulietta un po’ prima del portone dell’ufficio dal quale, verso le otto, sarebbe uscito il dottor Paolo Cavenari, per incontrarsi con le pallottole del suo mitra. Naturalmente lui continuava a pensare che doveva esserci qualche altro modo di risolvere la questione, mentre guardava dal finestrino dell’auto il portone dal quale sarebbe apparso il suo bersaglio. Ma non vi erano altri modi. Carla si sarebbe uccisa se non avesse avuto la sua bambina, era questione di ore, Gianni e lui non potevano passare tutta la vita a farle la guardia. Aveva calcolato quasi tutto, non si può mai calcolare tutto, aveva calcolato perfino la strada di ripiegamento, quel piazzale di Porta Romana era l’ideale per uno che scappa con l’auto, con tutte quelle strade larghe piene di svolte, e quando vide il suo bersaglio uscire dal portone lo riconobbe immediatamente, se l’era guardato con tutto comodo all’ultimo processo due anni prima, quando lui era comparso a testimoniare contro Carla e contro di lui, svolse di schianto l’impermeabile, prese il mitra e nel mezzo buio, perché i lampioni non erano ancora accesi, sparò la raffica, fin quando non fu sicuro che l’altro aveva chiuso i conti con questo mondo. E quasi nello stesso tempo innestò la marcia e la Giulietta sgroppò come una puledra impazzita, e rombò via verso la circonvallazione. Anche se c’era un poco di gente, nessuno fece in tempo a capire nulla. Agli spari, come lui sapeva, pratico di quel lavoro, cominciarono tutti a scappare, a nascondersi, e nessuno vide nulla. E una decina di secondi dopo gli spari lui era già lontano, in viale Montenero, poi voltò a destra, poi a sinistra, poi a destra, poi a sinistra e fece questo lavoro quattro o cinque volte, fino a quando non fu sicuro che nessuno l’aveva seguito, che nessuno aveva capito cosa era successo, che avevano trovato solo un morto, il dottor Cavenari, e che ci sarebbe voluto tempo prima che la polizia potesse avere la minima traccia. Ma lui sarebbe stato ben lontano e al sicuro in un paio di giorni. Allora scese di macchina, andò a piedi alla stazione, l’impermeabile sul braccio e il mitra ancora un poco caldo sotto, dette duecento lire di mancia al custode e salì sulla Jaguar, la mise in moto, e arrivò subito al Palace. Era in anticipo. Salì all’appartamento 92. Bussò. Il platinato aprì subito, aveva un viso stravolto che a lui non piacque. «Cosa è successo?» Pensò alla polizia, lo sorvegliavano sempre. «Non lo so, non l’ho lasciata mai un momento», il ragazzo aveva paura di lui, camminava all’indietro, «ma ha preso qualche cosa, magari davanti a me, non lo so che cosa, non è cianuro, non ha nessun odore, ma è morta. È un’ora che è morta, e non sapevo cosa fare, tu non tornavi mai.» Non lo ascoltò più e corse nella stanza di lei. Stava sul letto, composta, con quello zigomo destro gonfio e le labbra nettamente blu, che cosa potesse mai aver preso, sotto gli occhi di Gianni che la sorvegliava, non si sarebbe saputo mai, e non aveva più alcuna importanza. Sedette sul letto accanto a lei e si coprì gli occhi per non guardarla. Era venuto per dirle: «Fra un mese o due i nostri avvocati ti faranno riavere la bambina, per sempre», e lei invece era lì, morta. Aveva pensato che non avrebbe mai più avuto la sua bambina, né con l’ulivo, né col mitra. «Chiama il direttore dell’albergo», disse. Mise una mano sul volto di lei, per non vedere quelle orribili labbra blu, e pensò di dirle: “Perdonami, sono io la causa di tutto, sono io che ti ho condotto a questo punto”. Scosse il capo. Era proprio lui il vero colpevole, ma le voleva tanto bene. Le aveva voluto, cioè, perché adesso era morta. 42 · Un attimo di nostalgia «Infermiera, faccio quasi sempre i turni di notte», raccontò lei mentre la ragazza bionda e profumata guidava l’auto nella pioggia, «da cinque giorni facevo la guardia a un vecchio che è morto stanotte, avrei dovuto rimanere fino al mattino, ma i figli del morto mi hanno mandato via, se no dovevano pagare un’altra notte e per un morto non hanno voluto...» L’avevano quasi sbattuta fuori, al telefono i posteggi dei tassì non rispondevano neppure, e si era ritrovata alle due in quel vialone di periferia sotto un’acqua da annegare, per fortuna quella ragazza, di cui aveva indovinato subito il mestiere, si era fermata a raccoglierla, anche se lei era un poco a disagio a viaggiare con una di quelle, ma era meglio che pigliarsi una polmonite sotto la pioggia fredda, e quella ragazza era così cortese che l’accompagnava a casa. «Volevo fare anch’io l’infermiera», disse quella ragazza, «ma c’era troppo da studiare, e io, se devo studiare, mi viene subito il mal di testa...» Ricordò le due prime e uniche lezioni, quando si era iscritta al corso, il caldo che faceva, la voce noiosa dell’insegnante, e appesa al muro la carta a colori di un corpo umano, si vedevano le ossa, i muscoli, il cuore, gli intestini, a lei faceva un po’ ribrezzo; erano così belli, invece, al mare, i giovanotti in costume da bagno. Eppure le venne nostalgia, di un’epoca, di una vita, ormai così lontane, e s’informò: «Potrei ricominciare il corso, adesso? Ho ventiquattro anni...». Erano arrivati e la motorizzata fermò la macchina e scosse il capo: «Ma tanto non ce la farò mai a cambiare vita». E ripartì subito, svanita in un attimo, l’attimo della nostalgia, senza salutare perché aveva visto all’angolo un cliente che le faceva segno. 43 · Sulla riva del fiume Si era seduto sulla riva del fiume ad aspettare che passasse il cadavere del suo nemico, come diceva il famoso proverbio, da più di sette anni, da quel pomeriggio in cui il padre di lei gli aveva detto, molto gentilmente, di lasciare in pace la figlia, e lei, la figlia, era lì e non aveva detto una parola, e la vera ragione era che lui non aveva istruzione, non aveva studiato, la famiglia di lei era tutta di sgobboni da scrivania, non accettavano uno zotico come lui, anche se non glielo dissero, e tutto l’impeto del suo amore per lei, da quel pomeriggio, si trasformò più che in odio, in gelido furore. Si era seduto sulla riva del fiume e aveva aspettato anno dopo anno, godendo delle disgrazie che accadevano a lei: la morte del padre, la vendita del podere e poi perfino della casa, finché lei non era andata via dal paese impoverita. Ogni tanto lui andava a Milano, prima di sposarsi, per qualche svago, con gli amici; e, dopo sposato, con la moglie per comprare qualche cosa che si trovava solo in città, e ora, arricchito, aveva soldi per comprare molte cose, ma stava sempre sulla riva del fiume, seduto, marchiato a fuoco, dal ricordo del rifiuto di lei. E anche quel sabato, dopo sette anni, era venuto a Milano, in uno dei migliori alberghi, e aveva lasciato la moglie, che aveva bisogno del pedicure, dal parrucchiere. Quando tornò a prenderla, sua moglie era ancora in poltrona, il grosso, gnoccoso piede nudo, e una donna, lei che quel giorno lo aveva rifiutato, glielo lavorava umilmente. «Ciao, Clelia», le disse, seduto sulla riva del fiume, vedendo galleggiare sull’acqua la spoglia, in vestaglietta azzurra, della sua nemica. 44 · Quando si ha un cane Dalla porta del bar lo videro passare, con quel grosso cane, quasi rognoso, se poi era un cane, così senza peli, con macchie rosee sulla pelle nuda, e strisciava, più che camminare, la bestia, e Walter lo indicò con gli occhi a Rugantino: «Potrebbe andare bene lui». E Rugantino disse: «È un’idea». Mandarono Mister a prenderlo, Mister attraversò la strada e gli andò incontro: «Figlio di una brava donna», quasi lo abbracciò, «quanto tempo che non ti fai vivo, vieni che ci sono gli amici che ti vogliono rivedere». Lo riportò nel bar, lo spinsero nella saletta del biliardo, lui e la sua bestia. «Champagne e bionde», disse Walter, bisognava festeggiare l’incontro con l’amico, arrivò il barista coi bicchieri pieni di anice, e perfino la bionda, tutta curve, come quelle dei film di gangster. No, non era stato in galera tutto quel tempo, rispondeva lui alle tante domande che gli facevano, prima era stato a Pesaro da una zia, poi il marito della zia l’aveva buttato fuori quando aveva saputo che lui era un ladro, allora era tornato a Roma e aveva trovato lavoro come guardiano in uno stabilimento, il direttore lo sapeva che era stato molte volte in galera, ma lo teneva lo stesso. Intanto beveva l’anice e guardava la bionda, era tanto tempo che ne sognava una così. «Mi pare che te la passi maluccio», gli disse Walter. E gli disse che aveva un progetto di primissimo ordine, una sciccheria, occorreva soltanto il solito palo, gli avrebbero allungato diversi bigliettoni, ma lui scosse il capo. «Sei gentile», gli disse, comprendendo che l’offerta era anche d’amicizia, glielo spiegò mitemente, non poteva fare il palo, «vedi, io adesso non posso rischiare. Non è mica per il posto, del posto me ne frego, ma è per questa povera bestia qui, se mi beccano e mi portano dentro, così malata com’è non la vuole nessuno e me la fanno ammazzare, invece con me chi sa quanti anni ancora vive. Ci sono affezionato, ecco. Non posso rischiare...» insisté, mite, ma inflessibile. 45 · Il bambino che non dormiva «Non capisco», disse il dottore, «non capisco perché non dorma.» Il bambino era sano, normale, molto intelligente. «La sera mangia abbastanza o poco?» chiese alla madre. Il bambino uscì e andò in cucina, la giovane madre stava diritta, impassibile, un poco pietrosa. «Mangia molto, la sera», disse. «Non capisco», disse il dottore, «non capisco.» La madre si scosse un poco. Ascoltò dalla cucina il piccolo che giocava con dei cucchiai. «Io lo so, perché non dorme», disse. «Ma allora doveva dirmelo», disse il dottore, «è un mese che andiamo avanti a curare a tastoni. Doveva dirmelo», ripeté. «Perché non dorme?...» «Perché qui non passano camion», disse la giovane madre. Non l’aveva detto prima perché era spiacevole dirlo. «Nella casa dove eravamo fino a un mese fa, per la strada, la sera cominciavano a passare i camion, ne passavano tanti, tutta la notte. Lui la sera, non si addormentava finché non ne passava qualcuno. Quando sentiva il rumore di un camion che passava, gli veniva sonno, e durante la notte, finché anche nel sonno udiva i camion che passavano, dormiva tranquillo, se invece per qualche ora non ne passava nessuno, allora finiva per svegliarsi.» «Strano», disse il dottore, «è un poco strano. Perché non dorme senza camion?» «Perché suo padre è un camionista. Lui lo aspetta sempre, gli ho detto che sta facendo un lungo viaggio. Se sente i camion sta tranquillo, può essere suo padre che torna.» «E quando torna il padre?» domandò il medico. «Non torna. Ne ha sposata un’altra», disse la giovane madre. 46 · Quasi due metri Era alto quasi due metri, aveva mani larghe e rosse di sangue come grosse costate alla fiorentina. La pelle del viso sembrava di cuoio, aveva le. stesse pieghe profonde del cuoio. Veniva dal Friuli, veniva per vedere la 12ª Mostra di Tecnica agraria. Non era mai stato a Torino. Girò quasi un’ora alla ricerca di un piccolo albergo; da buon friulano non domandava mai niente a nessuno, neppure la più semplice informazione. Ma tutti gli alberghi erano troppo di lusso per lui. Non era una questione di denaro, aveva molto denaro con sé, ma era un contadino, ed era orgoglioso di esserlo, e non voleva andare in posti con gente schizzinosa e camerieri che ghignano al cliente disceso dalla montagna. Finalmente fermò la Cinquecento davanti a un albergo che gli parve adatto a lui: Atlantic Hôtel. Entrò aprendo una porta a vetri opaca e fu in un’anticamerina puzzolente di cicche da morire. Non c’era nessuno, attese davanti a un piccolo banco e infine comparve una donna sui quarant’anni, dipinta da far ridere. «Ha una camera per tre notti?» disse il friulano. Si chiamava Lucio Zanettin. La donna guardò il gigante, le sue mani. Dovevano piacerle gli uomini di quella stazza. Di solito non affittava mai camere per tre notti di seguito, al massimo per tre ore. Comunque le venne da ridere al pensiero che l’ingenuo Golia fosse capitato proprio nel suo albergo e disse divertita: «Sì, certo. L’accompagno io». Lucio Zanettin seguì con la sua valigetta la donna per delle ripide scalette, molto strette. Così strette che quando discese una ragazza, giovanissima, dall’aria provocante, seguita da un maturo signore rossiccio e stralunato in viso, dovettero farsi da parte per lasciarli passare. Anche la stanza sapeva di cicche. «Il bagno e il resto è fuori, nel corridoio, qui c’è solo il lavabo.» C’era anche un altro aggeggio, coperto da due asciugamani, uno rosa e uno azzurro. «Acqua fredda, soltanto.» Lucio Zanettin non si era mai lavato nell’acqua calda, neppure in pieno inverno, e la notizia non lo interessò. Rimasto solo si lavò accuratamente, si fece la barba col rasoio a lametta e come al solito dovette cambiare due lame per sentirsi, se non liscio, almeno meno rasposo. Si cambiò d’abito, e uscì. Da basso non c’era nessuno e lasciò la chiave sul banco. Ma appena fuori, sulla strada, c’era anche troppa gente. Sapientemente disseminate lungo il marciapiede dell’albergo, c’erano una mezza dozzina di ragazze che non lasciavano alcun dubbio sulla loro attività. Diritto come un fuso, benché un paio cercassero di abbordarlo, Lucio Zanettin attraversò la strada, andò dall’altro lato dove era parcheggiata la Cinquecento e si curvò per aprire la portiera. «Ehi, Mister Universo, non hai bisogno di un po’ di compagnia?» Lucio finì, curvo, di aprire la portiera. Conosceva quella voce, la conosceva benissimo. Alzò il capo e guardò la ragazza che gli si era avvicinata. «Giovanna», disse semplicemente. Lei emise un gemito, riconoscendolo. «Vai via, vai via, non dirgli che mi hai vista», lei quasi piangeva. Istintivamente gli parlava in stretto friulano. E lui le rispose in stretto friulano. «Tua madre e tuo padre stanno morendo per te.» «Non dirgli niente, se no divento pazza, mi ammazzo.» «Parliamo almeno un momento, Giovanna.» «Non possiamo parlare qui, Lucio, se vuoi parlare devi prendere una camera in quell’albergo lì e allora posso venire con te un poco.» Non occorreva essere un esperto di quel lavoro per capire che lì intorno doveva esserci un giovanotto, il padrone della ragazza, che sorvegliava perché lei non perdesse tempo. «La camera ce l’ho già», disse Lucio paziente. «Andiamo.» C’era infatti, a una ventina di metri, dentro una Giulia ultimo modello, un giovanotto biondo, torvo e robusto. Seguì con lo sguardo la sua gallina – così lui si esprimeva nella sua mente – mentre entrava nell’albergo insieme con quella specie di grosso bestione sotto forma umana. Si accese una sigaretta. Intanto Lucio aveva portato Giovanna nella sua stanza. Appena soli, lei si sedette sul letto e si mise a piangere. «Come sta la mamma?» «Male. Ho visto lei e tuo padre proprio due giorni fa. Sono invecchiati di dieci anni.» Parlavano un friulano così chiuso che anche se uno fosse stato ad ascoltare, non avrebbe capito una parola. «Giovanna, di’ perché sei scappata di casa, che cosa ti è successo.» «Non lo so, sono stata una sciagurata. Volevo andare via dal paese, mi annoiavo, allora sono andata appresso a uno che veniva ogni tanto in paese a vendere la roba alla drogheria. Lui mi ha detto che mi avrebbe fatto viaggiare, che mi sarei divertita. Quando mi sono accorta di avere sbagliato, era troppo tardi, ero già finita qui. E ormai non ho più speranza.» «Giovanna, hai solo poco più di quindici anni, non devi dire che non hai più speranza. Tu devi tornare a casa e riprendere a vivere.» «No, io non posso tornare a casa, se no lui mi ammazza. Me lo dice sempre: “Tu prova a scappare, e io ti apro con questo coltello”. Guarda, mi ha dato una coltellata, due mesi fa, qui sul braccio, per farmi paura.» Il dialetto friulano è solenne, ed era ancora più solenne in quella squallida stanza a ore. «E poi non torno in paese, perché mi vergogno», lei disse solennemente. «E non ti vergogni di più a fermare gli uomini in mezzo alla strada? Tu devi tornare a casa. In paese non lo sanno quello che stai facendo, possono immaginarlo, ma non sanno niente. Poi, non sei la prima ragazza che scappa di casa, sta via due o tre mesi e dopo torna. Non puoi lasciar morire tua madre e tuo padre.» «Io non torno a casa, mi vergogno.» «Giovanna, tu sei ancora una bambina, e non capisci. Io non ti lascio qui a continuare questa vita. Sono amico di tuo padre da quando eravamo ragazzi, sono stato compare al matrimonio di tuo padre con tua madre, e padrino al battesimo quando tu sei nata. Ti ho tenuta in braccio, ti ho dato il biberon e mi hai fatto la pipì addosso diverse volte. Io non ti lascio qui, ora che ti ho incontrata. Potrei chiamare la polizia, e far arrestare quel farabutto, ma allora la polizia prenderebbe anche te e ti metterebbe in uno di quegli istituti di suore dove tu soffriresti troppo, e poi lo scandalo sarebbe grave, tutti i giornali parlerebbero di te, e allora sì che sarebbe vergogna. Invece noi adesso usciamo di qui, saliamo in macchina, e torniamo direttamente in Friuli, a casa tua. Domattina all’alba arriviamo, ti consegno a tuo padre e a tua madre, e non c’è nessuno scandalo. Al massimo i carabinieri ti interrogheranno un’oretta, ma tutto finisce lì.» Si alzò. «Vieni, Giovanna.» Lei si rimise a piangere. «Ma se scappo, ci ammazzerà tutti e due, ha anche la rivoltella.» «Può sbagliare anche mira», disse con oltracotanza friulana lui. «Asciugati le lacrime e vieni.» «È qui sotto con una Giulia, non riusciremo mai a sfuggirgli. Sta’ attento, Lucio, stai attento, non farlo, lasciami andare.» «Tu devi ubbidire a me, bambina, smettila di piangere e usciamo.» Uscirono dall’albergo, con la sinistra lui teneva la valigetta, con la destra il braccio di lei. Attraversò la strada, raggiunse la Cinquecento. La portiera era ancora aperta da prima, buttò la valigetta di dietro. Lei tremava. «Lucio, lasciami andare, è in quella Giulia sotto gli alberi. Se mi porti via ammazza anche te.» «Sali.» Dette un’occhiata e vide la Giulia. Distinse nell’interno la brace rossa di una sigaretta. Salì svelto e mise in moto rapidamente. Dallo specchietto retrovisivo vide la Giulia, era verde scura, che si muoveva anche lei. «Ho paura, ho paura, lui spara.» «Vedrai che non spara.» Prese l’autostrada. La Giulia seguiva sempre. Dopo il casello lo stradone divenne molto buio, c’era anche una leggera nebbia che tendeva a divenire sempre più fitta. «Ho paura, ho paura.» «Stai tranquilla, ci sono io.» Ma non c’era molto da star tranquilli. Avvenne quello che Lucio aveva facilmente previsto. La Giulia sorpassò con un balzo la lenta Cinquecento poi le si parò davanti e frenò di colpo, così che anche Lucio fu costretto a bloccare per non andargli addosso. E dalla Giulia schizzò fuori il giovanotto biondo, torvo e robusto che con la rivoltella in pugno si precipitò sulla Cinquecento e agitando la rivoltella fece a Lucio cenni imperiosi che aprisse la portiera. Lucio accennò di sì e aprì la portiera, mentre Giovanna raggomitolata sul sedile rabbrividiva di terrore. Aprì la portiera con una certa violenza, spalancandola tutta, in modo che colpì di striscio il braccio del giovane con la rivoltella. D’istinto quello sparò contro Lucio, ma Lucio rotolò a terra, si abbracciò alle sue gambe, lo fece cadere a terra e gli dette una ginocchiata all’inguine, quindi si alzò e lo colpì in piena faccia con un calcio perché il torvo biondo, pur rantolando di dolore per la ginocchiata, stava per sparare ancora. Non fece in tempo. Lucio gli prese la rivoltella e la buttò via, nel prato. «Vieni, Giovanna, saliamo sulla Giulia, così andiamo più in fretta.» L’aiutò a scendere di macchina. Si diresse verso la Giulia e stava per salire con Giovanna quando i fari abbaglianti di una macchina che sopraggiungeva lampeggiarono su di loro e una grossa Mercedes fermò di fianco alla Giulia. Ne scese un vecchio, asciutto signore di oltre cinquant’anni che disse: «Cosa è successo?». «Ah, non lo so», disse Lucio. «Ho visto quell’uomo lì in terra, e mi sono fermato un momento a guardare.» Il signore asciutto si curvò sul corpo del biondo. «Ma è morto», disse. «Bisogna avvertire la polizia.» «Ah, io non m’intrigo», disse Lucio. «La polizia mi fa perdere tutta la notte, e io ho fretta.» «Bel civismo!» scattò il vecchio, «se tutti facessero come lei, il mondo sarebbe una giungla... Ma che strano! La Cinquecento non ha una scalfittura, e neppure la sua Giulia, eppure quest’uomo è morto... Forse ho capito.» «Che cosa ha capito?» domandò Lucio tenendo per mano Giovanna che tremava convulsa. «Avete litigato per una questione di sorpasso. Forse questo poveretto della Cinquecento non le ha lasciato subito strada, allora lei l’ha sorpassato rabbiosamente poi si è fermato, è disceso e l’ha ammazzato di botte.» Il vecchio era pignolo e astioso. «Ecco perché non vuole avvisare la polizia, ecco perché ha tanta fretta, anche perché va in giro con le minorenni a quest’ora, quella ragazza forse non ha neppure tredici anni. Vergogna!» «Ma lei delira!» Il friulano Lucio Zanettin era colpito soprattutto dalla fantasia del vecchietto. «Le faccio vedere io se deliro», il vecchio si mise gli occhiali, levò dalla tasca una penna a sfera e una busta. «Adesso prendo il numero della sua Giulia, e poi si spiegherà con la polizia.» Era convinto che la Giulia fosse sua. «Lei non prende nessun numero.» Lucio gli prese gli occhiali, la penna e la busta e glieli buttò via. Proprio in quel momento passarono tre macchine, probabilmente, siccome andavano piano per la nebbia, videro tutto, il morto, lui che strappava gli occhiali al vecchio, ma per fortuna non si trattava di gentiluomini della strada, erano degli esseri incivili che volevano tornare presto a casa, senza essere coinvolti in grane. «Le conviene stare qui, zitto e buono.» Andò verso la Mercedes, aprì la portiera dalla parte del volante, tolse le chiavi dal cruscotto e le buttò nel prato vicino. Ci sarebbe voluto almeno un quarto d’ora perché qualche macchina di passaggio raccogliesse il vecchio stizzoso. Il quarto d’ora sufficiente per raggiungere la prima uscita dell’autostrada e buttarsi per le strade di campagna per sfuggire ai blocchi della polizia. Mentre saliva sulla Giulia fece in tempo a udire le grida isteriche del vecchio: «Finirà in galera lo stesso, farabutto, assassino, teppista!». Lucio Zanettin guidò tutta la notte per stradine di campagna, guidato, più che dalle scarse segnalazioni, dal suo senso di orientamento di montanaro. All’alba si trovò in un paese vicino a Mantova. Ancora tre o quattro ore soltanto e sarebbero stati a casa. Giovanna aveva dormito ed era più calma. Intanto, però, il vecchio asciutto signore aveva fatto alla polizia una sua fantasiosa denuncia. Un teppista a bordo di una Giulia verde aveva ucciso un povero ragazzo che guidava una Cinquecento. Poi aveva fretta di andarsene, perché aveva con sé una ragazza di dodici, tredici anni – diminuiva sempre l’età – che si vedeva aveva corrotto. Quindi la polizia si mise alla caccia di un bruto alto due metri, che aveva ammazzato un povero ragazzo, ma, per fortuna del friulano, le ricerche non vennero estese oltre il Piemonte e la Lombardia. Lucio Zanettin era già addentro nel Veneto, aveva oltrepassato Mestre, aveva percorso la striscia di Capo Sile e si stava avvicinando al Piave, quando lei che era stata calma fino ad allora si rimise a piangere. «Perché piangi, Giovanna?» «Perché non voglio tornare a casa. Mi vergogno troppo.» «La vergogna ti passerà subito, appena vedrai tua madre e tuo padre. Se tu non torni loro muoiono.» «Ma se torno muoio io di vergogna.» «Non fare i capricci come una bambina, Giovanna.» «No, io non torno a casa, Ferma la macchina e lasciami qui, se no non so che cosa faccio.» «Fa’ la brava, Giovanna, fra poco siamo arrivati, poco più di mezz’ora e sei a casa, e allora cambierai idea.» Aveva pena di lei. Comprendeva benissimo come il suo orgoglio fosse ferito all’idea di tutto quello che avrebbero detto di lei nel piccolo paese, ma lei doveva pur comprendere che questo era nulla in confronto alla gioia che il suo ritorno avrebbe dato ai genitori, e alla possibilità di rifarsi una vita. «No, io non cambio idea. Ferma la macchina e lasciami libera.» «Figurati se ti lascio scendere.» Allora lei abbassò il finestrino, sporse il capo in fuori e gridò con tutta la sua voce: «Aiuto! Aiuto! Aiuto!». Poi tentò di aprire la portiera e vi sarebbe riuscita se lui non l’avesse fermata. «Giovanna, tu sei una ragazza che capisce. Io ho ucciso un uomo per liberarti da quel mascalzone e riportarti a casa. Dovrò fare diversi anni di galera, e li faccio volentieri se so che sei con tua madre e con tuo padre e che torni a vivere una vita da brava ragazza.» Ma ormai non c’era più niente da fare: la crisi di pianto era divenuta una crisi di nervi, lei si dibatteva, continuava a urlare aiuto, aiuto dal finestrino aperto e tentava di aprire la portiera. Lucio Zanettin non ebbe scelta, la colpì abbastanza forte su una guancia, per lui fu un colpo leggero, ma lei svenne all’istante e un poco di sangue uscì dal naso. Lui richiuse il finestrino, bloccò la portiera e riprese a correre al massimo di velocità. Arrivò in paese nel primo pomeriggio. Entrò con la Giulia nella corte della cascina. Il padre e la madre di Giovanna vennero fuori a vedere, e videro scendere la figlia che si teneva un fazzoletto rosso di sangue sotto il naso. Lucio Zanettin stette in disparte ad attendere che le lacrime e gli abbracci finissero, poi: «L’ho incontrata per caso a Torino e allora te l’ho portata qui», disse al suo amico, il padre di Giovanna. «Lei non voleva venire, e allora ho dovuto darle una botta per farla star calma. Le esce un poco di sangue, ma non è niente.» «Vieni dentro a bere un tajùtt, Lucio.» Il padre di Giovanna si asciugò gli occhi. «Non ho tempo, Bepi, devo andare dai carabinieri.» Aveva detto che l’avrebbe riportata a casa, e l’aveva portata. I friulani hanno la testa dura. Il maresciallo dei carabinieri quando ebbe ascoltato il racconto di Lucio Zanettin, disse: «Tu non ti fai neppure un mese di carcere. Prima di tutto perché tu hai ucciso per legittima difesa perché quello ti minacciava con la rivoltella. Poi, quello era un mascalzone che sfruttava quella povera ragazza». «Allora posso andare?» disse Lucio ingenuamente. «Eh, no, caro, dovrai stare qualche settimana qui in caserma con me intanto che il giudice istruttore prepara il processo. Ma vedrai che non ti troverai male. Qui si mangia come si deve, per esempio stasera facciamo la bruada con le salsicce...» 47 · Villa della disperazione La vecchia Alfa, attraversato il caos costruttivo di San Giovanni a Teduccio, lasciò la strada borbonica e prese quella che conduceva al Vesuvio, di cui nella chiarità del pieno mattino di giugno si vedeva l’aggraziata e pur minacciosa mole. Al volante c’era un giovane con un grosso ciuffo di capelli neri che gli ricadeva in mezzo alla fronte, e vicino a lui c’era come il suo contrario, un uomo anziano, ma grosso, tutto robusto e tutto rapato in testa. Nei sedili dietro c’era un uomo di neppure trent’anni con un maglione grigio scuro dal collo alto fino al mento perché quel giugno anche a Napoli fece freddo, era bruno, ma dai capelli tagliati cortissimi, meno di un dito, e, anche se era rasato da poche ore, aveva una maschera violacea sulle guance. Vicino a lui una donna giovanissima, bionda, boccheggiava al finestrino aperto, l’abito prémaman, per quanto largo fosse, aderiva ormai strettissimo al suo ventre enorme di gestante all’ultimo giorno. Dopo una svolta quasi a L, l’Alfa fermò di colpo davanti alla villa. La villa era tutta recintata da una staccionata, all’ingresso c’era un grande cartello: Ministero della Pubblica Istruzione. Sovrintendenza ai monumenti della Campania. Restauro e ripristino delle ville settecentesche vesuviane. L’ingresso è consentito soltanto alle autorità competenti. Non è permessa alcuna visita. L’uomo rapato lesse il cartello senza parlare e senza parlare tutti scesero. Il ragazzo col ciuffo dette un piccolo colpo di clacson, poi slegò i numerosi bagagli che erano sul tetto dell’Alfa. Non c’era nessuno sullo stradone, l’aria era polverosa di microscopiche faville che piovevano dalle falde del Vesuvio spazzato da un vento abbastanza forte e freddo. Al brevissimo, quasi inesistente colpo di clacson il portello della staccionata si aprì e vennero avanti una donna e un uomo, anziani ma dall’aspetto robusto, e una ragazza alta, dal viso pallido, dai capelli bruni, lunghi, tutti in disordine, da una gonna rossa cortissima, ma spiegazzata e stracciata. Senza parlare, la vecchia donna andò a sostenere la giovane gestante, mentre il vecchio e la ragazza presero le molte valigie che erano sul tetto della vettura, escluse due che, con un gesto imperioso, il vecchio robusto dalla testa rapata volle portare lui. «Sbrighiamoci», disse il ragazzo col ciuffo, «prima che qualcuno ci veda.» Attraversarono lo stradone in fretta e furono tutti al riparo un momento dopo dietro la staccionata che circondava la villa, senza che si fosse visto un passante o un’auto. La villa sembrava dovesse crollare da un momento all’altro, i due portali disegnati dal Sanfelice erano spariti, così le preziose ringhiere panciute e fogliute dei quattro balconi, e delle preziose persiane dell’epoca non esisteva neppure il ricordo: finestre e balconi erano tappati da assi di legno. Percorso il lungo androne arrivarono nel cortile con porticato e, a sinistra, entrarono nel vasto anticamerone di servizio, buio come una cantina, la luce filtrava soltanto da due grandi finestre tappate però dalle assi di legno e a destra di questa area di disbrigo entrarono nella cucina. Una cucina del tardo Seicento, grande come una vasta sala da ballo di oggi, con un camino alto due metri, il soffitto che recava ancora qualche traccia di affreschi di cani che inseguivano la selvaggina, fagiani, lepri, uccellini. «Di qui, signori», disse la vecchia. Aprì una porta ed entrarono in una stanza ancora più vasta della cucina. Le finestre non erano chiuse dalle assi di legno, ma da polverosi vetri e rozze imposte non verniciate. In quell’immensità, il letto matrimoniale, l’altro letto singolo, un armadione, enorme e sgangherato, un lavabo con la brocca e il catino, un tavolino e due sbrindellate poltrone, si sperdevano come pochi chicchi di riso in una grande scodella. «Signora, stendetevi qui un poco», disse la vecchia alla giovane, nel suo morbido, grasso napoletano. Aiutò la donna incinta, viola in viso, a mettersi sul letto. «È un letto molto morbido, mio marito dice che è troppo morbido, che fa fatica a dormirci.» Erano entrati anche il vecchio e la ragazza con le valigie, insieme col giovanotto dal ciuffo che aveva guidato l’Alfa. «Mandali via», disse il grosso uomo rapato al ragazzo col ciuffo. «Tu resta qui, dobbiamo parlare.» Senza parole, con un gesto e uno sguardo, il ragazzo ordinò ai tre di uscire e chiuse la porta dietro di loro. Il vecchio gli andò davanti. Con la mano gli indicò una delle poltrone. «Siediti.» Così lo dominava meglio. «Che posto è?» «È il posto più sicuro, signò, qui non vi trova nessuno», disse il ragazzo, anche lui evidentemente napoletano. «Perché?» «Perché è un monumento nazionale...» disse il ragazzo, «avete visto la staccionata e il cartello? Nessuno va a pensare che qualcuno si voglia nascondere qui, infatti nessuno ci si è mai nascosto.» «Chi ha pensato a questo nascondiglio?» disse il grosso vecchio, incombendo su di lui. «Gli amici...» disse il ragazzo, dette un’inflessione speciale alla parola amici. «Siete con una signora che aspetta un bambino, non potevamo tenervi a Napoli, troppo vistoso. Allora abbiamo pensato qui, è l’angolo più deserto della zona.» «Chi sono quei due vecchi e la ragazza?» disse il grosso. Fece segno di no all’uomo col maglione dal collo alto fino al mento, che aveva preso una bottiglia di whisky da una valigia e gliene offriva un po’ in un bicchiere di metallo, dette un’occhiata alla donna distesa sul letto che invece beveva bravamente dalla bottiglia. «Sono i custodi della villa. La ragazza è la loro figlia, ed è la mia fidanzata», disse caldamente il giovane col ciuffo. «Per questo gli amici mi hanno detto: “Tu hai la passione, lassù, in quella villa, e allora portali lassù”. Sono gente brava, dovete stare sicuro, dotto’», cominciò a chiamarlo dottore per quanto con quella faccia non desse troppo la sensazione del dottore. La grande camera era illuminata da due sole finestre e quindi, nonostante la mattinata così luminosa, era piena di ombre. L’uomo in maglione era seduto sul letto vicino alla giovane donna, fumavano tutti e due quei robusti sigaretti, e dopo tutto il whisky lei, invece di vomitare, pareva che stesse molto bene, e aveva un dolce color fragola in viso. «Come ti chiami?» disse il vecchio. «Fiorello», disse il ragazzo. «Io mi chiamo Gennaro. Se non ci credi, fai male», disse il grosso, si frugò sotto la giacca, come avesse prurito, e ne tirò fuori una grossa Browning. «Sono più napoletano di te anche se da quarant’anni vivo a New York e parlo l’italiano così male.» Alzò la voce rabbiosamente, urlò addirittura: «Alzati!». Lentamente, non per svogliatezza, ma per terrore, Fiorello si alzò, cercando di non guardare la piatta canna della rivoltella. «Ascoltami, Fiorello», disse Gennaro, «tu mi sei stato raccomandato dagli amici di laggiù. Mi hanno dato la tua fotografia a New York, e a Capodichino, quando siamo scesi dall’aereo, tu eri lì ed eri quello della fotografia. Ti ho chiesto: “Lei è dell’agenzia alberghiera?” e tu hai risposto, secondo la parola d’ordine: “Sì, dell’Hôtel Continental”. Tutto questo va bene, ma io prima di fidarmi sto attento.» Alzò la Browning, gliel’appoggiò sulla pelle, sotto il mento, costringendolo ad alzare il viso. «In questo posto ci sono molte cose che non mi piacciono. Per esempio non c’è il telefono.» «Dotto’», si lamentò Fiorello, «ma in questi scavi di Pompei cosa volete che mettano il telefono? È solo questione di pochi giorni, poi vi troviamo la casa degna di voi, dotto’.» Gennaro abbassò la rivoltella, ma la tenne sempre in mano. «Poi non mi piaci tu. Sei troppo giovane, l’ho detto anche a New York quando mi hanno dato la tua fotografia, per una cosa così grossa. Mi hanno assicurato che posso fidarmi, ma non mi piaci lo stesso.» Alzò di nuovo la rivoltella verso il suo viso, guardò un attimo l’uomo in maglione che si era disteso sul letto accanto alla donna. «Ti assicuro che, se sbagli, se servi due padroni, se prendi soldi da noi e poi vai a informare la polizia, non ti salverai più, e non solo tu, ma tua madre, tuo padre, la tua ragazza, tua sorella. Siamo venuti qui per questo, ci sono troppi figli di Giuda intorno a noi, e siamo venuti a sistemarli.» «Dottore, io non le faccio certe cose.» «Sarà», disse il grosso. «E poi non mi piace che non ci sia la luce elettrica. Qui di notte ci infilzano come tordi allo spiedo.» «Dotto’, qui non c’è mai stata la luce elettrica, sono ville di tre, quattro secoli fa. Ma ci sono i lumi a petrolio e le candele, e poi nessuno si sogna di venire qui, state sicuro, dotto’, parola.» L’altro si rimise la rivoltella dentro la camicia. «Adesso cerca di ricordarti quello che mi occorre subito, e portamelo subito.» In quel momento la donna distesa sul letto ebbe una specie di breve rantolo. Il vecchio, con voce d’improvviso tenera, raucamente dolce, le si rivolse: «Cos’hai, cara?». «I dolori, papà, diventano sempre più forti», disse lei. «Il dottore verrà subito», la rassicurò lui, poi la sua voce ritornò dura e si rivolse al ragazzo napoletano. «Te l’ho già detto prima in macchina: mi occorre subito l’ostetrico.» «Sì, dottore, lo teniamo il cavapupi, gli amici lo sapevano che arrivavate con la signora così.» «Subito vuol dire subito, ragazzo.» «Sì, dotto’, fra un’ora arrivo qui col cavapupi.» «E mi occorrono due auto.» «Due, dotto’?» «Non molto grandi, ma veloci. E subito. Quando vieni qui con l’ostetrico devi portare anche le due auto, col serbatoio pieno.» «Piccole, ma veloci», rifletté a voce alta il ragazzo. «Due Giuliette forse vanno bene.» «Non conosco le auto italiane, ma voglio che facciano almeno i centosessanta.» «Va bene, dottore.» «Sono le undici e tre quarti. All’una meno un quarto devi essere qui col dottore. Se succede qualche cosa a mia figlia perché tu ritardi, è meglio che ti tagli la gola da solo.» «No, dotto’, sono qui anche prima di un’ora.» Il ragazzo era lucido di sudore. «E porta questo messaggio agli amici, ricordati bene le parole.» «Sì, dotto’.» «Questo è il messaggio: “voglio subito casa con telefono”.» Quello voleva tutto subito, pensò il ragazzo. «E adesso voglio la cosa più importante: il numero di telefono dell’amico più grosso, e tutti e due sappiamo chi è.» «Sì, dotto’, ve lo scrivo subito.» Lo sapeva a memoria, aveva in tasca dei foglietti sparsi, consunti, sgualciti, e una matita che si passò tra le labbra per inumidirla. Era un numero facile da ricordare, 35.25.65, e scrisse il numero sul foglietto, ma arrivato alla quinta cifra sbagliò, non si accorse che invece di scrivere 6 aveva scritto 5, così consegnò al vecchio, la mano tremante per l’agitazione, il foglietto con scritto questo numero sbagliato: 35.25.55. «Adesso va’ via e fa’ presto», disse il vecchio. Solo quando fu fuori, sulla strada, il ragazzo riprese a respirare normalmente. Era la prima volta che veniva in contatto con gli americani, era stata una prova di fiducia che gli avevano dato, ma un po’ pesante. Coi suoi padroni napoletani si sentiva molto più sicuro, ma di questi stranieri e delle loro rivoltelle aveva paura. E bisognava far subito subito. Si mise al volante dell’Alfa, girò la macchina e discese verso Napoli, continuava a pensare che doveva trovare il cavapupi, subito subito, e poi le due Giuliette, subito subito, che strano che a mezzogiorno, a Napoli, e in giugno, dovesse fare freddo, tirò su il finestrino dalla sua parte e senza accorgersene continuava a premere l’acceleratore, finché, come era prevedibile, appena arrivò sulla via borbonica, due militi della strada alzarono il loro palettino irritante e gli fecero segno di fermarsi, coi loro irritanti caschi, le loro irritanti moto appoggiate al muro, e le loro irritanti facce. Il ragazzo col ciuffo, Fiorello, era un napoletano verace, e un napoletano verace se nell’orecchio ha il rombo di cento «subito, subito, subito», non resiste a tante cose irritanti insieme. E infatti non resisté. Invece di fermarsi all’intimazione, accelerò, schizzò via nel traffico convulso di San Giovanni a Teduccio in quell’ora convulsa vicino all’ora di colazione. Era impossibile che ce la facesse, e infatti non ce la fece. Un bambino che era caduto di bicicletta rompendo il fiasco di vino che teneva in mano e che piangeva, lì, in mezzo alla strada, lo bloccò, e dallo specchietto lui vide arrivare come un proiettile uno dei motociclisti. «Vieni fuori.» Il ragazzo guardò il bambino che si rialzava, fradicio di vino rosso e di lacrime, e scese. Dette al milite la patente e il libretto. Arrivò anche l’altro milite. «Perché sei scappato?» «Avevo fretta.» Il milite si trattenne i documenti. «Sali, e seguici», disse. «E sta’ tranquillo.» «Tranquillissimo», disse lui colando sudore dalla fronte al rimbombo di quella voce nelle orecchie: «Subito, subito, subito». La prima mezz’ora l’italo-americano Gennaro la passò a ispezionare la villa. Il vecchio custode, con un lume a petrolio in mano, lo condusse al piano superiore e alle soffitte, o stanze, a quei tempi, per la servitù. Il lume a petrolio era necessario perché di sopra tutte le finestre erano sbarrate da assi di legno. La larga scala era senza l’arabescata ed elaborata balaustra di bronzo, bisognava stare attenti perché non sempre i gradini si mostravano sicuri, sul primo e sul secondo pianerottolo si erano aperte due falle, due grossi buchi dai quali s’intravedeva il vago chiarore dell’anticamera sottostante. «Dotto’, attento a dove mettete i piedi», diceva il custode. Al piano superiore vi erano due grandi saloni e quattro stanze. Anche qui vi erano dei buchi nel pavimento, e anche nel soffitto. Pezzi di muro cadevano un po’ da per tutto, sempre semplici scaglie, ma era una pioggia continua. In uno dei saloni vi era ancora un massiccio, lungo tavolo dell’epoca, evidentemente non era stato rubato soltanto per la sua mole e la sua pesantezza. E a tutte le pareti si vedevano ancora, in ogni stanza o salone, le larghe chiazze di affreschi del Fischetti, gentili vergini nude nelle volute ariose e geometriche delle decorazioni, con fantastici paesaggi sullo sfondo, monti sui quali si ergevano leggiadre rocche, e cani da caccia che inseguivano la selvaggina in irreali foreste. Gennaro guardò tutto senza capire, guardò il grande lampadario penzolante pericolosamente dal soffitto. «Una volta c’era la luce elettrica», disse indicandolo con la Browning che teneva in mano. «No, signore, quello è un lampadario a candele.» «Di sopra cosa c’è?» «Le soffitte. Il tetto è molto rotto, si sta sfasciando tutto, sono due anni che hanno messo quel recinto col cartello intorno alla villa, ma non hanno ancora fatto nulla. Sono venuti un paio di volte, forse a controllare che la villa sia ancora in piedi, ma io ho paura a starci, qualche notte magari ci casca tutto addosso.» Gennaro ispezionò anche le soffitte, e solo quando fu sicuro che nella villa non c’era nessuno tornò da basso nella stanza dove erano sua figlia e il genero. Tina dormiva. «È ubriaca fradicia», disse l’uomo in maglione. «Non resiste alle doglie, adesso le ha ogni quarto d’ora, ma non si sveglia neppure, si lamenta un po’. Il bambino nascerà sbronzo.» «Non c’è nessuno nella villa, Charlie», disse Gennaro. Charlie aveva un viso da duro, ma non da bruto, i suoi occhi, anzi, esprimevano intelligenza, acume, se avesse portato gli occhiali sarebbe sembrato un giovane e aitante professore. «Figurati che consolazione», disse acre. «Avrai tempo di incontrare tanti poliziotti da non poterli contare. Non si va in giro a fare i gangster con una donna gravida appresso.» «Io non lascio mia figlia sola in un momento come questo. E tu che sei suo marito dovresti pensare come me.» «No, non posso pensare che Tina abbia il bambino qui, in questa catapecchia, in questo letto», Charlie alzò la voce, guardò il suocero con odio, «non ci farei dormire il gatto, su queste lenzuola, su questo cuscino...» «Forse non nasce subito, domani o dopo ci sistemeranno in una casa migliore.» «No, nasce qui, fra poche ore, le doglie sono sempre più fitte. Senti», disse Charlie. Pur nel sonno dell’ubriachezza Tina si mosse convulsamente e lanciò una specie di ululato, poi respirò profondamente e ricadde in quella specie di coma. «Adesso guarda l’orologio, fra dieci minuti gliene verrà un’altra, poi gliene verranno ogni cinque minuti e allora ci vuole subito il medico.» «Sta arrivando», disse Gennaro. All’una e mezzo non era arrivato nessuno. Alle due neppure, alle due e mezzo Tina si svegliò urlando e Charlie dovette metterle una mano sulla bocca. Le dettero ancora tanto whisky da narcotizzarla, e lei si riaddormentò. Gennaro guardò l’orologio. «Vado a telefonare.» Charlie si accese uno dei sigaretti che gli erano rimasti. «E a chi telefoni? Non hai ancora capito che ti hanno tradito? Siamo venuti qui per vedere se tradivano, e adesso lo sappiamo.» «Vado a telefonare lo stesso.» Aprì una delle due valigie che aveva voluto portare personalmente lui: c’era parecchia roba, quattro cinture caricatori per la Browning, due pistole mitragliatrici e due mitra smontati in due. Sul fondo c’erano le scatole, tre, coi candelotti di nitroglicerina, ne aprì una e si mise due candelotti in tasca, prese una cintura caricatore e se l’allacciò alla vita. Sembrava un po’ più grosso, ma era già abbastanza grosso per non destare sospetti. Un uomo così equipaggiato, e deciso a usare il suo equipaggiamento, è un po’ difficile da prendere. Charlie non disse nulla e non lo guardò neppure molto: il vecchio gli faceva pena, gli faceva pena sua moglie schiacciata da un tiranno così spietato e aveva anche pena di sé stesso. Ma era nato in quell’ambiente, e doveva viverci. Gennaro risolveva tutto sparando. Anche quando parlava senza puntare la rivoltella era implicito che se qualcuno non fosse stato del suo parere, avrebbe sparato. Facesse pure. Il vecchio si tolse la rivoltella da sotto la camicia ed entrò di colpo nella stanza accanto, la grande cucina: c’era la ragazza che sembrava una zingara che stava ascoltando una radio a transistor, e al tavolo c’erano sua madre e suo padre che discutevano, con un fiasco di vino in mezzo a loro. Puntò la rivoltella contro di loro. «Devo telefonare. Quanto è lontano il telefono più vicino?» Il custode si alzò. «Signo’, non sparate, noi non vi abbiamo fatto niente.» «Dov’è il telefono più vicino!» urlò selvaggiamente Gennaro. «Se no, sparo davvero.» «È più su, verso il Vesuvio», disse il custode, frustato da quell’urlo, «c’è un ristorante per i turisti che vanno fino in cima, lì c’è il telefono.» «Allora mi ci accompagni, e subito. Voi due starete qui in camera con mio genero», le sospinse malamente nella stanza. «Vado a telefonare. Sta’ sicuro che torno. Se non torno, sai cosa devi fare», disse a Charlie. Oh, sì, lo sapeva, doveva uccidere le due donne. I traditori devono morire, sì, verissimo, ma a che serviva? «Sì, lo so», disse Charlie. Guardò Gennaro che usciva col custode, richiuse la porta e, con lo stile desiderato da suo suocero, levò dalla cintura la rivoltella e la tenne puntata contro le due donne. «Sedete nelle poltrone e non seccate.» Carezzò con la sinistra il viso umidiccio di Tina. Dormiva tranquilla. Guardò l’orologio: erano più di venti minuti che non aveva la doglia. Forse aveva ragione il suocero, poteva essere un falso allarme. Dopo un’ora e mezzo, Gennaro non era ancora tornato. Tina non sudava più, continuava a dormire e ogni tanto rabbrividiva, e non aveva più avuto nessuna doglia. Chiese delle altre coperte alle due donne, ma Tina continuò lo stesso a tremare. Dopo un’ora e tre quarti, Gennaro tornò, rientrò nella stanza spingendo avanti il custode. «Mi hanno dato un numero di telefono falso», disse con una voce senza rabbia ma cattiva, spietata. «Ho chiamato venti o trenta volte, risponde uno che non ha niente a che fare col nostro amico. Siamo dentro la trappola. Bisogna uscirne subito perché fra poco arriverà la polizia.» Era logico, pensò anche Charlie, avevano tradito, avevano voluto liberarsi dagli ispettori che venivano da New York. «Mamma santissima, guardate sotto il letto, signò, quello è sangue, si sente anche l’odore», disse la moglie del custode. Charlie guardò subito: da sotto il letto usciva e si allargava una spessa macchia di liquido scuro lucido che subito diveniva opaco. Si curvò a guardare. Il sangue gocciava dal sotto del materasso, allora Charlie sollevò un attimo le coperte e il lenzuolo che coprivano Tina, e la ricoprì subito stringendo i denti dalla nausea. «Tina, Tina», carezzandola sul viso e sentì il viso non ancora freddo ma che stava divenendo rapidamente freddo, la scosse, le mise l’orecchio sulla bocca, e così capì che era morta, sotto i suoi occhi, dissanguata. «È morta», disse. Gennaro si avvicinò, cauto, a Tina, le mise una mano dietro il collo, alla nuca, le sollevò il capo e non ebbe bisogno di altro che di questo, di sentire l’innaturale peso della testa di lei e l’innaturale rigidità del collo. La ridepose, cauto, sul cuscino e la coprì tutta col lenzuolo. Sedette sull’altro lettino, accanto a Charlie, e stettero tutti e due lì in fondo al loro abisso di disperazione, per lunghi e lunghi e lunghi minuti. Poi Gennaro si alzò. «Dobbiamo andare», disse, «fra poco qui arriva la polizia.» Era logico. Erano stati traditi e adesso li davano in pasto alla polizia. «Ma dove andiamo?» disse Charlie. «Non conosciamo nessuno, neppure i posti...» «Io so dove andare», disse Gennaro. «A Napoli, ai telefoni. Voglio telefonare a New York perché siano informati di quello che succede qui, e di che genere di amici sono. E perché vengano a prenderci.» Forse era l’unica cosa che potessero tentare, pensò Charlie. «Tu porta la valigia coi soldi», disse Gennaro, «io prendo quella con le armi.» Le mani gli tremavano. Si rivolse ai tre napoletani che stavano in piedi, ammucchiati vicino al muro. «Mia figlia è morta per colpa vostra. Se voi non foste delle sporche carogne di traditori, il medico sarebbe arrivato qui in tempo e mia figlia sarebbe viva, e anche il bambino. Siete degli assassini.» «No, signo’, no, signo’, Fiorello è acqua chiara, non ha tradito mai nessuno, gli deve essere successo qualche cosa», disse la vecchia custode. «Ah, sì? E che cosa? E perché mi ha dato un numero di telefono falso? Stai zitta.» Si avvicinò alla ragazza, le prese un braccio. «Tu adesso vieni con noi e ci insegni la strada.» Si rivolse ai genitori della ragazza. «Se la volete rivedere viva state qui buoni. Se noi ci salviamo, si salva anche lei.» Guardò Charlie che si stava asciugando con le dita gli occhi umidi. «Andiamo, Charlie.» Charlie bevette, vuotò la bottiglia di whisky, e prese la sua valigia piena di valuta italiana avvolta nei pigiama, negli slip, nei maglioni e nelle camicie. «Io non vengo con voi, io ho paura, lasciatemi stare.» La ragazza si divincolò dalla presa di Gennaro che le teneva un braccio e frullò via verso i suoi genitori che le si strinsero addosso, in una posa di protezione che era quasi un affresco, come quelli dipinti sui muri della villa. Il viso di Gennaro si scompose tutto nel furore, la morte della figlia gli ribollì nel sangue come veleno. Era vecchio, ma nessuno ebbe il tempo di accorgersi di ciò che succedeva. Anche Charlie, solo quando udì la sequenza di spari, capì che cosa aveva fatto Gennaro, mentre i tre, i custodi e la loro figlia, non capirono neppure di morire, morirono semplicemente, senza saperlo. «Sporche carogne, assassini.» «Sei tu un assassino», disse Charlie, la voce ingoiata di pianto rabbioso. «Muoviti!» Gennaro gli agitò la rivoltella davanti. «O vuoi star qui ad aspettare la polizia?» Charlie resisté alla voglia di sparare lui al vecchio pazzo e uscì per primo dalla stanza. Uscirono insieme dalla villa, sullo stradone, sotto il sole non caldo del tardo pomeriggio, ciascuno con la sua valigetta blu scurissimo, in una specie di foschia data dal polverume pietroso delle falde del Vesuvio, che il vento quasi freddo diffondeva nell’aria. S’incamminarono, verso Napoli. Nel buio totale dello stradone, le due Giuliette, con le mezze luci, fermarono davanti alla villa. Al volante della prima era Fiorello, che dette il solito, piccolo colpettino di clacson e scese, quasi rotolò fuori dall’auto. Subito, subito, subito, risentiva sempre la voce. Era riuscito a farsi rilasciare dalla polizia stradale solo un’ora prima, ma in un’ora, grazie ai suoi padroni, aveva trovato le Giuliette e il cavapupi. Chi sa come era arrabbiato l’americano, doveva ritornare dopo un’ora e arrivava invece con nove ore di ritardo. L’altra Giulietta era guidata da quello che Fiorello chiamava il cavapupi, che scese dall’auto a fatica, data la corpulenza, con una grossa valigia, in cui vi era tutto quello che poteva occorrere per un parto, fino ai flaconi di plasma e al forcipe. Era il solito medico quarantenne che ha passato tre o quattro anni in galera per procurato aborto, se non per omicidio colposo in seguito alla morte della ragazza che non voleva essere madre. Corsero tutti e due verso la staccionata, il portello era aperto, il ragazzo col ciuffo in fondo era contento, aveva fatto quello che doveva fare, anche se in ritardo, l’americano doveva riconoscerlo. Soltanto, non gli piacque il buio assoluto della villa, e il silenzio assoluto. Perché stavano così al buio? La luce dei lumi a petrolio avrebbe dovuto trapelare dalle finestre, così invece sembrava che non ci fosse nessuno. Entrarono a tentoni, poi il dottore fece scattare l’accendino: erano in cucina. «Silvana, Silvana», disse Fiorello. Nessuno rispose. Chiamava la sua ragazza. Sul tavolo c’era una candela, il dottore l’accese. «Silvana, Silvana...» Continuò a chiamarla, non comprendendo come mai nella villa non ci fosse più nessuno, finché, entrando nella camera vicina, non la vide ammucchiata a terra insieme con la madre e il padre, in un ricamo di macchie di sangue che decorava il volto e gli abiti di tutti e tre, alla viva, lunga, fumosa fiamma della candela che il dottore teneva alta. «Dottore, che cosa è?» il ciuffo gli ondeggiò sulla fronte, vedeva che cosa era ma non riusciva ancora a capire, a crederlo. «Li hanno sparati», disse il dottore, in grasso napoletano. Fissò la candela al tavolo e andò vicino al letto, sollevò il lenzuolo che copriva il viso di Tina, posò una mano sulla fronte di lei, sollevò tutta la coperta e vide la pozza di sangue. Non avrebbe avuto più da cavare nessun pupo. Poi si volse subito a quei sordi tonfi e vide Fiorello che stava sbattendo la testa contro il muro con tutta la sua forza. Gli saltò addosso e lo trattenne. «Lasciatemi fare, dotto’, che volete che faccia d’altro, adesso? Lasciatemi fare.» L’indomani, nel tardo pomeriggio, un quotidiano riportò per primo la notizia: Ieri sera, negli uffici delle comunicazioni intercontinentali della SET, sono stati arrestati due pericolosi banditi italo-americani che avevano chiesto una comunicazione con New York. Il loro atteggiamento aveva messo in sospetto l’agente di P.S. Andrea Salapanti che aveva chiesto loro i documenti. Uno dei due banditi, allora, il più anziano, ha subito sparato, ma l’agente Salapanti è riuscito a evitare il colpo e a sparare a sua volta ferendolo lievemente, riducendolo all’impotenza. L’altro, il più giovane, non ha opposto alcuna resistenza. In seconda pagina i particolari... 48 · Come in un balletto Il treno proveniente da Francoforte arrivò quella mattina alla stazione di Porta Nuova con solo ventinove minuti di ritardo. C’era un po’ di nebbia febbrarina, degli ultimi di febbraio, erano le primissime luci dell’alba ma la stazione era affollata come un veglione di carnevale, solo che non c’era musica, né danze, né stelle filanti. C’era solo un fruscio di centinaia di persone immusonite dal sonno che scendevano in silenzio da un treno o salivano tossendo in un altro. Davanti al binario numero 3 dove fermò dolcemente, quasi sospirando, il treno proveniente da Francoforte, c’erano due uomini che non partecipavano a quel movimento di scendi e sali. Stavano fermi in mezzo alla folla che sciamava sonnolenta fra un treno e l’altro e guardavano attenti il treno proveniente da Francoforte che rallentava con dolcezza femminile davanti ai respingenti in fondo al binario numero 3. No, proprio no, non avevano l’aria di torinesi, di piemontesi. I loro nerissimi occhi e i loro capelli rammentavano un caldo sud, e molte, molte arance, e molte zàgare. Uno dei due giovani, però, stranamente, aveva in mano, tenuto quasi con insolente evidenza, sul petto, un giornale tedesco, esattamente la «Frankfurter Zeitung». Se qualcuno avesse potuto leggere la data si sarebbe accorto che il quotidiano era della settimana prima ma evidentemente questo particolare non impensieriva il proprietario del giornale che lo ostentava, quasi uno scudo, davanti al suo petto. I due guardavano acutamente, attraverso la folla, il treno proveniente da Francoforte, fermo, coi loro nerissimi occhi. Gli sportelli cominciarono ad aprirsi. «Guarda bene», disse uno dei due giovani, quello senza giornale, «sono tutte e quattro bionde, sono nel vagone vicino alla locomotiva. Fa’ vedere bene il giornale, non capiscono un tubo d’italiano, parlano solo tedesco.» Eccole. Come in un balletto, d’improvviso scesero dal treno quattro ragazze bionde in vistose pellicce, non di plastica, dall’arancio al marrone rossiccio. Avevano in mano ciascuna una ridicola valigetta. Erano così vistose, per le pellicce, per la biondezza, per l’aria prostituiva che avevano che, nonostante la sonnolenza dell’alba, i viaggiatori immusoniti dal sonno, i pendolari, i facchini col carrello, si risvegliarono alla vista delle quattro ragazze, e fu giorno per loro. I due giovani dagli occhi nerissimi calarono sulle quattro ragazze velocemente. Quello col giornale agitò la sua vetusta «Frankfurter Zeitung» con un sorriso pieno di fascino latino, e gli rispose forte la risata teutonica di una delle quattro tedesche, perché non poteva esservi dubbio, erano quattro morbide, bionde, eppure esplosive tedesche, esplosive soprattutto per l’età, la più anziana non doveva avere più di diciotto anni. La risata della tedesca fece voltare, ancora di più, i bravi pendolari piemontesi che andavano al lavoro in quell’alba sconsolante di febbraio. Uno dei due giovani dagli occhi nerissimi, quello che non aveva il giornale e che era evidentemente il capo, in un tedesco che sapeva molto di sole mediterraneo, dopo aver preso per il braccio la tedeschina che aveva riso forte, disse: «Non fate troppe scene, se no arriva la polizia». I due baldi giovani tenendo in mezzo a loro le quattro ragazze con le loro piccolissime valigette, uscirono dalla stazione. Quello col giornale, che però aveva buttato via in un cestino, corse nella via di fianco davanti a una monumentale ma sgangherata Impala. L’altro dagli occhi nerissimi arrivò un momento dopo con le quattro tedesche, le stivò nell’Impala, sedette davanti vicino all’amico che era al volante. «Forza», disse all’amico, e quello avviò. «Non capisco perché con tutte le sporcaccine che abbiamo a casa nostra, le andiamo a prendere in Germania.» «Import-Export», disse concisamente il giovane dagli occhi nerissimi che era al volante. L’Impala girellò per le vie del centro, come oziosamente, mentre un sole vestito di grigio e di nebbia sorgeva stancamente, nel sedile di dietro le quattro ragazze chiacchieravano ad alto volume in un tedesco gutturale da morire. Il giovane vicino a quello che guidava si volse d’improvviso nervoso. «Ruhe!» urlò con violenza. Silenzio. Le ragazze si zittirono di colpo, ubbidienti, alla tedesca. Dopo qualche giretto l’Impala attraversò il Po, le verdi colline del Valentino, vestite di rosa per il sole nebbioso che traspariva dalla nebbia, incombettero dolcemente. L’auto arrivò in alto, fino a una villa. I due scesero di colpo, si guardarono intorno, non c’era nessuno a quell’ora sotto si vedeva il nastro fumiginoso eppure lucido del Po e la Torino dipinta di rosa di quella mattina di febbraio. «Fuori, vacche», disse in italiano uno dei due aprendo la portiera. Intanto l’altro aveva suonato in modo convenzionale alla porta della villetta e le quattro tedesche discesero pimpanti dall’Impala, non che sembrassero gemelle, ma avevano l’aria, peggio, di essere state stampate in serie, made in Germany. Il portoncino della villetta si aprì. Apparve una donna più vicina ai quaranta che ai trenta, ma dal viso devastato. «Perché un’ora di ritardo? Fra poco passa la pattuglia dei carabinieri, se ci trova qui con queste quattro sporche, andiamo tutti in vacanza. Entrate, presto, sceme.» Le quattro tedesche sorridevano beote. «Guarda che non capiscono un rospo d’italiano», disse uno dei due dagli occhi nerissimi. «Tanto, per il lavoro che devono fare potrebbero essere anche mute», disse l’altro con un ghigno. Il portone si richiuse sul gruppetto. Ma il portone della villetta si riaprì d’improvviso, la mattina di qualche giorno dopo, ancora all’alba, una delle tedesche, sotto la pioggia, ne uscì, completamente nuda, sanguinava dalla bocca, correva per il viale che conduceva al fiume, gridando disperatamente: «Hilfe! Hilfe!». Per puro caso, a quell’ora così mattiniera, l’ingegner Valarega che aveva fatto la notte brava in un cantiere a Stupinigi per un operaio rimasto morto sotto l’assale grande di una gru, tornava a casa, da sua moglie che invece sospettava che fosse stato a donne, e, vedendo quella ragazza nuda coi capelli incollati dalla pioggia dirompente che correva incontro alla sua auto, credette di avere un’allucinazione. Poi comprese che non era un’allucinazione. La ragazza correva urlante e sanguinante contro la sua auto. Dovette bloccare l’auto per non investirla. Scese di scatto di macchina, nonostante la mortale stanchezza, e udì l’urlo frenetico della ragazza che si aggrappò a lui macchiandogli tutto il giaccone da auto del sangue che le fluiva dalla bocca e gridava sconnesse frasi in tedesco, sotto la pioggia a diluvio che inzuppava tutt’e due. L’ingegner Valarega aveva studiato il tedesco, ogni tanto andava anche in Germania, ma con la segretaria che faceva tutto per lui. Inoltre quel convulso gridare della ragazza nuda e sanguinante sotto la pioggia, in qualunque lingua fosse il gridare, sarebbe stato incomprensibile. L’ingegner Valarega comprese soltanto che era tedesco. E comprese che non c’era molto da parlare e da capire. Fece salire la ragazza sull’auto, vicino al volante, grondava acqua e sangue, aveva un brutto taglio alle labbra che le deformava tutto il viso. Continuava a piangere e a parlare sulla sua spalla, e lui non riusciva a capire che cosa dicesse, il terribile pugno che le avevano vibrato doveva averle rotto diversi denti, così già tanto gutturali le parole risultavano distorte ancor di più, ma alla fine, guidando in una Torino allagata dalla pioggia, l’ingegner Valarega riuscì a distinguere nitidamente la frase che la giovane tedesca continuava a rantolare: «Hanno ucciso mia sorella e volevano uccidere me». Vide un vigile mattiniero, appena oltrepassato il Po, che si riparava sotto un terrazzo e quasi lo investì. «Guardi qui, per favore», disse al vigile. «Mi aiuti lei.» Il vigile guardò nell’auto e sussultò. Il telefono suonò. Lei sollevò il ricevitore ancora istupidita dal sonno. Aveva lavorato in questura fino alle cinque e adesso non erano ancora le otto. «Pronto.» «Loredana, scusa.» Era la voce del vicecapo della Buon Costume, lei la riconobbe subito. «Non è niente, dottore.» «Invece sì, povera disgraziata», disse il vicecapo, «sei stata qui fino a questa notte e adesso devi venire qui ancora.» «Vengo subito, dottore.» «Grazie, Loredana, tu conosci il tedesco, vero?» «Sì, dottore.» «Ti ho svegliata proprio per questo. Abbiamo preso una tedesca, c’è un delitto, una faccenda di prostituzione, ma non riusciamo a capire un tubo, vieni subito, dobbiamo sapere tutto dalla ragazza prima che gli assassini e i pappa prendano il volo.» «Vengo subito, dottore.» «Ti mando a prendere con l’auto, intanto che ti vesti.» «Grazie, dottore.» Depose il ricevitore. Schizzò fuori dal letto. Due minuti in bagno sotto il getto gelido dell’acqua. Cinque minuti per indossare la divisa di ausiliaria della polizia e per pettinarsi. L’auto della questura col lampeggiante azzurro era già lì. L’autista le sorrise aprendole la portiera per farla salire vicino a sé. «Chi è che ti fa fare questo mestiere?» le disse avviando. «La mamma. Voleva un maschio che facesse il poliziotto. Sono nata io e mi ha fatto fare il poliziotto lo stesso, anche se sono femmina...» Ridono tutti e due. Semafori, semafori. Infine la questura. Scale, corridoi, infine la giovane ausiliaria Loredana Doria entra nell’ufficio del vicecapo della Buon Costume. C’erano molte persone. Il vicecapo, prima di tutto, dietro la scrivania. Poi in una poltrona davanti alla scrivania una ragazza, evidentemente tedesca, vestita in qualche modo, il viso gonfio di botte. Forse non aveva ancora diciotto anni. Poi c’era un giovanottino dall’aria molto intelligente, era uno degli stenografi della questura. Poi c’era un signore sui sessant’anni, era l’ingegner Valarega, quello che aveva raccolto la tedesca. «Questa ragazza è stata trovata nuda e ferita, sotto la pioggia, sulle colline del Valentino», spiegò il vicecapo alla giovane ausiliaria. «Questo è l’ingegner Valarega che l’ha raccolta e l’ha portata qui. Non sappiamo molto, parla un tedesco terribile, poi è sotto choc, ma dobbiamo interrogarla subito se no i delinquenti prendono il volo. Comincia dal nome e tutto il resto, fin dal principio. Sai, noi l’abbiamo interrogata in piemontese, figurati che bel dialogo.» Il vicecapo sorrise. La giovane ausiliaria Loredana Doria sedette davanti alla tedesca che rabbrividiva nei goffi abiti che lì in questura le avevano trovato, con in mano il bicchiere di grappa che il vicecapo le aveva fatto portare per toglierla un poco dallo choc. E disse alla tedesca, nel suo limpido, dolce, latino, tedesco: «Non aver paura, cara, non vogliamo farti nessun male, vogliamo solo sapere la verità. Io mi chiamo Loredana, sono una tua amica». La ragazza tremò tutta. «Mi chiamo Herta Darst.» Singhiozzò: «Hanno ammazzato mia sorella». Nel suo dolce, limpido, latino, tedesco, Loredana Doria, ausiliaria di polizia, cominciò a interrogare la tedesca. «Dice che lei è dell’alto Bavarese, e che suo fratello, fin da quando aveva dodici anni, la costringeva ad andare coi suoi amici e si faceva pagare, e, se lei non andava, il fratello la picchiava.» «Istruttiva notizia. Ma voglio sapere come e perché è venuta in Italia. Tutto qui», disse il vicecapo. La giovane ausiliaria interrogò la tedeschina, poi tradusse in italiano: «Dice che appunto perché il fratello l’aveva avviata alla prostituzione lei, dopo Capodanno, aveva accettato l’offerta di un giovane italiano a venir qui». «Che razza di giovani signori che ci sono in giro», disse il vicecapo. L’ausiliaria riprese a tradurre le risposte della tedesca. «Dice che quest’uomo la convinse a trovare anche altre amiche, per passare una bella vacanza in Italia.» La tedesca bevette un poco di grappa, poi rispose alla nuova domanda. «Dice che lei convinse sua sorella maggiore e altre due amiche, quel giovane signore italiano le aiutò per i documenti e le portò a Francoforte dove le mise sul treno per Torino.» Il vicecapo disse: «E chi era questo, si fa per dire, giovane signore?». «Dice che non lo sa, queste ragazze non s’informano mai dei nomi.» Aspettò che la tedesca bevesse un altro sorso di grappa, poi le fece l’altra domanda, quella essenziale. «Dice che questa notte», tradusse in italiano, «è arrivato nella villa un signore molto grasso, era una casa d’appuntamento frequentata molto bene, venivano perfino da Milano. Dice che questo signore voleva due donne, e ha scelto loro due, questa ragazza e sua sorella.» L’ausiliaria mise una mano sulla spalla della ragazza che parlava singhiozzando. «Dice che l’uomo era un sadico e ha ucciso sua sorella e lei ha fatto appena in tempo a fuggire prima di essere uccisa a sua volta.» Silenzio. Lo stenografo aveva smesso di scrivere. L’ingegner Valarega ingoiò saliva. Il vicecapo si guardò un poco le unghie. «Non dirmi che questa povera disgraziata non sa dove si trova la villetta. Ho fatto bloccare tutta la zona, ma capirai bene che non possiamo visitare casa per casa.» «Dice che non lo sa, dice che è una grande villa sulla collina...» «Fatti dare qualche altro particolare.» «Dice che è una villa a mattoni.» L’ausiliaria abbracciò la tedeschina che singhiozzava sempre più disperata. «Bei mattoni scuri che le rammentavano le case del suo paese.» Il vicecapo si alzò di scatto. «La troviamo subito, non ce ne sono molte di ville di questo genere sulla collina.» Batté il pugno sul tavolo. «E ripuliamo la città da queste schifezze.» L’ingegner Valarega timidamente si fece avanti. «Dottore, la prego, il mio nome, in questa storia...» «Stia tranquillo, ingegnere.» Il vicecapo alzò le spalle e uscì. La giovane ausiliaria Loredana Doria continuò a tenere fra le braccia la tedesca e continuò a parlarle, in tedesco, finché la ragazza non smise di piangere. 49 · L’indomabile Quel giorno le aveva chiesto di venire a prenderlo in ufficio portando il bambino e fin dalla portineria dove i due uscieri si affrettarono ad aprire la porta lei sentì la potenza di suo marito in quel vecchio fabbricato, come altre volte l’aveva sentita, come ogni volta, e questa potenza si rifletteva ora anche sul piccolo in irreprensibile tutina marrone a bretelle, e la camiciola gialla, e gli occhi a mandorla di lui, la Bestia del padre, e neppure l’usciere anziano osò fargli una carezza, né sorridere, ma fu lei, come la Bestia l’aveva istruita, che gli disse: «Franco, saluta i signori». Il bambino eseguì con dolce ubbidienza la manovra che la governante gli aveva insegnato, congiungendo i piedi, tendendo la mano, e accennando, appena un accenno, un inchino col capo: «Buonasera» e i due uscieri tennero appena un attimo la mano del piccolo, e poi la sera l’avrebbero raccontato alle loro mogli, che avevano stretto la mano al principino dell’ingegnere che se non era il capo dell’azienda, e neppure uno dei capi più importanti, era il capo di più sicure promesse per l’avvenire, si sentiva nell’aria che stava salendo. In ascensore, sempre tenendo la mano del piccolo e guardando un bottone dorato dell’usciere più giovane che l’accompagnava, come scorta d’onore, non certo perché lei non sapesse la strada, sentì ancora l’improvviso senso di gola chiusa, come stessero strangolandola – ma forse non era così? – e il gelido sudore sulla fronte che ne conseguiva, ma sorrise con lo sguardo all’usciere che si scusò di precederla per farle da guida quando le portine dell’ascensore si aprirono, ed era ancora per quel ricordo convulso e disgustoso, quel foglio con quel lungo elenco di nomi, ricordo che ricacciò via per sorridere alla vecchia segretaria Grossini che veniva dal corridoio e che allargò le braccia e la bocca e subito si accucciò per essere all’altezza del piccolo. «Oh, signora, che meraviglia di bambino, e gli occhi tutti del padre.» Questi incontri troppo passionali erano stati previsti dalla governante piemontese ma diplomata in Svizzera, che aveva ideato per difesa una «manovra di sbarramento», e il piccolo, infatti, restò rigido, eretto, come quelle bambole che si facevano le bambine prima della prima guerra mondiale, le povere, con un manico di scopa imbottito di stracci, e tenne le braccia strette lungo i fianchi in modo che gli ardenti abbracci della signorina Grossini si spensero rapidamente come una lingua di fuoco contro un palo di cemento e lei subito si rialzò, sempre divorata dalla tenerezza che le ispirava il bambino, ma con dentro il gelido timore di essersi presa troppa confidenza verso uno dei familiari della potente stirpe dei dirigenti; e lei, che comprendeva come gli odiosi insegnamenti della governante facessero comportare talvolta il bambino in modo che poteva impietrire i semplici, e che aveva visto negli occhi della vecchia segretaria quel gelido timore, subito la consolò, abbracciandola. «Sono tanto felice di rivederla, Leni.» «Grazie, signora», lei rispose goffamente e goffamente, dopo l’abbraccio, si rimise a posto gli occhiali, dietro cui gli occhi non avevano più traccia del crudele disagio di prima, ed ecco, in quel momento, una delle quattro massicce porte del corridoio si aprì, ed era lui che, informato dall’usciere, veniva ad accogliere la moglie e il figlio, e il piccolo appena la vide gli corse addosso, gli si abbrancò a una delle due lunghe gambe perché – pensò lei – per il bambino c’era una sola deità, e questo divino si chiamava papà. Lui passò la sua grande mano sulla testa del bambino, curvandosi un poco. «Hai salutato la signorina?» gli disse. «Oh, sì, ci siamo già...» tentò di dire la signorina Grossini, ma, invitato dal padre, dal suo divino, il piccolo, per fargli piacere, per rendergli omaggio e per mostrare la sua perizia, andò subito dalla signorina Grossini, le si irrigidì davanti chinando galantemente il capo, e poi subito spiò, ansioso, suo padre. Lui prima sorrise alla moglie: «Grazie di avermelo portato, c’era Antonio che voleva vederlo, da tanto tempo». Lei pensò, per pura cattiveria, per quella stretta alla gola che le dava ogni tanto la sensazione di morire, che lui l’aveva fatta venire lì col bambino per molcire e invaghire qualche super-big dell’azienda e presentarsi in tutta la sua luce di padre di famiglia, marito amoroso e devoto al lavoro, ma questa volta vide che era stato un calunnioso pensiero e lui era davvero un dedito padre di famiglia e amoroso marito, e irrefrenabile lavoratore che solo col suo lavoro stava facendo carriera e non ostentando il suo pargolo sapiente. Infatti, col bambino in braccio, disdegnò l’ascensore e la scala padronale, per prendere quella di servizio e scendere seguito da lei nel vasto sotterraneo illuminato da una luce accecante e tremula che si rifletteva sulla cinquantina di automobili nuove disseminatevi in ordine, grosse e potenti, dalla linea armoniosa, dai tenui, sobrii colori e l’eco, quando ancora non aveva finito di scendere le scale, ripeté il suo grido, cordiale, bonario, democratico: «Antoniooooo, t’ho portato il pupooooo». L’invalido di età indefinibile, appoggiato al bastone, che venne avanti nella sua tuta blu scuro, fungeva da guardiano di quel mezzo miliardo circa di valore in auto, che lo circondava, lavoro non pericoloso perché era improbabile, sebbene non impossibile, che riuscissero a rubare delle auto da un sotterraneo, ma prima che i tedeschi gli rompessero il bacino e una mascella a calci, doveva essere stato un bell’uomo e la moglie e il bambino che, sempre i tedeschi, gli avevano bruciato nella chiesa del paese di sua moglie, in Francia, erano nella sua memoria, vivissimi, specialmente il piccolo, e voleva vedere ogni bambino, tutti i bambini, qualunque bambino, come se sperasse un giorno di riconoscere in qualcuno dei tanti bambini il suo, non pensando o non volendo pensare che dopo tanti anni il suo bambino ora sarebbe stato un uomo. «Saluta Antonio, è tanto che vuole vederti», disse lui mettendo il piccolo a terra. Antonio non poteva inginocchiarsi né curvarsi e tese la mano per toccare la mano tesa del bambino, e poi il suo capo. «Quanti anni hai?» chiese. «Cinque.» «Tu es vraiment un grand homme, mon vieux», disse Antonio, tu sei veramente un grand’uomo, vecchio mio, nel rotondo francese meridionale imparato da emigrante, un milione di anni prima, vangando vicino a sua moglie. «As-tu compris, Doudou?» Allora lei vide gli occhi di lui, della Bestia, ingrandirsi per un’ansiosa felicità paterna che, nonostante quel sentirsi strangolata e come vicina a morire, la intenerì: il piccolo aveva imparato il francese quasi insieme con l’italiano e ora si trattava di vedere se aveva capito, perché lui l’aveva fatta venire lì col bambino per questo, non per aprire il cuore di coloro che potevano fargli fare carriera, ma per mostrare orgoglioso il prodigio di quella sua creatura, e non a un grande o big dell’azienda ma, generosamente, a un povero invalido, a uno degli ultimi subalterni. «Oui, monsieur, j’ai bien compris », sì, signore, ho compreso; e suo marito sembrò ascoltarlo come il generale vincitore ascolta le mille trombe che suonano per il suo trionfo. A casa, prima di pranzo, lui accomodò la tenda indiana di Franco, che zoppicava da una parte; e dopo pranzo le disse se voleva andare al cinema, scelse il film che piaceva a lei, una commedia musicale, e uscendo dal cinema disse gentile che gli era piaciuta, che lo aveva disteso, ed era sincero, così come fu sincero quando a casa spense la luce e le si avvicinò, impetuoso e gentile, e lei cercò di non pensare, non pensare, non pensare, non pensare, finché al mattino invece ricominciò a pensare perché non si può vivere senza pensare. Lui era appena uscito, l’aveva appena lasciata, guidava la piccola utilitaria per le strade grigie di nebbia della sua Cremona, forse ricordando ancora Oui, j’ai bien compris della sera prima e il rombo delle mille trombe che immortalavano il suo trionfo di educatore e si fermò come ogni mattina al solito bar vicino alla stazione a prendere un altro caffè prima di andare in ufficio, guardando oltre la porta dai vetri un poco appannati le ombre dei viaggiatori che arrivavano con quei primi treni del mattino, giovanotti già in tuta, uomini con scuri e pesanti paltò, volti violacei di ragazzole, e fra queste una alta, che non sembrava invece aver freddo, con un giacchetto di pelliccia di gattopardo o quasi e una gonna corta che mostrava il ginocchio, delle lunghe, elastiche gambe su tacchi altissimi. La mano che teneva nella tasca del paltò gli si strinse a pugno quasi senza che ne avesse coscienza, uscì subito e guardò la ragazza che subito aprì la rossa bocca, ma egli avvicinandosi all’auto le fece un segreto segno, di no, negativo, e con lo sguardo le indicò il posteggio di tassì davanti alla stazione. La ragazza si fermò un momento, senza avvicinarglisi, poi sbatté le palpebre, aveva capito, gli voltò le spalle, andò al posteggio, salì su un tassì, lui la seguì con lo sguardo e poi salì anche lui sulla sua utilitaria. Nella nebbia il tassì andò avanti per primo sulla circonvallazione che portava allo stradone per Mantova, e l’utilitaria lo seguì, andarono avanti così, uscendo dalla città, un’auto cento metri dopo l’altra, correndo piano tra campi che quasi non si vedevano, mentre lui, guidando, teneva la sigaretta tra le labbra, fumandola così, un occhio un poco socchiuso per evitare il fumo, il tergicristallo che andava vanamente per pulire il vetro dall’umidità della nebbia, e mai vi riusciva del tutto, finché il tassì davanti non fermò e allora fermò anche lui. La nebbia era sempre più fitta e adesso non vedeva più il tassì, ma non ce ne era bisogno, dopo qualche minuto dalla nebbia emerse l’anfora dei fianchi della ragazza, le sue lunghe gambe, poi si distinse il rosso delle labbra e lui rimase immobile, la sigaretta tra le labbra, finché lei non aprì lo sportello dell’utilitaria e non gli fu seduta a fianco. «Avevo voglia di vederti», disse lei, «ma mi fai fare certe alzate, ho preso il treno alle sei.» Lui le mise una mano sul ginocchio. «Te l’ho già detto di non venire a Cremona, se non ti avviso io.» Ma era un rimprovero senza forza, non aveva più severità vicino a quei fianchi, l’osso del ginocchio di lei stretto nel palmo. «Leviamoci di qui, miosignore, se no con questa nebbia ci sbattono nel fosso», lei disse e nello stesso tempo un pullman strombettò isterico avendoli avvistati all’ultimo momento e sfiorandoli dopo una violenta sterzata. Ma neppure questo riusciva a smorzare quella specie di torpore violento che sempre più lo prendeva e aumentava, neppure il pericolo, con uno sforzo levò la mano dal ginocchio di lei e mise in moto, guidando dove sapeva, pratico di quella campagna, dove fin da bambino aveva spadroneggiato, pratico di ogni campo, ogni cascina, quasi ogni albero, e ogni sentiero appena tracciato, e così subito voltò a destra in una strada non asfaltata e al quarto incrocio a destra ancora, in un largo sentiero, e poi a sinistra, questa volta sull’erba umida dove le piccole ruote dell’utilitaria tendevano a slittare, ma ormai erano arrivati e intorno c’era soltanto nebbia, ancora più gocciolante, e nell’interno dell’auto quel ginocchio scoperto sul quale lui subito tornò a posare la mano. Come gli altri giorni, poco dopo l’una e mezzo, lui era a casa, a tavola, nella piccola sala, con la luce accesa perché quello che c’era di fuori non poteva chiamarsi giorno, e lei gli serviva le tagliatelle dalla tonda zuppiera cercando di non guardare l’angolo di quei suoi meravigliosi occhi a mandorla, ora come prolungato da una matita, ed era invece il Segno che lei aveva imparato a riconoscere: il Segno di quello che lui aveva fatto, e che certamente credeva di aver così ben nascosto, con le due auto nella nebbia, con le giravolte tra i campi fuori città, e invece lei era come se avesse visto e sapesse tutto anche se non aveva veduto e non sapeva nulla, la ragazza col ginocchio scoperto, le grosse labbra rosse, e forse anche il giacchetto di gattopardo o quasi, perché da troppi anni soffriva di quella tortura, e non aveva più stupore nemmeno nel pensare come mai lui, quasi appena uscito dalle sue braccia, potesse subito, ferinamente, cercare un’altra, perché da troppi anni non poteva più provare stupore neppure di questo, avendo già subìto da lui tutto il credibile e l’incredibile. Soltanto, quell’occhio, l’angolo dell’occhio, rilassato, momentaneamente, le faceva venire voglia di urlare, ma non urlò come non aveva quasi mai urlato, e non si scostò disgustata quando lui le posò una mano sul ginocchio sotto la tavola, dopo aver voracemente finito le tagliatelle e sincero disse: «Quando sei stufa di questa nebbia dimmelo che prendiamo la Fordona e ce ne andiamo a Sanremo come in luna di miele». Gliel’aveva detto suo cugino l’avvocato, e già diversi anni prima, quando col bambino di pochi mesi in braccio credeva d’impazzire quando lo vedeva tornare a casa con il Segno, e anche con altre tracce; glielo aveva detto che non poteva dire niente contro di lui, glielo aveva detto a punti: punto primo lui le voleva bene, lo aveva dovuto ammettere lei stessa, e la desiderava anche come donna; dall’appartamento di due stanze a Bozzolo l’aveva portata alla villetta con giardino lì a Cremona, e stava lavorando frenetico per andare alla sede di Milano dove aveva già comperato un appartamento, in via dei Giardini. Punto secondo, era un marito esemplare, che non usciva mai la sera, che passava le sere con la moglie e il figlio alla televisione, e di quello che faceva quasi nessuno sapeva niente, non aveva mai dato scandalo, che potesse offendere o umiliare la moglie. Lei aveva urlato, quel giorno, al cugino avvocato, al punto secondo, sì, era vero, lui non usciva mai la sera, mai, faceva tutto di giorno, dietro l’insuperabile alibi che doveva girare per lavoro da una sede all’altra, ma quella ragazza che le aveva telefonato, la prima volta, dopo sei mesi che erano sposati e lei ancora non supponeva l’assurdo futuro che la attendeva... «Parlo con la signora Pollazzi?» La voce era meccanica, quasi incisa su un registratore, insensibile, metafisica. «Sì, sono io», lei aveva risposto. «Mi chiamo Daria», aveva detto il registratore meccanico, benché fosse una vera voce umana. «Abito abbastanza vicino a lei. Suo marito è uscito due minuti fa da casa mia. Forse verrà subito da lei, comunque, quando può, gli guardi nel taschino della giacca. Ci ho messo una mia forcina con una ciocca di capelli rossi, non è che voglia di ritorno la forcina e i capelli, desideravo solo informarla, sono una neurotica intellettuale e anarchica, e desidero sfasciare le famiglie, ma temo che con la sua non riuscirò.» Non vi era stata neppure una risata, solo il tlic della comunicazione interrotta, e poi lei aveva trovato nel taschino della giacca, esattamente, la forcina e la ciocca di capelli, esattamente rossi, e non era stata neppure male, era stata semplicemente sul punto di essere portata al neurodeliri, non parlava più, non mangiava più, non si alzava più dalla poltrona in sala, in un angolo, e solo le lacrime e la disperazione di lui pentito, sinceramente pentito, che minacciava di uccidersi se lei non si fosse ripresa e si capiva che l’avrebbe fatto, l’avevano tolta da quell’abisso. Gli aveva creduto e aveva appena ricominciato a vivere, quando aveva sentito quel profumo, un giorno d’estate a tavola, con lo splendido sole di giugno, mentre gli tagliava una salamella alla cremonese che aveva sorvegliato lei stessa in cucina. Allora, a quei tempi lontani, quando il bambino non era ancora nato, lui era meno esperto ed era arrivato lì con quel profumo; lei lo aveva graffiato in viso, rovesciato il piatto di portata con le salamelle, una scena selvaggia, vicino alla finestra al quinto piano della casa dove abitavano allora, e dalla quale lei voleva buttarsi, perché lo amava veramente e il profumo dell’altra – chi altra? quale delle tante altre? – la spingeva a morire, ma gli urlò che era un miserabile, una bestia, e da allora lo chiamò la Bestia, che si sarebbe ucciso lui, con quella specie di lebbra indosso che lo rendeva schiavo della prima che vedeva sculettare per la strada e che sì, era meglio morire, e si sarebbe buttato lui fuori dalla finestra, per primo, perché non resisteva più al rimorso di farla soffrire così e lei finì anche quella volta per credergli, e gli credette ancora, volta dopo volta, attraverso gli anni, attraverso la maternità, perché il pentimento di lui era sempre sincero, profondo, perché lo vedeva terrorizzato all’idea di perderla, di perdere la famiglia, l’unione con lei, a cui dedicava tutto il suo lavoro e la sua vita; finché la sensibilità di lei si era come ottusa, di delusione in delusione e ogni volta che scopriva una traccia, ma erano sempre più rare, perché egli diveniva sempre più abile, e soltanto rimaneva il Segno, l’angolo dell’occhio rilassato, come un poco invecchiato, cercava di non vedere, di pensare solo alla casa, al bambino, finché questo suo continuo soffocare la realtà aveva cominciato a darle quel senso di strangolamento, ogni tanto, un ogni tanto sempre più frequente, e quelle punte di spillo gelate al cuore. Ecco, tutto questo aveva urlato al punto secondo del cugino avvocato, e quello aveva annuito ma aveva continuato a spiegare. Punto terzo: va bene, prendiamo la cosa dal punto di vista legale, e allora il codice tace su questo punto, il codice vuole o un adulterio continuato, ostentato, con la stessa donna, o una condotta riprovevole del marito e umiliante per la moglie, ed egli non faceva nulla di tutto questo, egli non aveva mai o quasi mai la stessa donna, ma sempre diverse, e nessuno poteva rimproverare la sua condotta, egli nascondeva le sue escursioni, diciamo galanti, in modo assoluto, tale che né la moglie né la famiglia fossero mai toccate, la voce pubblica lo giudicava un modello e anche se qualcuno sapeva qualche cosa, nessun danno ne veniva a lei. E se andiamo per tribunale non solo non possiamo provare nulla, ma anche se i giudici si rendono conto della situazione, non possono far nulla, tu sei una moglie con due automobili, una villetta, quattrocentomila lire al mese per la casa, e un marito di cui nessuno può provare nulla, neppure tu, perché non ti trascura in alcun modo, neppure come donna, e l’hai detto tu stessa, dopo più di dieci anni di matrimonio, e non c’è nessuno né qui a Cremona, né in tutta la provincia, né a Mantova o a Milano, né in qualunque altro posto del mondo che si diverta alle tue spalle perché tuo marito ti tradisce, perché nessuno lo sa che ti tradisce, non va con amici, anzi non ne ha, non passa le sere al bar a combinare orgette, e allora il tribunale dice che è meglio che te ne stai a casa tranquilla e cosa vuoi da lui, dal tribunale, che ha altro da fare con certi altri mariti che hanno una o anche due concubine pubbliche in giro, o donne che portano a casa della moglie e se lei parla, botte. E punto quarto, stai attenta alla tua salute mentale, perché a prendere le cose così per storto, la testa va insieme come la maionese che non lega, e quando hai fatto la separazione legale hai fatto il niente, hai soltanto levato il padre a tuo figlio, gli levi la famiglia, l’unione dei genitori, e tu rimani sola come una scarpa sinistra, e questo perché? perché lui di nascosto come un ladro, per dieci minuti, che dopo non si ricorda neppure chi era, va con un’altra, è una bestia, va bene, ed è capitata proprio a te, ma ricordati che non ha altri difetti, nessun altro. No, nessun altro, assolutamente nessun altro, e per quasi tre anni quell’aspro discorso, reale e sudicio come un biglietto da mille vecchio, l’aveva non calmata, ma tenuta a freno, nonostante sapesse, vedesse e sentisse, a ogni suo ritorno a casa o quasi, tutto quello che lui faceva, come se lo vedesse in un film, su uno schermo, sul suo viso, per quel segno, e per altri, come i gesti delle mani più morbidi, e la voce più profonda, e una maggiore facilità al sonno, perché non si vivono dieci anni giorno e notte con un uomo senza sapere a un certo punto quanti sono i pori della sua pelle e che è nervoso perché si toglie prima la calza sinistra che la destra la sera quando va a letto. E forse avrebbe resistito ancora tre anni o trenta, se un mattino, preparandogli come sempre l’abito nuovo e mettendogli via da spazzolare quello vecchio, non avesse voluto guardare nel suo portafoglio – oh, mai avesse fatto quella meschinità – e non avesse trovato quel lungo foglio, che si poteva, volendo, arrotolare come una pergamena, un codice antico, e uno sotto l’altro il nome di una trentina o più di ragazze, Silvana, Miranda, Ilaria, Cuccagna – era scritto proprio così – Domenicana – era proprio così – Marisa, Tango, Ohi Susanna – era proprio così, come la canzone western – Marilena I, Marilena II, Properzia, Giovanna, Evelina, Lillà, e tutti gli altri, e vicino a ogni nome il numero del telefono e vicino a qualche numero di telefono, tra parentesi, il nome dei giorni della settimana in cui evidentemente erano libere, tutti giorni feriali, lunedì, giovedì, sabato, e mai domenica, perché lui era «mai di domenica», perché la domenica la dedicava a lei, alla famiglia. E doveva aver lasciato un simile codice di sozzura nel portafoglio, nonostante la sua abilità, come anche il più abile degli spioni commette una volta il pauroso errore che lo porta all’impiccagione; ma, leggendolo, lei era straripata come un bacino che riesce a sfondare la diga e con un pugno sulla bocca rideva isterica, quasi non più cosciente, urlando quei nomi, così che lui, ancora a letto, si svegliò di soprassalto, saltò in ginocchio sul letto. «Lisetta, Lisetta, cosa c’è? Cosa fai?» Aveva urlato spazzando il piano del comò dal paralume e dalla grossa scatola di cristallo che conteneva le stecche per il collo delle camicie di lui e che caddero a terra in un cristallino rovinio e neppure le braccia di lui che la tenevano forte la facevano tornare in sé, neppure il pensiero che il bambino potesse udire e la cameriera e la governante accorrere, il suo urlo delirante, solo lo schiaffo forte di lui la bloccò, ma senza ridarle la coscienza, e il dottore disse a lui, prima di uscire, confidenzialmente, che andava male, che se avesse avuto un’altra crisi simile, bisognava pensare a una clinica, e nei giorni seguenti lui era stato male, non era neppure andato in ufficio, le aveva pianto addosso tutte le sue lacrime e il suo rimorso, dicendole che voleva scomparire, che se non ci fosse stato il bambino sarebbe scomparso, che quel foglio gliel’aveva dato un viaggiatore dell’azienda, ma solo per fargli vedere che razza di mondo era, che lui non conosceva nessuna di quelle ragazze, che non avrebbe più visto un’altra donna altrimenti non sarebbe tornato più a casa, mai e, senza credergli, senza fiducia, solo per il processo naturale del tempo che trascorreva, lei tornò ad alzarsi dal letto, a seguire la cameriera in cucina, a tenere il bambino quando la governante aveva la sua libertà, e non era passata neppure una settimana che lui era tornato a casa con quel segno all’angolo dell’occhio e lei non vi aveva badato neppure perché stava troppo male, anche se stava in piedi, ma ogni tanto doveva mettersi a letto, un giorno o due, e la governante veniva a farle da infermiera, col bambino che sfogliava i libri illustrati e diceva il nome delle figure che vedeva in italiano e in francese. Ma il lungo foglio, con la sconcia litania di nomi femminili, era rimasto, chi sa come, e l’aveva messo nella cassetta dove teneva le collane, i bracciali, l’orologio d’oro, i due anelli, e chi sa perché lo teneva. E una di quelle mattine che lei stava a letto, lui uscì come tutte le altre mattine, dopo aver preso il caffè vicino a lei, seduto sul bordo del letto, lo sguardo triste per lei malata, stringendole una mano nelle sue, commosso, dicendole di fare uno sforzo, di rimettersi in piedi presto, così avrebbero preso la Fordona e sarebbero andati in riviera. Uscì e avrebbe voluto tornare subito, per stare vicino a lei, ma alle undici era ancora alla filiale di Crema, con un agente scoccioso che non la smetteva più di fargli vedere registri e schedari e dopo si diresse verso Lodi, per l’altra ispezione, ma controvoglia perché la faccia verdastra della sua Lisetta non gli era piaciuta e quasi tornava indietro e dopo Lodi doveva fermarsi alla stazione di servizio sullo stradone, la nuova, per vedere come funzionava la pubblicità della vendita d’auto, e prima di arrivare a Lodi si fermò perché aveva sentito un rumore di motore che non gli piaceva per niente, alzò il cofano e cominciò a guardare nel motore, il caldo sole mattutino che gli batteva sulla nuca, quando, senza alzare il capo, vide passare vicino all’auto due nude gambe, alte lunghe, dal solido e morbido ginocchio, ed erano di una giovane contadina con su un abitino rossiccio e probabilmente niente altro, che oltrepassò la sua macchina dondolandosi sui fianchi e lui, sempre senza alzare il capo, solo volgendolo, la seguì, dimenticando il rumore del motore e tutto, poi richiuse di colpo il cofano e si accese una sigaretta che tenne tra le labbra, senza più levarla, e quando si volse ancora, non resistendo più a guardare, la contadina era già molto lontana e allora salì in macchina, mise in moto e la raggiunse, stando attento, anche spiando dallo specchietto retrovisore, che non vi fossero auto o gente. «Signorina, vuole un passaggio?» A chiamarle signorine ci stavano più facilmente. La contadina sorrise, il viso più fine del creduto, maliziosa. «Grazie.» Se ne andava via dondolando per lo stradone deserto, con quelle ginocchia scoperte, un passo da giovane animale sano e veloce che lo stordiva. «Non avrà mica paura?» La malizia dello sguardo di lei divenne impudente. «Mi piace andare a piedi.» «Guardi che bella macchina, vediamo se indovina la cilindrata», sapeva come prenderle. «Io non me ne intendo.» «È una quattromila gran turismo, sa cosa posso fare con questa? Salto da zero a cento chilometri all’ora in trenta metri.» «A me piace andar piano.» «Ah, ma questa va anche piano, non lo vede? la seguo a passo d’uomo, andiamo, salga, un giretto.» La ragazza rise, poi, nonostante gli zoccoli, saltò il fossato che divideva la strada dai campi, cadde in piedi sull’erba. «Ciao, un’altra volta, adesso non mi va.» E continuava a ridere, l’aveva preso in giro, ma se un’altra volta l’avesse incontrata, forse ci sarebbe stata, ma ora lui non poteva più aspettare un’altra volta, si fermò a Lodi al primo telefono pubblico, guardò nella sua agenda dove sotto la voce Legnami Imp. vi era un numero telefonico e, non avendo memoria per niente, lo compose cifra dopo cifra guardando nell’agenda una cifra dopo l’altra. «Sì», disse una voce femminile. «Ciao, sono Silvio», disse lui. «Che naso che ho», disse la voce femminile, «avevo scommesso mille lire che stamattina mi telefonavi.» «Libera?» disse lui. «Per il mio Silvio sempre.» «Lascia aperta la porta del box, ho la macchina grossa e non la voglio tenere per la strada.» Oltrepassò Lodi e appena fuori, in una via traversa, vide la villetta di Evelina, era aperto anche il cancello, e in fondo al vialetto il box che ingoiò la grossa auto. Appena l’aveva visto uscire lei aveva cominciato a sentirsi peggio perché era come sapesse e vedesse dove lui andava, e cercava di soffocare il pensiero ma era come voler turare la falla di una nave con le mani, il viso le si bagnò di sudore gelato e la gola era così chiusa che anche a bocca aperta riusciva appena a respirare. Anche senza che lei dicesse nulla, la governante se ne accorse, accompagnò il bambino in cucina, dalla cameriera, cosa che le ripugnava ma quello era un caso di forza maggiore e poi tornò nella camera di lei. «Vuole che le chiami il medico, signora?» Lei scosse il capo. «Posso chiamare suo marito.» Lei pensò, ma anche questo era inutile. «Provi.» La governante, alta, magra, dalle mani maschili, formò il numero sui telefono che era sul comodino. «L’ingegnere non è in ufficio», disse rapida la voce della centralinista, ed era logico, perché un ispettore dirigente va a ispezionare, in giro, e lui ispezionava. «L’ispettore Raimundo, el mas veloce seduttor del mundo», glielo aveva detto la sua amica Caterina, lo aveva sentito dire a Riccione, quell’anno che lui l’aveva portata sull’Adriatico, il più veloce seduttor del mondo, un amico dell’amica Caterina lo raccontava in giro ridendo. E a quel pensiero la crisi scoppiò, fredda, e così la dilaniò ancora di più. «Per favore, signorina, apra il secondo cassetto del comò a destra», disse alla governante. La governante eseguì. «C’è una cassetta di metallo, me la dia.» Quando la ebbe sul letto disse alla governante. «Ho delle chiavi nella borsetta, me le porti.» Aprì la cassetta, prese il lungo foglio, il Who’s who , il Chi è dello sposo fedele, l’almanacco di Gota delle squillo della provincia lombarda e viciniori. «Mi dia il telefono.» Avrebbe telefonato a tutte, ma non occorreva a tutte, oggi era martedì e non era necessario telefonare a quelle che erano libere solo il lunedì o il mercoledì, e da una avrebbe trovato suo marito, lo sapeva come lo vedesse. Dopo le prime due telefonate la governante, avendo compreso, tentò di fermarla, ma lei le disse di andarsene, e subito, allora la governante disse: «Almeno faccia telefonare a me». Finì per cedere, dopo la quinta telefonata non gliela faceva più, e allora la governante cominciò, metodica e implacabile, nome dopo nome, Ilaria dopo Giovanna, Marisa dopo Marilena I, Miranda dopo Silvana. «Signorina, è una cosa grave, se c’è il signor Silvio Pollazzi da lei gli dica di tornare subito a casa, sua moglie sta male.» Qualche numero non rispondeva, ma tutte le voci femminili dicevano, una dopo l’altra, che no, il signor Silvio Pollazzi non c’era, non lo conoscevano, non ne avevano mai sentito parlare. «Non importa, signorina, se caso mai fosse lì, gli dica di tornare subito a casa, sua moglie sta male.» Cinque, sei, sette, dieci, dodici, quattordici nomi femminili e da tutte le voci la stessa risposta. «Continui», ordinò lei alla governante asciugandosi il sudore gelato col bordo del lenzuolo. Il telefono squillò mentre lui stava accendendo una sigaretta a Evelina. «Uh, che barba», lei disse e staccò il ricevitore. Lui le guardava, fumando con la sigaretta tra le labbra, le ginocchia rese più morbide dalla velatura bronzea delle calze. «La signorina Evelina?» «Sì.» «Signorina, è una cosa grave, se c’è il signor Silvio Pollazzi da lei gli dica di tornare subito a casa, sua moglie sta male.» Ancora prima che finisse, Evelina aveva messo la mano sul ricevitore. «Cercano te, dicono che tua moglie sta male.» Lui si tolse la sigaretta dalle labbra, poi scosse il capo. «Ma io non conosco questo signore», disse Evelina. «Non importa, signorina, se caso mai fosse lì gli dica di tornare subito a casa, sua moglie sta male», e la comunicazione venne chiusa. «Ha ripetuto che tua moglie sta male e che devi tornare subito a casa», disse Evelina. «Poi ha staccato.» Lui si curvò a raccogliere la sigaretta che gli era caduta accesa e la spense nel posacenere. «Ti conviene andare», disse Evelina. «Mi dispiace, vedrai che non è niente di grave, lo so che ci tieni tanto.» Con un gesto nervoso della mano lui le fece cenno di tacere, poi tornò a sedersi sul divano vicino a lei. «Non posso andare», disse. «Perché?» «Perché se ritorno prima del solito orario lei capisce che mi ha pescato qui da te, o da un’altra, e allora soffre di più.» Era vero, era proprio così, la vedeva che stava telefonando a tutte le ragazze di quell’elenco, c’era solo una speranza di nasconderle la verità e non farla soffrire, tornare alla solita ora, anche un poco più tardi, tanto adesso era quasi mezzogiorno, fra poco più di un’ora sarebbe stato a casa. Silenzioso, lentamente, si accese un’altra sigaretta e la tenne tra le labbra e solo allora si accorse di aver messo una mano su un ginocchio della ragazza, e così comprese che tutto quel ragionamento che aveva fatto prima era fasullo, un pretesto, perché non riusciva a muoversi da lì, da quel ginocchio, ma adesso che se ne era reso conto era troppo tardi. Arrivò dieci minuti più tardi del solito, andò subito in camera da lei, la governante si alzò per lasciarli soli. «Come stai, Lisetta?» Lei stava seduta sul letto, rinfrescata da mezzo litro di lavanda, racconsolata, anzi rappezzata, dalle parole, povere ma generose, della governante zitella che aveva cercato di calmarla e non volle neppure vedere il Segno, non voleva vedere niente, sapere niente, perché tanto era inutile. «Solito.» «Mangio qui vicino a te, sul carrello», disse lui, intenerito, «non voglio stare solo, laggiù in sala.» «No, caro», lei disse, una volta o l’altra sarebbe morta, ma finché non moriva sarebbe stato così, e scese dal letto. «Vengo a mangiare con te, in sala.» Se non c’era la moglie che lo serviva, stava male, non perché non fosse servito bene, ma perché la voleva vicina, le voleva bene, era uno sposo innamorato. «Oh, cara, ma non ti farà male?» Lei spostò il cuscino per nascondere meglio il lungo foglio che aveva nascosto lì sotto, voleva dormire con tutti quei nomi di donna sotto il cuscino, e impazzire, e sarebbe impazzita, un giorno o l’altro, ma lui non sarebbe cambiato: era indomabile. «No, è meglio che stia in piedi.» Finché fosse riuscita a starci. 50 · Rififi per promessi sposi Berto Valnez teneva il grosso lupo siberiano per un guinzaglio corto: una catena di acciaio. Il lupo si chiamava Stalingrado. Era praticamente una bestia feroce, anche se classificato come cane. Conosceva soltanto Berto e un paio di altre persone della fabbrica, tutti gli altri era pronto a sbranarli se Berto non lo avesse trattenuto. Erano le sei del mattino, ma era ancora completamente buio. Doveva fare ancora quattro giri, poi alle sette sarebbe arrivato il guardiano di giorno e lo avrebbe rilevato. Con pazienza, anche se stanco, riprese il suo monotono viaggio. Il grande stabilimento farmaceutico era composto di due grandi edifici, uno a quattro piani, con i laboratori e gli uffici, l’altro disteso orizzontalmente, una serie di capannoni collegati l’uno all’altro, con tutto il macchinario per la fabbricazione e l’inscatolamento dei medicinali. Oltre Berto Valnez, c’era un altro guardiano, senza cane, Lorio Aspasis, un vecchio molto in gamba che parlava un torinese strettissimo che Berto stesso stentava a capire. Si davano il cambio, una volta Lorio ispezionava i capannoni mentre Berto girava gli uffici, e poi all’inverso. Vi erano tra tutt’e due gli edifici circa una trentina di orologi controllo da bucare, un giro intero di un edificio richiedeva almeno venti minuti, e con Stalingrado che tirava disperatamente come trascinasse una slitta con sei persone, la passeggiata era ancora più faticosa. Alle sei e un quarto Berto era al quarto piano del palazzo degli uffici. Timbrò all’orologio controllo del piano e andò subito alla porta blindata del numero 10. Questa porta dava nella stanza più gelosamente riservata dello stabilimento, la emme di, magazzino droghe. Senza che si vedesse alcun filo o alcun congegno – era assolutamente una porta come le altre – bastava toccare la maniglia, o tentare di forzare minimamente la porta perché il segnale d’allarme scattasse, direttamente anche in questura, e in quattro minuti arrivava al completo il comando antidroga di polizia. Tutte queste precauzioni erano prese perché nell’interno del magazzino vi era una cassaforte più ricca di quella del più ricco gioielliere di Torino. Vi erano chili di morfina e morfinoidi, oppio puro ed oppiacei, amfetaminici ad alta potenza, e anche allucinogeni di vario tipo, fra cui l’LSD. Alcuni di questi allucinogeni venivano venduti al mercato nero anche a centomila lire il grammo, l’oro diventava un metallo per poveretti al confronto. Sul muro vicino alla porta dell’emme di erano accese tre lampadine, erano tutte e tre blu. Voleva dire che tutto andava bene. Prima lampadina: indicava che il gruppo elettrogeno, nell’interno del magazzino, non era stato toccato. Infatti dei ladri avrebbero potuto tagliare i fili della corrente per tutto lo stabilimento, in modo da impedire il funzionamento del segnale di allarme, ma questo non poteva avvenire perché il gruppo elettrogeno avrebbe fornito energia autonoma, anche se tutti i fili fossero stati tagliati. Seconda lampadina: indicava che il sistema di allarme chiuso nella cassaforte funzionava regolarmente, era munito anche di un orologio a rullo di carta che si fermava istantaneamente appena qualcuno avesse tentato di forzare la cassaforte. La terza lampadina era il super controllo, o la prova del nove: se il generatore si fosse guastato, o l’allarme nella cassaforte non funzionava bene, la terza lampada avrebbe lampeggiato rosso. Tutto era invece regolare, vide Berto controllando le tre lampadine dalla morbida luce azzurra. Intanto Stalingrado tirava, soffiava, guaiva, perché voleva uscire all’aperto. Berto discese a pianterreno, s’incontrò con Lorio, nel cortile, che aveva finito l’ispezione ai capannoni e veniva a dargli il cambio, per visitare lui il palazzo degli uffici. Fumarono una sigaretta all’aria fredda che li svegliò un poco. «Vorrei sapere come farai a fare la notte di nozze, se continui a fare il guardiano notturno», disse Lorio. Era la solita battuta sfottente che gli diceva da quando aveva saputo che Berto si sposava. «Puoi chiedere al capo del personale se la notte di nozze ti lascia portare tua moglie qui, nell’ufficio del direttore c’è un divano quasi a tre piazze, così tu un po’ fai la guardia con Stalingrado, un po’ fai il marito.» «E finiscila.» Era sempre lo stesso scherzo. Lo odiava. Del resto da qualche giorno odiava tutti e tutto, escluso Evelina. Alle sette meno dieci arrivò il custode del turno di giorno e Berto andò a casa a dormire, da sua madre. Non dormì niente, neppure un minuto. All’una si alzò, sua madre gli aveva preparato le fettuccine con la pancetta, ma lui non mangiò, niente. «Non ti senti bene?» «Sto benissimo. Solo ho il nervoso.» Attese le due. Alle due, puntualissima, arrivò Evelina. Era domenica, e la domenica lui ed Evelina andavano a vedere la loro casa. Era un grosso palazzo, però non aveva niente del casermone, a neppure duecento metri dalla casa della madre di lui. Intorno c’era un grande prato cintato, con qualche piccolo albero, con altalene, dondoli, scivoli, girelli per far giocare i bambini. Sembrava un palazzo di ricchi, ne erano orgogliosi. Lui, da qualche tempo, no, ne era solo ansioso, angosciato. Attraversarono il giardino, in quella nebbiosa giornata di dicembre. Entrarono nell’ascensore – aveva perfino l’ascensore quella casa – al quarto piano raggiunsero nel lungo corridoio la quarta porta, c’era già la targhetta col cognome di lui, Valnez. Avevano le chiavi, segno di proprietà, perché quell’appartamento era loro, era comprato, comprato a rate ma comprato. Entrarono e richiusero la porta. L’appartamento era completamente vuoto, dal soffitto pendevano i fili senza neppure il portalampade, e quindi senza lampadina. Non vi era nessun mobile, in nessuna delle tre stanze, neppure una sedia, i vetri avevano ancora la grande s fatta col gesso dai muratori che avevano rifinito i locali. Girarono in silenzio la loro casa, i passi echeggiavano nel vuoto, in cucina controllarono che l’acqua calda ci fosse. C’era. Erano accesi anche i termosifoni. Anche in bagno controllarono l’acqua, che tutto funzionasse bene. Poi andarono in quella che sarebbe stata la camera da letto, vi erano le prese per mettere i paralumi sui comodini, mancavano soltanto i comodini, i paralumi, e il letto. Sedettero in terra al posto dove sarebbe stato il letto, ogni domenica facevano così. «Perché non parli?» lei disse. «Ah, se vuoi che parli, parlo subito.» Berto si accese una sigaretta. «Neanche una lira. Ho girato due giorni di seguito. L’istituto di finanziamento non dà una lira perché dice che offro poche garanzie, e poi dicono che faccio un mestiere pericoloso, il guardiano notturno, i ladri possono ammazzarmi e dopo per loro è difficile riavere il prestito dagli eredi. In banca, quasi mi buttano fuori, mi hanno dato già troppo su un appartamento così piccolo e se non pago le prossime rate si pigliano loro l’appartamento. In fabbrica ho chiesto un prestito, ma l’amministratore ha detto di no. Niente da fare, Evelina. Se ci sposiamo, veniamo a dormire qui in terra, senza luce, perché mia madre non ti vuole in casa sua, ti odia perché le porti via l’unico figlio maschio, e io non posso certo venire a dormire da te, alle Beate Paoline. Le suore non vorrebbero.» Lei gli prese una sigaretta dal pacchetto e se l’accese. Disse pensosa e appassionata: «Ci basta un materasso, un materasso e una lampadina, venerdì, quando prendo la paga, lo compro io». «Certo, basta un materasso», disse Berto amaro. «Un materasso, una lampadina, e magari anche una sedia. Poi io direi anche un tavolo. Forse si può risparmiare sul tavolo, mangiamo in terra, ma almeno le posate e i piatti ci vogliono, la minestra per esempio non si può mangiare con le mani...» Lui alzò le spalle. «Evelina, è inutile illudersi, dobbiamo ancora rimandare le pubblicazioni di matrimonio. Non possiamo sposarci fra una settimana. Forse neppure fra un mese. Abbiamo speso tutti i nostri risparmi per comperare in parte questa casa, perché abbiamo ancora sei milioni da pagare, e voglio vedere dove li troviamo, così il risultato è che non abbiamo più i soldi e che questa casa non è ancora nostra e chi sa mai se lo sarà.» Evelina lo baciò per farlo tacere. Lei sperava, sperava sempre, forse in un miracolo. Il solito caffè vicino allo stabilimento farmaceutico, dove veniva a passare la mezz’ora prima di riprendere servizio, perché alle nove accompagnava Evelina alle Beate Paoline e lui fino alle dieci era libero. Le solite facce, il padrone dietro la cassa, nervoso perché il locale era vuoto, il giovane barista che sfogliava una rivista per soli uomini e così ogni tanto gli veniva un tic all’occhio destro, i soliti due lattonzoli che giocavano al flipper con la sigaretta tenuta tra le labbra e un occhio chiuso per il fumo che saliva al viso. Poi Giovanni, detto Figlio di Mamma, che era seduto a un tavolo con un bicchierone di birra e con le carte si esercitava forse a barare, perché non era tipo da solitari. E fu Figlio di Mamma che si alzò, con in mano le carte e la birra e venne a sedersi al suo tavolo. «Ciao, Berto, come va?» «Benissimo», disse Berto rigirando il cucchiaino nella tazza del caffè vuota. «Sono contento», disse Figlio di Mamma sornione, «a me però un uccellino ha detto che per sposarti ti farebbe comodo un milione.» «Perché? Hai intenzione di darmelo tu?» «Certo, guarda qui.» Cominciò a disporre delle carte sul tavolo: «Tu lavori in un’azienda farmaceutica, a poche centinaia di metri da qui. Queste quattro carte una dopo l’altra, sono i quattro piani del palazzo degli uffici. Per caso ho saputo che al quarto piano c’è una stanza speciale, si chiama l’emme di, magazzino droga. Vedi che sono bene informato. Poi ho saputo che dentro questa stanza c’è una cassaforte, che non contiene oro o brillanti, ma qualche cosa di meglio: droga.» «E allora?» disse Berto socchiudendo gli occhi e abbandonandosi meglio sulla spalliera della poltrona. «Allora ammettiamo che uno voglia entrare in questa stanza emme di 10 e portarsi via il contenuto della cassaforte. La cosa è molto difficile, non ti sembra? C’è un guardiano con un lupo siberiano che fa paura solo a vederlo, e un altro guardiano, tutti e due armati e pronti a sparare. Ma ammettiamo che questo qualcuno possa neutralizzare i guardiani e arrivare davanti alla porta 10, non ha ancora combinato niente. Appena tocca la maniglia o cerca di lavorare la porta, suonano tutte le suonerie e pochi minuti dopo arriva la polizia. È inutile che tagli i fili della corrente, perché i segnali d’allarme della porta 10 sono legati a un gruppo elettrogeno autonomo dentro la stanza. Non gli resta che un mezzo.» Berto guardava sempre la sua tazzina di caffè vuota, era proprio curioso di sapere di che mezzo si trattava. «Tu lo sai che vicino alla porta 10 c’è la bocca della pompa antincendio. Questa bocca è scavata nel muro che dà nella stanza emme di, così che il muro in quel punto risulta di uno spessore minimo e con pochi colpi si apre un bel foro. Attraverso questo foro si fa passare un ragazzino smilzo che entra nella stanza 10, spegne il gruppo elettrogeno e, dopo, aprire la porta è uno scherzo. Aprire la cassaforte è solo una questione di nitroglicerina e il qualcuno, coi suoi amici, si porta via tutte le belle polverine e fialette chiuse nella cassaforte.» Berto non disse nulla, ma Figlio di Mamma continuò tranquillo: «Naturalmente questo qualcuno non riuscirà a niente se non ha l’aiuto di uno dei due guardiani, per esempio di quello col cane. Il qualcuno potrebbe per esempio dare a questo guardiano una bottiglia con del cloroformio e un po’ d’ovatta. All’ora convenuta il guardiano tampona il naso e la bocca del cane col cloroformio, così per una bella mezz’ora non c’è pericolo che abbai, poi entra il qualcuno coi suoi amici, neutralizzano l’altro guardiano, sempre col cloroformio, poi sale al quarto piano e il lavoro è fatto». Berto mise sul tavolo le cinquanta lire per pagare il caffè. «Hai altro da dire?» disse a Figlio di Mamma. «Sì, guarda questa busta», levò una busta tutta gualcita dalla tasca, «In fondo non è molto gonfia, eppure contiene mezzo milione, cinquanta biglietti da diecimila.» Con discrezione, perché gli altri non vedessero, glieli mostrò. «Sono un buon principio per ammobiliare l’appartamento di due giovani sposi. Ma questo è niente. Appena avremo fatto il colpo, ti darò un altro milione e mezzo. Pensaci. Domani sera passo di qui.» Alle due di notte del giorno convenuto, Stalingrado, dopo aver leggermente guaito sotto il tampone di cloroformio, prima si inginocchiò in terra, come un toro morente, poi crollò disteso di fianco. Berto aveva in tasca la busta col mezzo milione, lo trascinò in un angolo buio del cortile, poi andò ad aprire il cancello d’ingresso. Entrarono subito Figlio di Mamma, e altre due persone, fra cui un ragazzo che non doveva avere più di dodici anni. L’adulto, col tampone imbevuto di cloroformio, raggiunse i capannoni, saltò alle spalle di Lorio, l’altro guardiano, e lo addormentò prima che quello potesse emettere il minimo gemito. Poi Berto li guidò al quarto piano, Figlio di Mamma e gli altri eseguirono tutto secondo il piano prestabilito. Sfondarono facilmente il muro della bocca della pompa antincendio, il ragazzino vi si infilò ed entrò nell’interno della stanza 10. In quello stesso momento Figlio di Mamma saltò alle spalle di Berto e gli applicò il tampone fradicio di cloroformio. Nonostante un tentativo di reazione, Berto non poté fare nulla, cadde a terra fulminato dal sonno. Figlio di Mamma gli tolse dalla tasca la busta col mezzo milione, sorridendo. Il rififì continuò. Il ragazzo spense il gruppo elettrogeno. «Fatto», disse ai suoi compagni che erano fuori. Quando Berto si svegliò si trovò sul famoso divano a tre piazze nell’ufficio del direttore. Vide vicino a sé un agente di polizia, e l’ufficio era pieno di poliziotti, e c’era anche il direttore che gli sorrise vedendolo risvegliarsi. Poi c’era un signore che gli teneva il polso, doveva essere il medico. «Li avete presi?» domandò Berto all’agente. «Tutti.» «E Stalingrado come sta?» «Benissimo», disse Lorio che aveva ancora gli occhi un poco addormentati dal cloroformio. «Avevano anche le cinquecentomila lire che le avevano date. Gliele avevano prese appena l’hanno addormentato.» «La devo ringraziare, signor Valnez», disse il direttore avvicinandosi, «lei ha fatto catturare la peggiore banda della zona.» “Va bene”, pensò Berto, “grazie dei ringraziamenti.” L’indomani era domenica. Lui ed Evelina raggiunsero la loro casa. Controllarono l’acqua, aprirono un poco le finestre, poi le richiusero perché faceva freddo, e andarono a sedersi in terra, in camera da letto. Lui si accese una sigaretta. «Guarda qui», disse. Levò dalla tasca un cartoncino piegato in due. «Che cos’è?» disse Evelina. «È il libretto di acquisti ai grandi magazzini, garantisce la ditta. Possiamo spendere fino a mezzo milione... pagherò a piccole rate.» D’improvviso lei vide nelle stanze vuote germogliare mezzo milione di mobili come fiori, il letto, il tavolo, le sedie, un bell’armadio, e le lampade, e le tendine alle finestre, ma sentì anche che non avrebbe mai dimenticato la dolcezza di quelle ore passate seduta in terra, vicina a lui. Berto le mise una mano su un ginocchio, scosse il capo. «Che stupidi», disse, «come hanno fatto a non pensare che io avrei avvisato la polizia? Come hanno potuto credere che io li aiutassi?» 51 · Pericolo di vita Molto rumore per nulla: tutto quel vento che aveva fatto sbatacchiare porte e finestre della piccola clinica non era servito a nulla, non aveva schiarito il cielo, anzi, aveva portato nuove nuvole, ancora più scure, e quindi la pioggia. I vetri della finestra s’inghirlandarono nuovamente di pioggia, e la signorina Adriana Mosetti guardò attraverso quelle gocce lo squallido giardino così polveroso che neppure il vento e la pioggia riuscivano a pulirlo, soltanto trasformavano in fanghiglia la polvere. La clinica sorgeva infatti in pieno centro della città e il giardino intorno era solo una ridicola e maleolente mistificazione. Il nome della clinica era Casa di cura Amerigi e, ufficialmente, i sanitari che vi lavoravano erano specializzati in cure ginecologiche, il che, in un certo senso, era anche vero, benché la loro vera specializzazione, pur essendo ginecologica, fosse di un genere non gradito alla polizia in quanto consisteva nel fatto di liberare signore e signorine dalle conseguenze di qualche imprevisto errore amoroso. La signorina Adriana Mosetti si trovava nella Casa di cura Amerigi appunto per questa ragione. Ai primi di giugno, nonostante il freddo, facendo il bagno, aveva incontrato, casualmente, un giovane signore che come lei non pativa il freddo, e nuotando avevano iniziato una cordiale conversazione. Questo signore le aveva dato solo il nome di battesimo, Saverio, e dopo la conversazione, protrattasi fino al mattino seguente, era scomparso, e ciò non era tanto dispiaciuto a lei, quanto era dispiaciuto, due mesi dopo, di essere tristemente sicura che attendeva un bambino. Essendo fidanzata, e data la sua posizione sociale, la cosa presentava aspetti difficili, ma un’amica esperta le aveva indicata la Casa di cura Amerigi, dove infatti aveva trovato un primario molto comprensivo che l’aveva assicurata che giovedì 7 settembre, nel pomeriggio, sarebbe stata libera da ogni preoccupazione. Anche le altre degenti della clinica, in totale sei, avevano ricevuto la stessa assicurazione. Anche in un’epoca di pillole, come questa, il professor Amerigi sapeva benissimo che possono accadere incidenti, dimenticanze, errori, e lui lavorava su queste dimenticanze. Da anni. Vi erano state pazienti che erano tornate da lui più volte. Dati i prezzi, la Casa di cura Amerigi era accessibile solo alle più facoltose famiglie milanesi, e lei era infatti chiamata dagli amici Adrianina il Pioppo, perché suo padre possedeva quasi tutti i pioppeti dell’Italia del Nord, e coi pioppi riforniva di carta mezzo paese. Erano le 15 e 10 del pomeriggio e in quel momento lei sentì ululare una sirena, doveva essere un’autoambulanza, sembrava venire proprio lì, verso la Casa di cura Amerigi, e infatti, guardando dalla finestra, vide che l’auto si fermava lì, ma non era un’autoambulanza, era una Pantera della polizia e dietro veniva una camionetta dalla quale, come marine in uno sbarco, esplosero subito fuori una diecina di poliziotti in divisa che in parte circondarono, e in parte irruppero nella villetta. La signorina Adriana Mosetti cominciò a capire, sia pure confusamente, ma ebbe la conferma dal telefono. Il telefono squillò, lei sollevò il ricevitore, la voce di un’infermiera, la riconosceva, era Rosella, le disse: «Signorina, si nasconda, c’è la polizia...». Forse era uno stupido consiglio, ma lei depose il ricevitore e stava pensando effettivamente dove nascondersi, quando un poliziotto in borghese e uno in divisa irruppero nella stanza. «Si vesta e venga con noi», disse il poliziotto in borghese. Nel rilasciarla, il vicebrigadiere le disse: «Signorina Mosetti, l’avverto ancora una volta che gli esami hanno stabilito che lei è in attesa di un bambino e che lei si trovava in quella cosiddetta casa di cura per non averlo. Come lei sa, il primario, gli altri due medici, le quattro infermiere, sono stati arrestati. E sono state arrestate anche due donne che erano lì per lo stesso suo motivo». «Non è vero», disse Adriana Mosetti altera, «io ero lì per una banale infiammazione.» «Sì, signorina, questo è quello che ha tentato di provare il suo avvocato, e io fingo di crederci, e la rimando a casa. Ma stia molto attenta...» «Attenta a che?» disse altera lei. «Ogni settimana muore almeno una donna in seguito a pratiche illecite», disse il vicebrigadiere, umanamente. Fu un peccato che lei rispondesse nel modo sbagliato: «L’informazione non mi riguarda». Il vicebrigadiere la fissò, storse un momento la bocca, pensò: “È una disgraziata, anche se nuota nei miliardi”, poi le disse: «Può andare, di fuori c’è il suo avvocato che l’aspetta.» Lei andò. L’avvocato, in auto, le spiegò, che adesso doveva decidere lei, se voleva avere il bambino, o no. Se decideva di averlo, avrebbe dovuto naturalmente sposarsi subito con qualcuno che riconoscesse il bambino. Altrimenti bisognava che andasse in Francia o in Svizzera, e prendesse subito la nazionalità francese o svizzera. Lo scandalo, qui in Italia, era stato troppo grande, non si sarebbe trovato nessun medico disposto ad aiutarla, mentre in Francia o in Svizzera si sarebbe potuta ottenere perfino l’autorizzazione ufficiale per eseguire la pratica. «Non desidero bambini», lei disse altera. «E preferisco andare in Svizzera, la Francia non mi piace.» L’avvocato disse che andava bene e che avrebbe parlato anche con i suoi genitori, comunque, spiegò, sarebbe stato meglio partire quel giorno stesso per Lugano, in modo da sottrarsi ai fotografi e ai giornalisti. «Certo», lei disse, «vado a casa a farmi fare le valigie e parto subito.» A casa, dove l’avvocato riuscì a portarla superando uno sbarramento di fotografi e di giornalisti, fu accolta gentilmente e freddamente. Lo stile è tutto, in una classe sociale così alta. Sua madre le disse, gentile e fredda, mostrandole le varie edizioni dei giornali del mattino e del pomeriggio, che da settantadue ore parlavano della Casa di cura Amerigi e delle degenti di detta clinica, tra le quali lei: «Sei contenta, cretina?». Adriana Mosetti lesse alcuni titoli, fra i più significativi: In pieno centro una fabbrica di angeli. E poi: Tra le donne ospitate per pratiche illecite anche la figlia del grande industriale Mosetti. Forse per istinto masochistico di farsi male, ne lesse anche un altro paio: Adriana Mosetti nel cantiere degli angeli, e quest’altro: Una settimana di degenza a mezzo milione il giorno. Poi, senza volerlo, gliene cadde sotto gli occhi un altro: Nella fabbrica degli angeli c’era anche una squillo. Questa, per fortuna non era lei, ma era evidente che non era in buona compagnia. Adriana rispose alla madre, mentre l’avvocato, in disparte, si accendeva una sigaretta: «Non sono contenta». Cominciava ad avere un po’ di mal di stomaco, era stata chiusa quasi tre giorni in questura ma non aveva mai immaginato che succedesse uno spavento simile. «Perché, cretina, non hai parlato con me? Pensavo io a tutto», disse gentile, fredda sua madre. «Perché è una questione privata», lei disse, e intanto che parlava si accorse di aver detto una stupidaggine. «Con tutti questi giornali, la chiami una questione privata?» disse gentile e fredda sua madre. «Privata in che senso? Cretina.» «Non mi piace che tu mi dica cretina davanti a un estraneo», lei disse. «Hai ragione, cretina», disse la signora Donata Mosetti, più altera ancora di sua figlia. «Posso sapere almeno il nome del padre del bambino?» «Non dirmi più così, mamma.» Adriana prese un pesante portacenere di cristallo rosa che era sul tavolino. «Ci hai rovinati, cretina...» disse sua madre. L’avvocato che sorvegliava la conversazione intervenne appena in tempo. L’ingegner Vittoriano Mosetti, padre di Adriana, ebbe anche lui, un’ora dopo, un colloquio gentile e freddo con la figlia. «L’avvocato ha consigliato di mandarti in Francia o in Svizzera. Tu non andrai da nessuna parte. Appena ti muovi dall’Italia, tutti capiscono che vai all’estero per perdere il bambino. Mi hai già buttato in una pattumiera di sudiciume, adesso basta. Tu stai qui in casa e avrai il bambino. Se avrai la cortesia di dirmi chi è stato, e se tu vorrai sposarlo, potrei anche intervenire io.» Lei disse: «Papà, non domandarmi nulla. Sono maggiorenne.» Ma se i miliardi davano alterigia a lei, ne davano molta di più anche a suo padre che li aveva fabbricati. «Tu ubbidirai a me. Resti qui e avrai il bambino.» Un brutale schiaffo fu la firma a quelle parole. Lei gemette, coprendosi istintivamente il viso, ma suo padre riuscì a colpirla ancora. «In due giorni hai sporcato tutti, te stessa, me, tua madre, il mio lavoro. Adesso devi ubbidire o ti uccido, ma a schiaffi, così», e gliene dette un altro. «Starai qui, a casa, e avrai il bambino: è l’unico modo per salvare il poco che c’è da salvare.» Il viso chiuso tra le mani nel timore di ricevere altri schiaffi, le orecchie rombanti, un occhio dolente, lei disse: «Sì, papà, resto qui». «E non fare colpi di testa, perché nascerebbero altri scandali e allora, te l’ho detto, ti uccido. Guarda che ti uccido davvero.» Non aveva bisogno di dirglielo che l’avrebbe uccisa davvero, conosceva suo padre: l’avrebbe veramente uccisa, ma non era di questo che aveva paura. Ripeté: «Sì, papà, resto qui». Con Alessandro, il suo fidanzato, la conversazione fu, non solo gentile, ma anche patetica. Alessandro era veramente buono, e infinitamente comprensivo. Telefonò. Era un ragazzo che viveva telefonando; per la sua timidezza, per la paura di guardare gli altri negli occhi, il telefono era il suo naturale mezzo di comunicazione sociale. «Adrianina, sono tanto infelice, ma tanto tanto, tu non immagini cosa è successo qui in casa appena hanno saputo, io ho litigato con mamma e papà, per difenderti perché parlavano di te in un modo che mi vergogno di loro. Sono disperato. Adrianina, io capisco come accadono certe cose nella vita, ma la gente, sai, è così stupida...» Era uno dei più teneri e generosi congedi che un fidanzato potesse dare alla fidanzata che è stata con un altro. Col consenso di suo padre lei poté andare a Roma dalla zia Marta. A Roma era arrivata solo una lieve eco dello scandalo. Nelle lunghe serate davanti alla televisione vicino a zia Marta, Adriana Mosetti, freddamente studiò il suo problema. Il primo punto era che il bambino non doveva nascere. Il secondo punto era che, dopo il terribile scandalo, non era possibile fare niente in questo senso, aveva ragione suo padre. Ma lei questo non lo sopportava, la sua alterigia le impediva di fare la parte della domestica sedotta e abbandonata. Piuttosto morire. Ecco, morire. Naturalmente poteva prendere facilmente dei sonniferi, e tutto era fatto. Ma sarebbe stato un altro scandalo, e la sua famiglia era già abbastanza segnata in nero per dare altro scandalo. Si poteva però morire come se invece fosse una disgrazia. I titoli dei giornali che parlavano di lei, le sue fotografie sui giornali la ossessionavano, di notte non riusciva a dormire, si sentiva una donna finita, tutto finito, veramente, per uno stupido incontro al mare, in un momento stupido. E la prima cosa che pensò, naturalmente, fu di fingere una disgrazia stradale. Si metteva al volante dell’auto di zia Marta e andava a sfracellarsi contro qualche cosa, un muro, un platano, o cadeva da un ponte. Così era finita, e nello stesso tempo non sarebbe sembrato un suicidio, e quindi un nuovo scandalo. Ma morire è difficile, a ventidue anni. Per diverse mattine uscì con l’auto di zia Marta, e andò fuori porta cercando di trovare il coraggio di uccidersi in quelle meravigliose giornate del settembre romano, ma non lo ebbe mai. E, quando capì che non lo avrebbe avuto mai, pensò che restava solo una cosa. Non doveva nascere. Proprio lo stesso giorno in cui pensò quella cosa, sua zia Marta le disse che una signora, la dottoressa Atrizi, la desiderava al telefono. «Sì, pronto?» disse lei al ricevitore. «Mi scusi, signorina, lei non mi conosce, sono Laura Atrizi, sono specialista in ginecologia e ostetricia, desideravo vederla e parlarle, se possibile, ho letto sui giornali...» Al primo istante non capì. Al secondo ebbe voglia di troncare la comunicazione, ma al terzo istante decise di ascoltare. «Dica, dica pure», disse. «Per telefono è meglio di no. Potremmo vederci nel mio studio, per esempio, è qui in via Tomacelli, vicino a dove abita lei», disse la voce, dolce, giovanile eppure un poco severa. La disperazione porta ad atti disperati. Voleva sapere perché una dottoressa in ginecologia s’interessasse lei. «Va bene», disse, «quando?» «Se le è possibile subito.» Ancora la tentazione di togliere la comunicazione. Poi, pensando a quello che aveva deciso di fare, disse: «Va bene. Vengo subito». Si fece dare l’indirizzo esatto e uscì, andò a piedi. Sul portone trovò una ragazza bionda, con gli occhiali, vestita in un severo tailleur. «Sono la dottoressa Atrizi.» Lei non le dette la mano, non disse «piacere», non sorrise, le fece solo intendere con lo sguardo che aveva udito. Salirono in silenzio al terzo piano, era una delle più vecchie case, e delle più brutte, di via Tomacelli, senza ascensore, sporca, maleodorante, ed era curioso che una laureata in ginecologia avesse lo studio in una casa simile, ma voleva andare fino in fondo, le persone altere non troncano mai una cosa a metà. E al terzo piano un uomo massiccio, dalla barba violacea anche se appena rasa, e dagli occhi piccoli affossati negli zigomi prominenti, come quelli di un calmucco, aprì la porta appena lei suonò il campanello, come se fosse lì dietro ad aspettare. «Mio marito», disse la dottoressa presentandolo. Lei lo guardò appena, non strinse la mano tesa di lui, tanto meno disse piacere, tanto meno sorrise. Che una dottoressa avesse un marito che, nella migliore delle ipotesi, rassomigliava a un robusto scaricatore di porto, era anche più curioso di tutto il resto. Nell’interno l’abitazione era più decente, anzi, abbastanza elegante, a parte il lieve profumo di cucina, di spazzatura e di gatti, ma era evidente che si trattava di un vecchio appartamentino ripristinato con un certo tono per trasformarlo in giovanottiera. Non aveva davvero nulla dello studio di una dottoressa. Lei sedette, rigida. Guardava oltre la ragazza bionda travestita da dottoressa, che stava in silenzio, dopo che era uscito il marito. «Io ho letto la sua storia sui giornali», disse poi la dottoressa. Si tolse gli occhiali che non le servivano, ed immediatamente assunse l’aspetto di una passeggiatrice, nonostante il rigido tailleur. La volgarità da suburra del viso, miracolosamente mascherata dagli occhiali, esplose d’un tratto appena se li tolse. Lei non rispose. «Io penso che lei voglia essere aiutata a uscire dalla delicata situazione in cui si trova», nonostante la volgarità della persona, il suo modo di parlare aveva un certo livello di civiltà: qualche cosa doveva avere studiato. «Un bambino, nel suo caso, nella sua posizione sociale, e per di più un bambino di cui lei non vuole rivelare il nome del padre, rappresenterebbe, oltre allo scandalo che già c’è stato, un umiliante peso per tutta la sua vita.» Lei non rispose. E allora la dottoressa continuò: «Non credo che, almeno qui in Italia, lei possa trovare medici disposti ad aiutarla, per qualsiasi somma. Lo scandalo è stato troppo grande. Un medico aiuterà piuttosto una povera impiegatina, magari gratuitamente, ma non lei, anche se lei desse dieci milioni. Non è vero?». Lei non rispose. Era vero, ma non glielo disse. Senza molto piacere di non aver ricevuto risposta, con molte rughine di dispetto agli angoli della bocca, la dottoressa riprese: «Per varie ragioni che non le spiego, mi trovo in una situazione molto difficile e ho bisogno di denaro, a qualunque costo e a qualunque rischio. Vede che sono sincera». Non lo era, ma non glielo disse, non disse nulla. «Io posso aiutarla, qui, subito, in meno di mezz’ora. Poi lei tornerà a casa e starà a letto un paio di giorni e non avrà più alcuna preoccupazione. Le chiedo una somma molto alta, lo riconosco, ma è quella di cui ho bisogno: cinque milioni. Pensi che metto in gioco tutta la mia carriera, come i medici di Milano che stavano per aiutarla. Se sono scoperta, per me è la fine. Ma non ci scopriranno. Lei fra mezz’ora sarà a casa, e non avrà più nessuna ansietà.» Lei non rispose. Pensava. Confusamente, pensò che tra mezz’ora sarebbe stato tutto finito. Ma poi si vide in quel miserabile appartamento per coppie squillo in cui, nonostante la classe di certi mobili, del lampadario, dei tendaggi, si sentiva odore di marciapiedi e di sfruttatori. E allora si sentì veramente umiliata. Quella era la vera umiliazione, girare per le cliniche equivoche, o andare in casa di donnacce travestite da dottoresse in ginecologia, girare per cercare di non avere il bambino, disposta a trattare con persone infime come quella che aveva davanti, o il di lei cosiddetto marito che certo stava alla porta ad origliare. Quello era degradante, avere un bambino, invece, non era degradante, anzi. D’improvviso pensò con ferrea decisione che avrebbe avuto il bambino: aveva ragione suo padre, averlo sarebbe stata la grande prova di orgoglio, di essere superiore a qualunque scandalo, più forti di ogni titolo di giornale. Poi la sua alterigia si sciolse un poco, perché nel decidere di averlo, sentì che tornava un poco felice, intenerita. Si alzò. «Mi spiace che lei si sia disturbata. Non desidero l’aiuto che lei mi propone.» Si diresse verso la porta, per uscire, ma la falsa dottoressa le si parò davanti. «Cinque milioni non sono troppi», disse, con una certa ansietà. «Nessuno l’aiuterà per meno.» Quella credeva che lei rinunciasse perché il prezzo era troppo alto. Come è difficile capirsi. La fissò e le disse: «Permette che esca?». Ma la falsa dottoressa non si mosse, il viso volgare s’involgarì ancora di più per la rabbia. «Perché è venuta qui, allora?» disse. «Lei ha capito benissimo perché le ho telefonato, ed è venuta. E ora va via. Perché?» Di fronte a quell’ignobile essere che le sbarrava la strada, lei guardò la maniglia della porta e disse, con voce bassa e insultante: «A parte il fatto che lei non ha nessuna laurea, in nessuna materia, mi vuol lasciare uscire o no?». La falsa dottoressa, non solo non la lasciò passare, ma mise una mano sulla porta. Disse a metà rabbiosa e a metà conciliante: «Io sono sincera, ha ragione lei, non sono laureata in niente, ho solo un diploma d’infermiera, ma sono stata per quattro anni l’aiuto di un ginecologo, qui di Roma, che ha fatto più angeli dell’angelificio universale, e ho imparato come lui. Può stare tranquilla, il mestiere lo so...». Quella era l’abiezione. Non era abietto avere un bambino, era abietto dover stare lì, davanti a quella abietta figura, e doverla ascoltare. Ripeté tranquilla e distante: «Mi vuol lasciare uscire, o no?». Doveva essere davvero abbastanza sincera. Disse: «No». Aprì la porta, disse: «Vieni, Giulio». Il cosiddetto marito che era davvero dietro la porta ad origliare, entrò, e richiuse nervoso la porta, e allora la falsa dottoressa gli disse: «Non vuole più. Hai sentito?». «Certo, che ho sentito», disse lui. Adriana Mosetti sentì che stava arrivando, o meglio scendendo, fino alla feccia. «Vorrei uscire», disse, con occhi di vetro fissi sui due. «Prima dobbiamo parlare», disse il cosiddetto marito. «Siediti.» A volte il tu è uno schiaffo. Lei sentiva avvicinarsi la feccia, non rispose, ma restò in piedi. «Tu puoi fidarti di Susi, non è laureata, ma ha sistemato tante ragazze che non immagini, è come una dottoressa, te lo dico io, devi aver fiducia, non è mai successo niente. Non aver paura.» Una Mosetti non risponde alla feccia, e lei non rispose, continuò a fissare la feccia, ma non negli occhi, sulla fronte, in mezzo alla fronte, ed è uno sguardo che infastidisce. E la feccia, infatti, si infastidì e le disse, ringhiando: «Ti ho detto di sederti». Lei non rispose e non sedette, e allora vide la mano dell’uomo, certo assai più larga e pesante della zampa di un orso, calare sul proprio viso e sentì il colpo del terribile schiaffo, e per un attimo fu buio, barcollò, poi riaprì gli occhi e udì la feccia che diceva: «E non gridare, se no ti spezzo». Lei non gridò e non aveva mai pensato di gridare. Com’è difficile che la gente inferiore capisca: lei non lo avrebbe mai degnato di un suo grido. Si sedette non per paura di un altro schiaffo, ma per ribrezzo del contatto fisico con quell’uomo. Non era il dolore della percossa, che la spaventava, era il sudaticcio della mano bestiale. Anche lui si sedette davanti a lei, la falsa dottoressa restò in piedi. «Senti», disse lui, «a noi non importa niente che tu voglia o non voglia il bambino. Se non lo vuoi, Susi ti serve subito. Se lo vuoi, te lo tieni e sono affari tuoi. Quello che c’importa è un’altra cosa. Noi siamo nei guai, abbiamo bisogno di cinque milioni per oggi, se no siamo finiti. È una settimana che penso al modo di trovarli. E il modo l’avevo trovato, mi sembrava un’idea buona, leggo la tua storia sul giornale, vengo a sapere che sei qui a Roma e penso: quella paga subito, anche più di cinque milioni. Tu adesso dici di no, che non ti occorre niente. Benissimo, come vuoi tu. Però i cinque milioni devono saltare fuori lo stesso. Tuo padre ha tanti soldi che può tappezzare Roma di biglietti da diecimila...» Naturalmente non gli rispose. Era lei che, volontariamente, era scivolata in quella fogna, e adesso doveva starci. «Perciò», continuò l’essere che aveva solo l’apparenza umana, «adesso tu telefoni a qualcuno dei ricchi che conosci, gli dici di trovare cinque milioni, in contanti, che noi li andiamo a prendere. E che non facciano i furbi se no tu sei una miliardaria morta.» L’uomo sorrise per la sua bravura. «Hai capito?» Ci fu tanto silenzio, davvero tanto, forse un minuto intero, una bella luce del sole settembrino romano entrava attraverso le finestre aperte, ma velate dalle belle tende giallastre: in fondo, a parte l’aria equivoca, non era una brutta sala, quella. Poi lui, Giulio, disse, con voce molto bassa che denotava il suo stato di furia: «Telefona subito a qualcuno e trova i soldi, fra due o tre ore non più tardi. Ti spiego poi io cosa devi dire per la consegna dei soldi. Non dirmi di no, perché sei peggio che morta». Lei capì che era la verità, che se non avesse ubbidito sarebbe stata peggio che morta, e allora disse anche lei la verità, per la prima volta parlò con la feccia. «No. Non telefono a nessuno e non avrete mai neppure una lira.» Stette rigida, in attesa di uno schiaffo, ma lo schiaffo non venne, l’uomo, anzi, le sorrise coi suoi piccoli occhi infossati nell’arco sopracciliare e negli zigomi. Era in fondo un sorriso sadico, non solo un sorriso di superiorità fisica, dell’uomo che si sente più forte della donna, ma soprattutto il sorriso dell’uomo che ha piacere di far soffrire una donna. «Conosco un sistema che ti farà parlare», disse lui alzandosi, «ti do tempo un paio di minuti, intanto che preparo, ma pensaci bene prima di dire di no, perché ti assicuro che non è bello.» Siccome l’uomo era davanti a lei, fu costretta a guardare quello che faceva. Fece delle cose veramente insolite. Sul tavolo dove era il telefono, vi era anche un grosso paralume. Lui strappò il filo elettrico dalla base del paralume con un gesto quasi garbato della sua manona, poi aprì i due fili a metà, in modo che non facessero contatto, per una ventina di centimetri di lunghezza dal cordone, infine, innestò la spina nella presa. Poi le si avvicinò. «Senti, io spero che tu pensi di telefonare e trovare subito i soldi per noi, ma se insisti a dire di no, ti spiego che cosa ti faccio. Questi sono i due fili del cordone elettrico, uno positivo e uno negativo, l’ho imparato da un film, te l’ho detto, e lo hanno fatto davvero. Ti metto un filo in un orecchio e l’altro nell’altro orecchio. Sono duecentoventi volts. Non muori, ma ti assicuro che è peggio che morire...» Lei lo ascoltò, degnandolo finalmente di fissarlo negli occhi, non certo per fargli un onore, ma solo per rendersi conto che si trattava di un sadico anormale, e non disse nulla. «Telefona», disse allora lui, «e trovaci i soldi.» «No», lei disse. «Pensaci ancora una volta», disse lui avvicinandosi coi fili. «Telefona.» «Non telefono», disse lei. Lui disse: «Tappale la bocca», alla falsa dottoressa. La dottoressa rivelò di essere veramente quello che era, forse un’aspirante nazista addetta alle torture, dal modo come in un attimo le mise una mano sulla bocca, e con l’altra la immobilizzò. «Telefona», disse ancora lui, «fa’ segno di sì, che telefoni, e non ti faccio niente.» Lei fece cenno di no. E allora sentì i due fili elettrici che si congiungevano alle sue orecchie, poi tutto si spense, le sembrò di essere sbriciolata, cercò di urlare, ma non poté, cercò di divincolarsi, ma loro la tenevano, per qualche secondo perse anche coscienza, poi rivide il sole del settembre romano attraverso le tende giallastre e sentì la voce dell’uomo. «Telefona, se no ricomincio da capo...» Guardò il telefono, tremante non di paura, ma soltanto perché il suo fisico risentiva della lunga scossa elettrica, la testa le bruciava, ma riusciva ancora a pensare lucidamente, abbastanza lucidamente da sapere che avrebbe detto ancora di no, nessuno poteva piegarla, non esisteva nulla al mondo che potesse piegarla ma un attimo dopo pensò che quella tortura poteva uccidere, non solo lei, ma anche il suo bambino. E lei ora voleva il bambino: era l’unica cosa che volesse, per redimersi da tutte quelle brutture in cui era scivolata, solo per illusione, insipienza, stupidità. «Sì, telefono», disse. Voleva il bambino. La belva femmina le formò il numero, e la belva maschio le disse: «Non fare scherzi, perché è peggio per te». Non aveva nessuna voglia di fare scherzi. «Pronto, zia Marta?» disse al ricevitore. «Senti, non ti spaventare...» Il piccolo Saverio nacque nella clinica della Madonnina a Milano. Vi erano giornalisti e fotografi. A un giornalista che ebbe la finezza, si fa per dire, di domandare: «Perché lei non vuole dire il cognome del padre del bambino?» lei dal letto, col piccolo che dormiva attaccato al suo seno, disse, altera, alterissima: «Perché non lo so neppure io». 52 · La fuga inutile «Signor direttore, non ne posso più.» Era un giovane alto, magro, un’aria piuttosto insincera nel viso, ma non antipatica. «Voglio uscire di qui, voglio uscire di qui», quasi piangeva. Il giovane direttore del carcere lo guardò quasi con compassione. «Certo che puoi uscire di qui, se vuoi, sono cinque mesi che hai finito di scontare la pena, e sei rimasto in carcere di tua volontà, perché lo sai, appena metti il muso fuori di qui, ti fanno la pelle.» Il ragazzo annuì, e il direttore continuò: «Quella gente lì lo sai che cosa pensa delle spie. Se tu esci, un giorno o due dopo ti ritroviamo appeso a qualche alberone nella città di Torino, con un tappo in bocca, tanto per far capire a tutti che sei uno spione». «Ma io non posso passare tutta la vita in carcere», disse, tenendosi le dita intrecciate. «Lo so», disse il direttore, lo comprendeva benissimo. Guardò l’orologio che aveva al polso, «ma qui sei vivo, e fuori sei morto.» Era duro dirlo, ma era la verità. Rifletté chiudendo un poco gli occhi. «Forse posso aiutarti. Nel Vercellese, spersa fra le risaie, c’è una casa di lavoro per ex carcerati. La casa di lavoro non è come il carcere, gli internati godono di una certa libertà, una volta alla settimana hanno il permesso di andare in paese accompagnati da un agente che gli dà un’occhiata. Là sei protetto e hai vita migliore.» «Io voglio uscire», disse il ragazzo. Teneva i gomiti appoggiati alle ginocchia, il viso tra le mani. «Se vuoi, esci, telefono alle guardie al cancello e loro ti lasceranno uscire facendoti perfino un inchino. Ma ricordati, Giovannuzzo, oltre al fatto che ti accoppano, c’è un’altra questione che mi preoccupa. Tu esci senza una lira, e senza un posto dove andare. Allora cosa fai? Per primo rubi una macchina, poi cominci, armato di un cric, ad assaltare qualche distributore di benzina isolato, ti fai fare il pieno, gli strappi la borsa e lo stendi con un colpo di cric. Poi rubi un’altra macchina, altro distributore, e così via, finché non ti sei fatto un po’ di soldi. Alla fine, però, o arrivano prima i tuoi amici e compaesani e ti stendono, sempre con tappo in bocca, oppure arriviamo prima noi e tu torni qui dentro a farti tre o quattro anni. Non farlo, non ti conviene.» «Non lo farò, signor direttore», disse il ragazzo alzando il viso. «Io ho un’amica, qui a Torino, e lei potrà aiutarmi, se lo vuole.» «E cosa dovrei fare?» «Io devo mettermi in contatto con lei. Lei ha soldi e mi vuole molto bene. Mi aiuterebbe a rifarmi un’altra vita. Le voglio molto bene anch’io.» «E allora le telefoni. Ti rilascio il permesso di telefonarle quando e quanto vuoi.» «Non si può, signor direttore. Deve essere ancora sorvegliata dai miei compaesani, sono capaci di ammazzarla di botte se sanno che le ho telefonato e perché vorranno sapere che cosa le ho detto e che cosa lei ha risposto. E peggio ancora se le scrivo una lettera, credo che tutte le lettere che lei riceve, con una compiacente portinaia, siano lette prima da loro, che da lei.» «Va’ avanti perché non ho capito bene.» «Signor direttore, voi mandate due agenti da lei e la fate arrestare. La portate qui, da me. Lei ed io parliamo, io le spiego tutto, le domando se vuole aiutarmi, lei mi aiuterà, ne sono certo.» Il direttore si coprì gli occhi con una mano, poi se la tolse, la posò sulla scrivania. «Giovannuzzo, tu sei peggio che pazzo, tu stai delirando. Prima di tutto io non posso far arrestare nessuno. Io sono un dirigente carcerario, non un commissario di pubblica sicurezza. E poi ci vuole un motivo per arrestare una persona.» «Sì, lo so, signor direttore, io pensavo di farla arrestare per atti osceni in luogo pubblico.» «Come: atti osceni in luogo pubblico?». Il ragazzo non rispose, ma lo guardò eloquentemente. «Ah, allora tu vuoi dire che questa ragazza tua amica e che guadagna bene, è una donna che guadagna bene con quel mestiere?» Il ragazzo, ancora con gli occhi, disse di sì. «Bene, così se tu esci con lei e ti fai aiutare da lei, noi ti dobbiamo subito rimettere dentro per sfruttamento.» «No, con me non la farà più quella vita», disse accalorato il ragazzo. «Io le ho detto sempre di smetterla, ma sa com’è, quando una donna comincia quella vita, è difficile staccarsi. Ma se io parlo con Adelina e Adelina mi aiuta a tirarmi fuori da qui, io aiuto lei a tirarsi fuori da quella vita. Lavoreremo, diventeremo delle altre persone. Glielo prometto, glielo prometto, signor direttore», e finalmente esplose a piangere. Il direttore del carcere aveva conosciuto molti delinquenti nella sua vita, la maggior parte incorreggibili, ma questo gli sembrava che non fosse un delinquente, era stato incanaglito dai peggiori esemplari di delinquenza, corrotto, compromesso. Ma dentro era rimasto ancora sano. «Vattene», disse al ragazzo, «torna al tuo ufficietto e alla tua televisione. Questi sono sogni da visionario.» Il ragazzo si alzò, livido. «Va bene, signor direttore, ma io mi ammazzo. Potete farmi sorvegliare quanto volete, ma io mi ammazzo.» Il direttore fermò il ragazzo che era già sulla porta. «Aspetta a fare karakiri. Dammi tempo qualche giorno.» Forse mentiva, tanto per tenerlo in vita. Due giorni dopo tre agenti entrarono poco dopo l’alba in un elegante palazzo. Mostrarono la tesserina al custode che aveva appena aperto il portone: «Polizia, cerchiamo Adelina Macherio, a che piano abita?». «Al quinto», disse il vecchio spaventato dall’irruzione. Al quinto piano suonarono e risuonarono il campanello, e finalmente Adelina Macherio aprì la porta. Era in vestaglia, era una bella donna, forse un po’ sciupata. «Polizia.» Entrarono tutti e tre, come una folata. «Ma perché, che ho fatto? Io sono in regola», disse lei. «Si sieda su quel divano insieme con me, dobbiamo parlare», disse quello che era il capo. Adelina ubbidì. «Vuole vedere il suo compaesano Giovanni Daddoro, che è ancora in carcere?» Il viso di lei fu come se si disfacesse. Poi lei disse: «Oh, sì, se avessi potuto sarei venuta tutte le settimane, ma sono sorvegliata, se sanno che ho cercato di parlare con lui mi ammazzano.» Il capo poliziotto disse: «Lo sappiamo. Questo è un arresto finto per permetterle di rivedere Giovanni senza che lei abbia danno. Coloro che la sorvegliano penseranno che noi l’abbiamo arrestata. Invece noi la portiamo in carcere a parlare con Giovanni». «Questo è un biglietto di Giovanni per lei.» Il poliziotto glielo porse. Lei pianse su quella scrittura che ben conosceva. Poi si riprese. «Ditemi che cosa devo fare», disse decisamente, con sottile pronunzia siciliana. «Prima di tutto, appena usciamo di qui, lei si mette a urlare come una disperata: “Io non ho fatto niente!”, lo urla in ascensore. “Non ho fatto niente, non voglio andare in galera, brutti mascalzoni!” Deve essere una scenata clamorosa, finché non l’avremo caricata sulla nostra auto. Bisogna far credere a tutti che la polizia l’ha arrestata.» Lei annuì, con fervore. «Poi lei deve raccogliere tutti gli oggetti di valore che ha, e il libretto degli assegni, e il denaro liquido, e darli a me. Glieli restituirò appena lei avrà parlato con Giovanni.» Ancora una volta lei annuì con fervore. «Vado a prenderli»,. disse alzandosi. Ritornò dopo due minuti con una valigia a sacca piena di oro, braccialetti, collane, orologi, ciondoli d’ogni genere, perfino un cinturino, poi vi erano due libretti di assegni. Il poliziotto chiamò l’altro che era in anticamera. «Berto, vieni qui: dobbiamo metterci tutta questa roba in tasca.» Sarebbe stato pericoloso uscire e farsi vedere con quella vistosa borsa da qualche eventuale compaesano rimasto a sorvegliare. Non era certo il tesoro della regina, ma vi erano diversi milioni in quelle ciondolerie. Disse il poliziotto capo: «Ma tutta questa roba, come mai? Gli sfruttatori lasciano a voialtre appena i soldi per il cappuccino e le sigarette». «Io faccio un altro lavoro. Io devo compromettere e corrompere dei grossi personaggi che interessano loro, cercare di avere delle notizie. E poi questa roba per loro sono quattro soldi.» «Lei ha una macchina, vero? Mi dia le chiavi.» Lei andò a prendere la borsetta, gli dette le chiavi. «Adesso si vesta e cominciamo bene la recita», disse il capo poliziotto. Adelina la recitò bene, molto bene. Stretta fra i due agenti che la tenevano, urlò ai poliziotti tutti gli insulti possibili e immaginabili, si dibatté come una posseduta dal demonio, per metterla nell’Alfa col lampeggiante azzurro dovette intervenire anche il terzo poliziotto, accorreva gente da ogni parte a vedere e a sentire le colorite contumelie in siciliano che lei urlava. Le carceri. Un agente guidò per un buio corridoio Adelina, camminandole a fianco. «Entri, è qui.» Aprì una porta. Era un piccolo ufficio, con un tavolino che faceva da scrivania, qualche sedia, uno schedario di metallo. In fondo, in piedi, c’era un agente, e in piedi, vicino al tavolo, c’era Giovannuzzo. Dietro il tavolo c’era un giovane signore, ma dall’aria molto importante, era il direttore del carcere. Per lunghi secondi i due siciliani rimasero a guardarsi, poi lei con un urlo gli si buttò addosso. Poi si accarezzarono il viso l’uno con l’altra, si parlavano bisbigliando alle orecchie. Poi i due si sciolsero. «Vieni qui, Adelina, sediamoci, dobbiamo parlare.» Lei sedette ubbidiente. «Prima di tutto non parlare in dialetto, tu devi parlare in italiano, per farti capire da loro.» «Parlerò in italiano», disse lei. «Adesso io devo spiegarti delle cose. Se queste cose ti piacciono, tu mi dici sì, altrimenti no.» «Aspetta a dirlo.» Lui le prese una mano. «Te la senti di fuggire con me da quella gente sporca? Pensaci bene, perché sarà una vita pericolosa, dovremo sempre fuggire e presto o tardi faremo una brutta fine.» «Non ho bisogno di pensarci», lei scosse il capo con foga. «Vengo con te.» «Ci pensi ancora un poco, signorina», disse il direttore del carcere. «Non si lasci trascinare dall’emozione del momento.» «Dottore, non è un momento, sono otto anni, otto anni che voglio stare con lui, e adesso finalmente ci sto.» «Non gridare così, Adelina», disse lui. «Prima però è bene che ti dica un’altra cosa: tu devi raccontare al direttore del carcere tutto quello che sai su quella gente, quello che fanno, come si chiamano, dove si trovano. La polizia ci aiuta e ci protegge a stare insieme, ma vuole il tuo aiuto. Tu lo sai che cosa significa questo?» «Sì, lo so. Significa che un giorno mi trovano morta con un tappo in bocca. Ma io dico lo stesso tutto quello che so, non me ne importa!» «Non gridare così, Adelina.» «Scusi, signorina, ma se era così decisa a denunciarli, perché non si è presentata al primo commissariato a dire tutto?» disse il direttore. «Ma perché ero peggio che in galera, in casa avevo quasi sempre uno che riceveva lui le telefonate, mi leggeva le poche lettere che ricevevo da mia madre e leggeva anche quelle che io scrivevo a mia madre e poi le imbucava lui. E fuori di casa, c’erano sempre degli altri con me. Quando andavo dal parrucchiere venivano con me, venivano con me nei negozi, al bar, al cinema. Quei farabutti mi tenevano per le loro porcherie e perché speravano che da un momento all’altro Giovannuzzo perdesse la testa e venisse a trovarmi. Lo avrebbero fatto secco in un istante.» Giovannuzzo le disse: «Allora, se hai deciso, hai deciso». «Chiamami lo stenografo», disse il direttore delle carceri all’agente in divisa. «Grazie, signorina», disse il direttore del carcere, «adesso ascoltate qualche consiglio. Voi avete bisogno di soldi e di prudenza. I soldi li avete. Lei signorina mi firmi un assegno, svuotando tutto il suo conto corrente e lo intesterà a un mio agente che andrà a incassarlo subito, perché voi avete bisogno di denaro liquido. Per l’oro, appena siete un po’ lontano da qui, mettiamo a Bologna, mettetelo in una cassetta di sicurezza. Non vorrei che dopo avervi ammazzato, vi rubassero anche tutto. Per i primi tempi vi consiglio di non fermarvi in un posto più di un giorno.» Un’ora dopo la Citroën nera uscì dal carcere. Giovannuzzo guidava, Adelina gli stava a fianco. Nella piazzetta, nascosta dagli alberi, c’era una Opel grigio scuro. Dentro c’erano due uomini. Uno guidava, l’altro gli stava a fianco. Sul sedile di dietro, coperti da un elegante scialle femminile, c’erano due corti mitra. «Eccoli gli sposini», disse quello che non guidava, in un fondo siciliano. «Adesso ho capito tutto. Va’ dietro con giudizio, figliolo.» «Ci hanno preso per poppanti», continuò. «L’Adelina si è fatta aiutare dalla polizia per rivedere Giovannuzzo, e avrà cantato tutto quello che sa, così adesso li allupariamo tutti e due in una volta sola.» L’inseguimento della Citroën continuò quasi due ore, poi la Citroën si fermava davanti a una piccola trattoria. «Lasciali entrare. Due minuti dopo entriamo noi», disse l’anziano. Dalla Citroën Giovannuzzo e Adelina discesero, ed entrarono nella trattoria. Sorridevano. Un minuto di attesa, due minuti. «Entro io per primo, tu tieni a bada gli altri.» L’anziano si precipitò come un marine all’attacco ed entrò nella trattoria. «Tutti a terra se no siete morti.» Non c’era quasi nessuno. Alle undici i ristoranti non lavorano ancora. C’era il padrone, due camerieri e una ragazza che si mise a tremare senza avere la forza di urlare. E a un piccolo tavolo d’angolo c’erano i due spioni. I due mitra più che ucciderli, li distrussero. L’anziano si avvicinò a guardare la sua opera, poi vide accanto al tavolo dei due una vecchia valigia, l’aveva prestata il direttore del carcere perché Adelina vi nascondesse i soldi e l’oro. L’anziano col mitra in mano non sapeva che cosa contenesse, ma era un curioso, e la prese. L’aprì solo quando fu in auto e si mise a ridere. «Grazie, Adelina.» 53 · Redimere un tigre Come mai un evaso dal riformatorio potesse trovarsi lì, in smoking, biondino, il viso magro e avido, ballando poco perché nelle sale dove fino a sette giorni prima ciondolava fingendo di lavorare non insegnavano esattamente le danze, ma premendo forte il pedale con le ragazze, e ne aveva già imbesuite tre o quattro, esclusa lei Matilde, che lo guardava come sentendo l’odore di selvatico, di ferino, e l’unica volta che aveva ballato con lui aveva notato, sotto il perfetto travestimento di damerino, il collo tozzo, corto, volgare, il polso grossolano e quegli zigomi alti, sporgenti, quasi mongoloidi, tutti segni di bassa nascita che nessuna camicia col davantino ricamato, nessuno smoking, nessun parrucchiere di lusso potevano nascondere, e questo le era bastato per evitare anche di guardarlo e girare per la sala con gli altri come se lui non vi fosse, cosa che, benché così giovane, le riusciva benissimo, perché era ereditaria e i suoi ascendenti si erano comportati nella loro vita ignorando la maggior parte della gente che non fosse come loro pensavano dovessero essere le persone di qualità. Il come mai lo seppe quando suo fratello la riaccompagnò a casa. «Quel cretino», disse suo fratello, guidando. «Chi?» Lei pensava ai libri di filosofia che aveva sul comodino, ma quella notte non gliel’avrebbe fatta a ripassare niente, alla festa si era annoiata e la noia la stancava più di tutto; le dispiaceva, c’era Spinoza che la stordiva e l’affascinava, la stordiva per tutto quel che non ne comprendeva, ed era molto, l’affascinava per quel poco che afferrava e che le sembrava gigantesco. «Il Luchino, e tu, prima di andare un’altra volta in un posto dove c’è lui, me lo dici perché ti lego alla gamba del letto.» «Ma che ha fatto?» e non aveva interesse di saperlo, tanto nel loro ambiente succedevano sempre le stesse cose, e già le conoscevano tutte. «Hai visto quel biondino senza collo», ah, l’aveva notato anche lui, «è suo amico, anzi fa apposta a dire che è suo amico, per fare lo scherzo, ma questo è uno scherzo che non mi va.» «Perché?» Erano arrivati davanti allo scassato portone della dimora avita e a infilare l’auto dentro c’era da piangere, così che al fratello gli venne rabbia anche per quello, oltre che per Luchino cretino, e restò in macchina per calmarsi e anche per spiegarglielo bene a lei, alla sorella, il perché. «Perché quel signorino che si è portato appresso alla festa è uno scappato dal riformatorio poco tempo fa, è il figlio di un loro contadino, e lui si diverte a proteggerlo, non per proteggerlo, ma per fare lo stupido, come ad andare in giro con una tigre al guinzaglio. Lo tiene nascosto in casa di un pittore, il Vodino, figurati, e quando vogliono ridere lo rivestono e lo portano nelle nostre case, senza dire nulla di chi è e di chi non è; poi una volta o l’altra la polizia lo piglia, e il giovanotto spiffera che è stato in casa Fortani, in casa Duzzi, in casa Di Pontesi, in casa Mori Caldari e figurati le risate dei giornali e la faccia verde dei nostri che hanno aperto la porta al campione.» Lei fece per scendere. «Non ci capisco niente, ti spieghi in un modo.» «Adesso ti faccio i disegnini coi fumetti.» Il fratello non riusciva a calmarsi. «Questa sera è successo che tu hai ballato con un biondino che è stato chiuso in riformatorio per violenza carnale, e quando sono arrivato a prenderti ormai era fatta, e così è successo alle altre ragazze, per colpa di quel cretino del Luchino.» Allora lei capì, qualche cosa le frullò in gola, forse un singhiozzo isterico o il principio soffocato di una risata nervosa, e risentì il braccio di lui che la teneva ballando, l’ossuta mano, e gli occhi celesti, ridenti – l’espressione di volgare furbizia che l’aveva infastidita – e quel ricordo provocava quel frullo in gola ora che sapeva. Violenza carnale era un termine, una faccenda di cui aveva letto anche troppe volte nei romanzi, uh, ne erano pieni, nei libri di psicanalisi, nelle cronache dei giornali, ma era la prima volta che era stata tra le braccia, ballando, dell’autore di una simile violenza. «Ormai è successo», disse, ma non controllava ancora bene la sua voce, aveva in fondo poco più di diciott’anni. «Basta che non succeda più.» «Vorrei vedere che succedesse ancora.» Il fratello si decise a scendere, aprire il portone e iniziare la funambolesca manovra per entrare nella corte dove un tempo neppure troppo lontano sostavano le carrozze a cavallo della loro nonna. E per le scale le disse: «Se domani vedo Luchino al golf lo sistemo, o sbatte via il suo avanzo di riformatorio, o glielo denunzio io alla polizia che lo cerca». Lei lo guardò mentre egli apriva cauto la porta al primo piano. Non capiva ancora bene, ma forse era stanca e il ricordo del braccio di quel ragazzo intorno alla vita le confondeva i pensieri. «E non dire niente ai nostri bambini», intendeva i genitori, «se no viene l’infarto al piccolo», intendeva papà, «e alla sua amichetta», intendeva la mamma. Lei non rispose neppure, sapeva bene quello che doveva dire o no. Quel braccio, pur senza stringere, aveva come lasciato il segno sulle sue spalle, un segno che non riusciva a levarsi, si addormentò tardi, col libro di Spinoza in mano, ma senza riuscire a capire una riga. Alle sette era già sotto la doccia, quasi fredda, ma neppure questo le tolse quel segno, che però scomparve, d’improvviso, appena ebbe bussato alla porta della piccola aula dove il professor Goffredi l’attendeva. Ancora prima di dirle «avanti», il professore, dal tocco leggero, fremente, sapeva che era lei e guardò verso la porta, come vedesse che al di là di quell’uscio vi era Sogno Insipienza e Amore, così la chiamava dentro di sé, e quando la ebbe davanti la guardò appena, intento solo a togliere dal cassetto della scrivania la squallida esercitazione, inserita però nella splendida cartella di pelle con le iniziali stampate del nome di lei M d M, Matilde del Monte, e pensando solo a come risolvere la questione col numero minimo di parole, non tanto per evitare una fatica – ma anche per questo – ma per la convinzione, l’istinto, anzi, che anche il minimo numero di parole sarebbe stato troppo, e inutile. Non serviva a nulla, a quella ragazza, scrivere come aveva scritto, una puerile esercitazione su Fichte, oltretutto risibile in quell’epoca di totocalcio – e non serviva a nulla che lui l’avesse letta e corretta, se non a dare una parvenza di giustificazione al suo stipendio, e anche alla sua giornata. «Si accomodi.» Sogno Insipiezza e Amore sedette e adesso, sì, la sensazione di quel braccio alle spalle era cancellata, come per sempre, come tutto, o quasi, si cancellava le rarissime volte che si trovava sola col professore, e il volto di lui, violentemente virile e cerebrale nello stesso tempo, per la linea magra e per i capelli rasati. Oh, Matì, Matì, Matì, se ne era accorta ancora prima che glielo dicesse la Soivani, che quello lì le dava la sbronza sentimentale, ma lei sapeva controllarsi, capiva benissimo la banalità della cosa, la storia dell’allieva che s’innamora del professore, come della servetta che trepida per il giovane padrone, era ormai una scena comica, da film alla Ridolini, e lei non faceva scene comiche, ma ciò non toglieva che quando era sola con lui per qualche esercitazione, in quella piccola aula prima che cominciassero le lezioni, dimenticasse tutto, o quasi, e volesse, desiderasse, implorasse mentalmente, che quella loro solitudine durasse a lungo, il più a lungo possibile. Ma fu breve anche quel mattino. «Guardi, ho trovato qui il termine “accidia”», disse il professore, il profumo delicato, asprino di lei, arrivava fino a lui, gli rammentò, aveva la memoria olfattiva, una mattina, un negozio di fiori in cui lui era entrato per comprare fiori a una ragazza – aveva anche la memoria logica e ricordava benissimo quale, nome cognome, e indirizzo, ma ormai certamente non abitava più lì – ma il ricordo gli divenne subito fastidioso, per tutto quell’affannarsi inutile, di quell’epoca, con mazzi di fiori, telefonate, appuntamenti, come uno che per riempire un bicchiere d’acqua prendesse l’aereo per arrivare alle cascate del Niagara. «Lei usa questo termine “accidia” dimostrando di non avere la più remota idea del suo significato.» Quasi senza guardarla, sentì che Sogno Insipienza e Amore arrossiva, e non capiva a che servisse farla arrossire, ma forse non serviva a nulla neppure non farla arrossire. «Mi spiego, signorina Del Monte. Le parole prendono il significato che uno vuole. Il significato che vuole il costume, l’epoca, e perfino il singolo individuo. Accidia, per la gente distratta, significa pigrizia, uno non vuole sollevare una cassa da cento chili, allora è accidioso. Ma noi non siamo gente distratta. Lei paga e spende, voglio dire i suoi genitori, e io vengo pagato, appunto per evitare la distrazione. Credo che non le sarebbe stato difficile consultare un qualsiasi dizionario etimologico per vedere che accidia viene dalla parola greca akedìa, e che a è privativo, come suppongo ricordi, e kedòs vuol dire “cura”, “dolore”, e quindi, letteralmente, “accidia” significa incuria, indolenza, e ha ben poco a che vedere con la pigrizia fisica se non in qualche manifestazione comune a tutte e due le qualità. Non le sarebbe dovuto sfuggire, inoltre, che l’accidia è stata considerata un peccato capitale, appunto perché è un difetto dell’anima, un vizio dell’intelletto, e non un fatto fisico come la fatica che hanno i pigri ad alzarsi al mattino. Non si può mandare all’inferno un peccatore se il suo peccato è solo quello di aver voglia di dormire di più. Pigra è la sua amica Soivani, e lo deduco dal modo come si siede al tavolo, qui davanti a me, e sembra sempre reduce, al momento in cui siede, da una marcia di cento chilometri, e invece è stata seduta in poltrona fino a due minuti prima. Accidioso invece sono io, benché mi alzi al mattino presto e mi occupi tutto il giorno di voi, per la semplice ragione che lo faccio semplicemente perché qualunque altra cosa volessi fare o dovessi, farei lo stesso sforzo, proverei la stessa mancanza di convinzione, sentirei la stessa indolenza.» Sapeva che lei lo avrebbe interrotto e tacque apposta. «Oh, no, professore, lei insegna meglio di ogni altro», disse infatti lei, quasi scandalizzata. «Lei sta scherzando.» «E questo che cosa prova?» cominciava già ad essere stanco, moralmente, di quella vana conversazione. «Il fatto che io insegni meglio di ogni altro non significa che io non potrei insegnare ancora meglio se non fossi accidioso. Comunque, le ripeto che il significato delle parole è vagamente fittizio e ciascuno può dare la sua interpretazione di qualunque parola. Lo Scartazzini, nel suo commento alla Divina Commedia, nega che nel fiume Stige, nel limo paludoso, Canto Settimo, verso 106 e seguenti, siano immersi gli accidiosi, ma soltanto “color cui vinse l’ira”, cioè gli iracondi, e afferma che caso mai gli accidiosi hanno il loro posto nel Vestibolo, Canto Terzo, verso 34 e seguenti, dove invece sono gli ignavi “che visser senza infamia e senza lode” e l’ignavia non è né la pigrizia, né l’accidia, ma se lo Scartazzini può dare una sua interpretazione dell’accidia, non vedo perché non possa darla lei, o io, o chiunque, quindi lei è ampiamente scusata dell’aver usato il termine accidia nel senso di pigrizia.» «Vuol dire che il significato delle parole è relativo?» lei chiese, con un atto di coraggio, senza però saper bene, neppure lei, quello che domandava, affascinata solo dalla sua presenza, dalla sua tagliente intelligenza, da quel modo di stare curvo sul tavolo come un vecchio impiegato, e invece lo sguardo diceva bene che era tutt’altro. «Io non dico nulla, faccio solo delle futili constatazioni.» Adesso veramente era infastidito, inuggito. «Sulla sua esercitazione su Fichte mi sono fermato su questa parola perché è la prima che mi è caduta sott’occhio, ho letto il resto, è diligente, ma non credo che questi siano i suoi filosofi.» Le porse, chiusa, la cartella di pelle. «Fichte e la Iità, sono troppo astratti...» «Ma è proprio quanto più sono astratti, tanto più mi piacciono, li sento», lei disse appassionata. «Spinoza, volevo parlarle di Spinoza...» Egli si alzò. «Un’altra volta», disse cortese ma svogliato e per liberarsene meglio le fece una vaga promessa: «Forse lunedì». Ma al momento in cui la vide uscire dalla saletta, quel giovane passo reso così esitante dalla soggezione – e attrazione, lo sapeva benissimo – che provava per lui, quel lungo collo botticelliano, gli sembrò di aver voglia di correrle appresso e fermarla, no, rimanga qui, parliamo di Spinoza, ma capì che non era una vera voglia, e neppure una velleità; certo avrebbe potuto anche sposarla, e come no? Era scapolo, la differenza di età contava poco, ma alzò subito le spalle a quella fantasia; era tanto più semplice telefonare ogni tanto a Giuditta, anche se Giuditta non era così giovane, piuttosto che mettere in piedi una montagna come un fidanzamento e un matrimonio con una ragazzina, e infatti la sera telefonò a Giuditta, la portò a cena nella solita trattoria – cambiarla era faticoso e inutile, erano quasi tutte uguali – poi a casa di lei, dalla quale uscì poco dopo le undici, e andò a piedi a casa sua nella fredda sera di primavera scansando le nottivaghe che gli rivolgevano complimenti o gli sorridevano come affascinate, e per contrasto rivedendo lei, Matilde, la purissima, provando come la mancanza di lei, ma una sensazione fuggente, vaga, senza consistenza, forse, pensò, come tutte le sensazioni del genere che provava. Le piaceva attraversare i giardini pubblici, che altrimenti evitava, quando pioveva, e forte, così erano deserti, tutti suoi, e avevano un’aria da stampa antica, o da film intellettuale, e avvolta nel corto impermeabile col cappuccio, le mani in tasca, ripararsi ogni tanto sotto qualcuna di quelle gigantesche piante, e aspirare l’odore di terra bagnata, più forte in primavera, e poi correre negli spiazzi scoperti, fino alla prossima pianta, e guardare il laghetto tempestato dalla grossa pioggia e le panchine, vuote, lucide e poi, quando arrivava a casa, ridere per l’angoscia dell’amichetta del piccolo – cioè la mamma – che temeva una polmonite, e per il muso della panzer cameriera, cioè quella addetta ai lavori più pesanti, che guardava le pozze di acqua che lei formava sul parquet al suo passaggio. Le piaceva, ma quella mattina sarebbe stato meglio che non avesse attraversato i giardini perché il biondino dagli zigomi mongoloidi, in un corto impermeabile bianco prestato evidentemente da qualcuno dei suoi ricchi protettori, mentre lei era ferma sotto una pianta a guardare una vecchia foglia gialla navigare procellosamente nelle acque del laghetto in minuscola tempesta, le apparve d’improvviso dalla svolta del piccolo viale e si riparò anche lui sotto la grossa pianta, guardandola, sorridendole, ma appena appena, coi suoi occhi celesti, senza dirle nulla per qualche istante, e infine mormorando: «Mi riconosce?». La sua, di lei, Matilde, non era l’età delle menzogne abili e improvvise, forse un no, non la riconosco, l’avrebbe salvata, e disse invece, spontanea: «Sì», ma forse non soltanto perché non sapeva mentire, ma per una nascente e ancora vaga atterrita attrazione. Il biondino divenne serio, si appiattì contro la grossa pianta per prendere meno pioggia. «E sa chi sono», disse. «Il bruto. Il criminale. Il lebbroso. L’ho capito da come mi ha guardato.» Lei non rispose, e questo voleva dire che sapeva chi era, soltanto non riusciva a comprendere come mai poteva restare così calma, naturale, vicino a un uomo come quello. «Mi hanno denunziato», e il suo viso si tirò, la pelle del viso, cioè, per l’ira repressa, così che gli zigomi sembrarono più sporgenti. «I suoi amici, la sua gente-bene, perché si erano stufati dell’avventura. Prima mi portano in giro, mi fanno un sacco di promesse, mi tengono nascosto, “sta’ quieto che ti sistemiamo noi, ti abbiamo preso l’avvocato, non dovrai ritornare al riformatorio, garantiamo noi per te”, ma poi lo scherzo comincia a pesare, hanno paura di sporcarsi troppo, e avvertono la polizia. Ma io non sono mica nato ieri, me l’aspettavo, vi conosco, voi, che gente siete, e ho sentito l’odore dei beccamorti che venivano a prendermi che erano appena entrati nel bar e io ero in una stanzetta sopra. Hai voglia a far sorvegliare tutte le uscite del casamento, io me ne sono andato per i tetti, come un uccellino, cara lei, perché Duilio, nessuno lo becca, piuttosto...» Il torvo, quasi sguaiato modo di parlare di lui, e quell’ultima espressione nel dire piuttosto, la fecero istintivamente guardare verso il vialetto, col pensiero della fuga, ma i tram di via Palestro erano incredibilmente lontani, e sotto la pioggia era tutta solitudine, spessa, densa, quasi un muro; egli l’avrebbe rincorsa e presa subito, e non era certo la prima volta che rincorreva una donna. Eppure ciò che egli le aveva raccontato fu più forte di questo timore. Lo avevano denunziato, tradito, buttato sulla strada in balìa dei poliziotti, dopo essersene serviti da zimbello. «Chi l’ha denunziato?» Pensò che forse era stato suo fratello. «Chi vuole che sia stato? Il padrone di mio padre, quello che prima mi ha aiutato a stare nascosto e mi portava in giro nelle vostre case per divertirsi.» Riuscì pur sotto la pioggia e il vento ad accendersi una sigaretta. «E sono tre giorni che giro senza potermi fermare da nessuna parte e dormo quasi in piedi e appena sento un passo mi sveglio e corro via.» Lei non diceva nulla, voleva andarsene, ma forse non lo voleva tanto. «Mi aiuti lei, signorina», lui disse, se voleva, sapeva come trattare le ragazze, anche senza violenza, in fondo, quella volta, aveva usato la violenza per la fretta, certe volte non c’è tempo per tutte quelle storie che vogliono le donne; così sapeva che doveva essere gentile e educato, e signore. «Non voglio soldi, non m’importa di mangiare, quando ho un pacchetto di sigarette ho tutto, ma adesso ho anche le sigarette. Mi serve solo di andarmene via, qui, dall’Italia, ho un amico in Svizzera, a Zurigo, che mi sistema lui», sorrise dentro di sé rimanendo serio, afflitto per lei. Cartoccio l’avrebbe sistemato davvero, con tutte le ragazze che lavoravano per lui per variare un poco le quiete serate degli elvetici. «Ma, se piglio un treno o un pullman, mi beccano subito», a lei dava tanto fastidio quel «beccare» che lui usava di continuo, ma provava anche compassione, «e anche se mi va bene, allora mi beccano vicino al confine senza dare nell’occhio, mi basta un centinaio di metri prima della sbarra, conosco il posto, poi mi arrangio da me per le montagne, e ci ritroviamo di là dal confine, in Svizzera, capisce?» «Non molto», lei disse. Il viso acceso di speranza di lui la impietosiva. «Sa, fino a Zurigo è lunga, e gli svizzeri hanno dei polizei che non scherzano, un italiano lo riconoscono da cento metri...» Lei pensò “e lo beccano”. «E lo beccano», disse lui. «Lei invece con l’auto mi porta fino dal mio amico, a Zurigo, in macchina i polizei svizzeri non fanno niente se lei non prende multe.» Tacque, e la guardò, uno sguardo dolce, non infantile, ma giovane, sincero. Riprese: «Non sono una iena, signorina, chi sa che cosa le hanno raccontato di me, ma anche al riformatorio il direttore lo sapeva che era stata una vendetta di quella ragazza, per rovinarmi, perché le avevo promesso di sposarla, poi invece mi ero fatta un’altra ragazza e appena l’ha saputo, lei si è fatta viva e mi ha detto se volevo passare la sera con lei, e io le dico: guarda che ne ho un’altra, e lei dice: non sapevo che eri così fedele, e allora andiamo al solito posto, ma quando siamo lì, lei comincia a sgraffiarmi e a urlare, viene gente e dice a tutti: “Mi ha rovinata, mi ha rovinata”, e invece ha rovinato me, per sempre, che con un precedente simile mi guardano come fossi un mostro, peggio che un assassino», era la stessa storia che aveva raccontato alla polizia, al giudice istruttore, ai rieducatori del riformatorio, ma quelli, duri, non gli avevano creduto neppure una sillaba e con un vistoso nerbo di bue, anzi, gli avevano fatto confessare come erano andate le cose: ma questa no, questa ci credeva, questa beveva come acqua, perché aveva la testa di una dell’asilo d’infanzia, anche se era più alta di lui, come tutte le donne forse, e poteva darsi perfino che rimanesse a Zurigo, da Cartoccio, lui poi sapeva convincerle ancora meglio le ragazze, per spingerle a lavorare per lui, sarebbe stato un colpo da gigante, agli svizzeri piacevano le giovani fini, di classe, come quella. «Non credo di poterla aiutare», lei disse, presa dalla sua voce e dal suo viso sofferente, «e adesso devo andare a casa.» «Lei è l’unica che mi può aiutare», egli disse, ma senza implorare, dignitoso. «E non le costa che portarmi in auto vicino al confine, se viene con una macchina bella è sicuro che non ci ferma nessuno, e poi mi aspetta dall’altra parte del confine, e io passo a monte e quando arrivo lei mi porta a Zurigo, in giornata può essere di ritorno a Milano.» «Mi spiace ma non posso fare nulla per lei.» Lo disse con un tono troppo ufficiale perché lui smettesse. «Va bene», lui mormorò con amarezza calcolata. «Poi non vi lamentate, voialtri, se incontrate sempre più rapinatori o ladri, è inutile che fate tante inchieste, tante conferenze, sulla delinquenza, cosa vuole che faccia io se lei non mi aiuta? Ancora un giorno o due, poi vado all’Idroscalo e becco qualche coppietta, poi un’altra, poi mi compro un pum pum sottobanco e continuo così più in grande. Volete redimere la gente e l’infanzia traviata, e tutte queste balle, e poi, quando ne potete salvare uno, almeno uno, dite di no. A me basta che mi porti in Svizzera, e io cambio da così a così, guardi», distese la mano, prima mostrando il dorso, poi il palmo, «ho un amico a Zurigo che ha un buon lavoro e mi rifaccio una vita onesta, ma, se lei non mi aiuta, come vuole che vada a finire? Anche se mi beccassero, cosa crede che al riformatorio mi trasformino in un angioletto? Ma lo sa lei che tipi ci sono in quell’ambiente? Ci sono ragazzi che hanno fatto fuori la madre o il padre per un mille, che solo a vederli mi facevano paura, e cosa vuole che impari là dentro?» Anche questo discorso, che non aveva avuto nessuna efficacia col giudice, con la polizia, e gli avevano detto di piantarla se no gli ridavano un altro assaggio di nerbo di bue, invece capì dal suo viso che con lei era convincente, e tanto. Ed era stato convincente davvero, anche se lei disse brusca: «Non posso fare niente per lei. Mi spiace». Un momento solo, senza toccarla, sempre con le mani nella tasca dell’impermeabile, perché sapeva che non doveva neppure sfiorarla, se no quella si sarebbe impaurita, avrebbe pensato alla violenza, solo un momento le si parò davanti. «Io sono qui fino a domani sera, notte e giorno, perché i giardini quando piove vanno bene per fuggire», aveva i capelli fradici di pioggia, il viso rigato di pioggia come di lacrime, e anche se non piangeva a lei sembrò che piangesse. «Se ci ripensa e vuole venire ad aiutarmi, io sono qui, a questo posto, solo lei può aiutarmi, mi guardano tutti come un mostro, come un appestato.» Si passò una mano sul viso per asciugarselo dalla pioggia, ma lei scosse il capo e si avviò piano, perché riusciva ancora a controllarsi, poi cominciò a correre perché temeva di essere inseguita e corse fino in piazza Cavour, fino alla fermata del tram, dove sotto la pensilina c’era della gente, e lui non poteva aggredirla più, ma subito si volse, il viso tutto bagnato anche lei di pioggia, a guardare verso i giardini, dove l’aveva lasciato, dove lui vagava, le venne in mente, come una belva del giardino zoologico fuggita, e nessuno lo voleva aiutare. Neppure lei. E perché proprio lei? A casa continuò a stare a letto a pensare, poi capì che da sola non poteva risolvere nulla, c’era solo un uomo che potesse aiutarla a vedere la verità: il professore. Bisognava che lo vedesse subito, altrimenti non avrebbe potuto dormire, non avrebbe avuto pace continuando a pensare alla giovane belva che vagava sotto il diluvio per i viali del giardino, e dormiva sotto la pioggia, senza dormire, durante la notte avrebbe sentito il ruggito delle altre belve chiuse nella gabbia del giardino zoologico, forse più fortunate di lui. Ma trovare il professore fu difficile, era fuori casa e ve lo pescò solo dopo le undici. «È una questione molto grave e avrei bisogno di parlarle subito.» Il professore guardò la sveglietta sul comodino – nonostante tutto, l’udire la voce di lei gli aveva fatto piacere – e pensò alla pioggia, e a cosa si sarebbe potuto supporre di un professore quarantenne che gira verso mezzanotte con l’allieva diciottenne – ma un poco gli sarebbe piaciuto – e afferrò subito la situazione: Sogno, Insipienza e Amore aveva un problema spirituale da risolvere, era una sognante, insipiente, amorosa creatura che viveva solo di anima e intelletto – e anche per questo era adorabile – una specie di Beatrice adolescente che discetta di problemi metafisici, ma lui non era Dante, anche se non riusciva a dimenticare quel collo botticelliano che ora immaginava piegato sul ricevitore del telefono, e lei tutta in ansiosa attesa della sua risposta. «Senz’altro, signorina, ma domattina alle otto, come la settimana scorsa, ora non è possibile», disse. «So che ora è, e che la mia richiesta è assurda, ma la prego...» Oh, quella voce, per un momento stette quasi per dire sì, acceso di tenerezza, ma il breve fuoco si spense subito, come sempre: «La prego, signorina, domani alle otto». «È una storia interessante», disse il professore alzandosi perché l’ascoltava da più di un quarto d’ora e andandole alle spalle, di lei che rimase seduta, e non volse il capo, ma stette immobile, raccolta, come orante, a sentire l’alta presenza di lui che incombeva dietro di lei, come una deità. «Ma non so quale risposta lei si aspetti da me.» Cominciò così, morbidamente, solo perché voleva sfuggirle al più presto, perché era una storia orribile, in cui c’era da compromettersi e rovinarsi solo ad averne sentito parlare. «Lei avrebbe dovuto confidarsi coi suoi genitori.» «Oh», fece lei soltanto, e non occorse altro, era spiegato tutto. «Solo lei mi può aiutare.» «Almeno con suo fratello, suo fratello è giovane e può comprendere», egli disse, rimanendo sempre alle sue spalle. Ma non a lui doveva rivolgersi. «Che cosa vuole che mi dica mio fratello», lei quasi si lamentò. «Di no, che, se porto quel ragazzo a Zurigo, sono una pazza.» «Non credo che gli si possa dar torto», lui disse. Lei, Matilde, allora si volse, quasi implorante: «Ma e se non lo porto, che cosa sono?» sorrise mentre stava sul punto di piangere: «un’accidiosa, o un’ignava, o una pigra?». Lui tornò a sedersi, era mentalmente stanco di quella questione, aveva pensato che Sogno Insipienza e Amore gli volesse sottoporre un problema meno spinoso. «Lei fa parte forse di un comitato per la redenzione dei minorenni traviati?» le disse ostile, eppure come avrebbe voluto prenderle le mani, tenerle nelle sue, e dirle «Ma sciocca, ascoltami» e carezzarle i capelli, e farla sorridere e dimenticare quei fittizi problemi che si creava. «Non scherzi, professore.» «Non scherzo. Lei non ha l’obbligo di redimere nessun giovane. Anzi, come cittadina, ha il dovere di avvertire la polizia che il tipo che cercano si trova ai giardini.» Il tono acidamente canzonatorio le fece salire le lacrime agli occhi. «Professore, io lo so che lei mi prende in giro», non era proprio riuscita a trattenere le lacrime, «ma io lo so da me che non dirigo nessun comitato per la protezione dei minorenni traviati e che dovrei avvertire la polizia, o almeno starmene a casa mia, a fare la calza, se vuole, ma non è questa la risposta che io volevo da lei, lo so da me che egoisticamente non devo neppure pensarci a una questione cosi...» «Si calmi, signorina», e le sue lacrime avevano acceso ancora una volta una fiammella di calda tenerezza in lui, ma come prima si spense subito al pensiero che se c’erano anche le lacrime, allora la storia sarebbe stata lunga, ne sarebbe rimasto spossato e irritato per diversi giorni. «Sì, mi scusi, la prego», non riuscì subito a smettere di piangere e continuò per un po’, mentre parlava, a passare rapidamente il fazzolettino sugli occhi, «io volevo che lei mi dicesse la verità.» «Quale verità?» egli domandò appoggiandosi alla sedia e guardando vagamente da nessuna parte. Dove era la verità? Che cos’era, ammesso che esistesse? E ne esisteva una sola o più di una? O era una semplice emissione di fiato? «Se è vero che dobbiamo aiutare gli altri.» «Senza danneggiare noi stessi», ma gli sembrava che fosse una discussione tanto inutile. «Io non ne ho nessun danno», lei insisté accalorata. «Accompagno quel ragazzo in Svizzera e torno indietro. Io non lo farò, professore, ma, se fra un anno quel ragazzo è divenuto un vero e proprio delinquente, e anche assassino, vorrei sapere da lei se la colpa è mia.» «Direi assolutamente di no.» «Perché?» Oh, cielo, non aveva mai sofferto i bambini che domandano perché. «Le tendenze. Per arrivare a usare violenza a una donna occorre avere delle tendenze che non si cambiano con una gita in Svizzera.» Ma appena ebbe parlato, si accorse che non era quello il modo di far riflettere Sogno Insipienza e Amore. «Allora lei vuol dire che siamo tutti condannati dalle nostre tendenze, che non esiste redenzione, che nessun uomo, nessuna donna, si è mai redenta, ma allora noi non siamo più responsabili delle nostre azioni, né meritevoli, qualunque cosa facciamo è per le nostre tendenze, buone o cattive, siamo dei robot, già caricati, ci sono i robot buoni e i robot cattivi...» L’uggia di quella discussione lo sommerse. «Dovrebbe aver studiato già in liceo la risposta a questa sua obiezione.» «Sì, l’ho studiata: ve ne sono diverse.» Lei, Matilde, cominciò a staccarsi da quel gelido uomo, forse come il cucciolo si stacca dalla madre che non gli dà più retta. «Ma ammetta che io accompagni questo ragazzo a Zurigo e lui si rifaccia una vita; e ammetta invece che io non lo aiuti e che allora lui domani uccida una coppia all’Idroscalo...» «Non si fa la storia con i “se”», lui tamburellò con le dita sul tavolo. «Lei può accompagnare questo ragazzo a Zurigo e forse lui diventa lo stesso un criminale. Oppure lei non lo accompagna, e lui, benché solo e senza aiuto, si rifà una vita onesta. L’uomo non può predeterminare il futuro...», si era lasciato scappare anche questa sciocchezza, adesso lei vi si sarebbe aggrappata, e si sarebbe fatto mezzogiorno, inutilmente. «E allora torniamo al punto che non si deve far niente, che non vale la pena di fare niente, tanto non possiamo predeterminare niente. Non possiamo neppure costruire case, perché può venire il terremoto e buttarle giù. Io invece sento che bisogna fare», e si alzò, avvilita di essere stata così allontanata, respinta, non sentiva più neppure il piacere di essere sola con lui, guardava la pioggia violenta, fuori del grande finestrone, e pensava alla giovane belva che vagava per i giardini, fermo sotto le grandi piante, ad attenderla. Allora lui ebbe un momento, un momento solo di paura. Poteva metterle una mano sulla spalla, lì, vicino al collo, e poi spiegarle amorosamente – sì, amorosamente – che non doveva affrontare così il problema morale che la inquietava, e spiegarle tutto, tutto quello che lui sapeva, per toglierla da quella spirituale, oh quanto spirituale angoscia, in cui un giovinastro qualunque l’aveva gettata, e se le avesse detto tutto, e tenuto la mano sulla spalla, allora lei avrebbe creduto a qualsiasi sua parola, altrimenti, come ora, con quello sguardo umiliato e gelido, se ne sarebbe andata in preda alla sua angoscia, e l’angoscia è una cattiva consigliera. Ma la fiammella si spense ancora. E poi, che cosa sarebbe stato? Pensò a tutta l’affaticante, spinosa storia avuta con un’altra ragazza che aveva perfino pensato di sposare e dopo, per settimane, gli passeggiava davanti a casa e, senza dirgli nulla, lo guardava quando egli rientrava, poi si metteva a piangere, lì per la strada, facendo voltare i passanti. Si alzò anche lui. «Comincio a capire che cosa vuole lei da me. Che io le dica che deve portare questo ragazzo a Zurigo, o che le dimostri metafisicamente che è male portarcelo. Ma io non sono un creatore di sistemi metafisici, un Aristotele o un Hegel, sono un semplice professore di filosofia. Le dico nel modo più categorico che lei non deve accompagnare un ragazzo del genere né a Zurigo né in qualunque altro luogo, né rivederlo. Ma se mi chiede le ragioni metafisiche del perché no, le dirò che non ce ne sono, o per lo meno che io non le vedo. Ci sono delle ragioni pratiche, una ragazza non fa un viaggio fino a Zurigo con uno che è stato condannato per violenza carnale», la vide arrossire perché questa volta la frase violenza carnale era stata pronunziata da lui, l’idolo, «vi sono delle ragioni di sano egoismo, una ragazza non può mettersi a redimere tutti i traviati in cui inciampa per la strada, ciascuno fa il suo mestiere, lei faccia la signorina Del Monte e lasci ai funzionari del tribunale dei minorenni di redimere i ragazzi traviati...» Lei s’irrigidì: e lui, il ragazzo, faceva intanto la belva, ai giardini pubblici, il tigre fuggito dalla gabbia, che ruggiva sotto la pioggia. «Mi scusi, professore, le ho dato tanto fastidio, sono stata una sciocca», ma glielo disse gelidamente, perché lui comprendesse: non era più il suo idolo, non era più nulla per lei: l’aveva lasciata sola, e nel momento in cui aveva maggior bisogno. E la stessa, gelida sensazione l’ebbe lui quando la vide uscire e la porta si chiuse dietro di lei: l’aveva lasciata sola, era come se lui, stando sulla riva, l’avesse sentita gridare aiuto, e non si fosse mosso, e fosse stato a vederla scomparire nel mare, immobile. Doveva fare qualche cosa, lo sapeva, da dieci anni conosceva ragazze di quell’età, quasi ogni giorno si avvicinava alla loro anima e aveva imparato a comprenderle dal minimo gesto, dalla più comune inflessione di voce. Doveva almeno telefonare a casa dei genitori di lei, perché non le dessero la macchina, le togliessero il passaporto, insomma la tenessero a casa. Sì, telefonare, ma il telefono era nell’ufficio della segretaria e, sulla porta, esitò, una conversazione con dei genitori, di solito facili al dramma, su un ragazzo traviato che attende la figlia ai giardini pubblici, davanti alla vecchia segretaria, avrebbe provocato uno squassamondo, un valzer senza fine di domande, pettegolezzi, commenti. Meglio telefonare fuori, al caffè, e si avviò verso il corridoio che portava all’uscita, ma una frotta di ragazzi e ragazze gli veniva incontro, un giovanotto lo fermò, il solito che aveva frequentato poco – o niente? – le sue lezioni, e si scusava dolciastro, foruncoloso, di non averle potute frequentare di più, ma aveva avuto la sorella malata – eh, sì, e le era stato sempre vicino, al capezzale, se lo immaginava – ma se lui, il professore, poteva dargli lo stesso la firma. Ma va’ a zappare, lui pensò, ma gli disse: «Venga da me più tardi», adesso doveva andare a telefonare, ma sulla porta, davanti alla pioggia diluviale si fermò esitante, era meglio se tornava indietro a prendere l’impermeabile, si sarebbe rovinato l’abito, se no, con quell’acqua, e rifece il corridoio, ma non uscì più perché mentre ripercorreva il corridoio aveva pensato a quello che potevano dirgli i genitori di lei, come mai questa storia di uno evaso dal riformatorio? E lui come faceva a conoscere un evaso dal riformatorio, no, lui non ne conosceva nessuno, e la madre, drammatica: ma allora perché me ne parla lei?, e poi, soprattutto, pensò che forse Sogno Insipienza e Verità non sarebbe mai andata a Zurigo, era solo una fantasia. Invece era andata a Zurigo, era andata a portare il tigre pensando che era suo dovere tentare di trasformarlo in agnello, di redimerlo, e il giornale raccontava che era stata arrestata a Zurigo, insieme a uno evaso dal riformatorio e a un suo amico, chiamato Cartoccio, in un appartamento un po’ troppo libero. Col «Corriere» sottobraccio il professore entrò nel caffè anche quel mattino, come tutte le mattine, e aspettando il caffè, rilesse la notizia che aveva già letto alle sei quando la cameriera gli aveva aperto la finestra e portato il giornale. «Il ristretto per il professore.» Non riuscì a berlo, quella mattina, il ristretto. Lei aveva gridato aiuto, e lui era rimasto fermo sulla riva a vederla scomparire nell’acqua. Tornò in macchina, ma attese un poco, prima di mettere in moto. Sarebbe stato così facile salvarla, sarebbe bastato parlare con amore, sì, con amore, e avrebbe voluto anche parlarle, con amore, ma l’accidia – la vera accidia, l’akedìa – era stata più forte, come tante altre volte. L’accidia di impegnarsi, di affrontare una lotta, una difficoltà, l’accidia anche di amare, perfino di studiare, per questo non aveva scritto che l’indispensabile della sua professione, per questo non si era sposato, non aveva figli, non aveva neppure amici, né donne, se non generiche, come Giuditta. Accidia, akedìa, e l’adolescente dal collo botticelliano si era trovata a Zurigo con un biondino e con Cartoccio, completamente rovinata per sempre dalla paurosa esperienza che lui avrebbe potuto evitare solo mettendole una mano sulla spalla, quella mattina di pioggia, e dicendole senta, cara, ma non l’aveva fatto, come non faceva quasi mai nulla. Mise in moto, ma dopo aver buttato nei sedili dietro il giornale, per non vederlo più; Dante lo avrebbe messo nel Canto Settimo, immerso nel limo paludoso dello Stige, immerso «nella belletta negra», akedìa, incuria, indolenza, uno dei peggiori vizi capitali, e dopo un centinaio di metri capì che quella mattina non avrebbe potuto dare lezione e voltò la macchina per andare verso casa, ma poteva chiamare casa le due stanze in subaffitto? E allora non aveva nessun posto dove andare, non si era impegnato mai con nulla e non era impegnato da nulla, non aveva mai curato nulla, e nessuno si curava di lui. Giuditta a quell’ora insegnava anche lei, matematica, poi ne aveva un altro che forse l’avrebbe sposata, e glielo aveva detto. Allora si fermò e riprese a leggere la notizia, breve, in fondo, succedevano cose peggiori, e la voce di lei gli arrivò come se lei fosse lì: «Oh professore, solo lei può aiutarmi!». 54 · Aspettando il Supremo Era una sera quieta, troppo vicina al ferragosto, e il giovane avvocato aveva tempo, e il viso ancora bello della donna, anche se distrutto, si vedeva, come da un interiore terribile male, gli ispirava un’incerta ma non superficiale emozione, benché la questione fosse legalmente senza nessun interesse, tanto futile che meschina, per questo l’avvocato grosso l’aveva affidata a lui che era l’avvocato piccolo. «No, signora», le disse curvandosi sulla scrivania, per guardare meglio quegli occhi languidi, anche se infossati e ombrati per quel suo terribile male, per parlarle più da vicino, perché sentiva che doveva fare così per poterla convincere, «queste sono cose che non si fanno, lei non può andare contro la legge: c’è una sentenza che ha stabilito che lei non può usare il nome di suo marito, e questa sentenza lei la deve rispettare, altrimenti rischia le più spiacevoli conseguenze.» Chi aveva emesso quell’odiosa sentenza, e per quali ragioni? Oh, sì, l’aveva nel cassetto e letta e riletta quasi con incredulità: ...il comportamento della coniuge dell’istante è lesivo del suo buon nome e per fino della sua professione, essendo stato appurato come dalle infrascritte testimonianze che la suddetta frequenta abitualmente osterie e locali simili, ogni sera, ubriacandosi e parlando continuamente del coniuge da cui è pur legalmente divisa da anni, riferendo a qualsiasi avventore o sconosciuto fatti anche intimi e delicati della sua vita matrimoniale..., e perciò le avevano tolto il diritto di chiamarsi col nome del marito, geometra Carlo Pontani, mentre lei insisteva e continuava a dire di essere la signora Pontani. «Ma è il mio nome», lei disse, con gentile foga, battendo un poco la palpebra di un occhio, uno dei leggeri tic alcoolici che cominciavano ad apparire in lei. «Sono sua moglie, la moglie ha il cognome del marito.» «Sì, lo so», disse con fraterna pazienza lui, l’avvocato piccolo. «Ma la sentenza le ha tolto questo diritto: lei deve chiamarsi col suo cognome da ragazza», lesse una delle carte dello smilzo e meschino fascicolo, «Elena Cavallaro, e non Elena Pontani. Deve togliere la targhetta sulla porta di casa e sostituirla, se vuole, con una in cui sia scritto Cavallaro e non Pontani. Ma non basta, signora, lei non deve più infastidire suo marito, andarlo a trovare, cercare di lui. Sono ormai più di cinque anni che siete separati, lo dimentichi, lo lasci stare», ma smise di parlare perché capiva che lei non l’ascoltava, con quegli svanimenti, allontanamenti dal mondo reale, di quando si beve e si fugge d’istinto da ciò che ci ferisce o turba. «Vuole bere qualche cosa, signora?» Dal lontanissimo mondo in cui era fuggita, lei riemerse, con quel suo tailleurino nero così elegante, l’acconciatura così a posto e discreta in confronto alle testone gonfie che giravano in quell’epoca, il brillare della fede che aveva tenuto ostinatamente al dito, benché da tanti anni nessuno volesse più fede da lei, né niente, e una catenina d’oro al collo che lui, il geometra Carlo Pontani, le aveva regalato prima di sposarsi e che lei toglieva da allora solo due minuti al mattino per lavarsi il collo, e riemerse solo per dire, riconoscente: «Sì, grazie», poi subito ritornò, fuggendo, in un mondo ancora più lontano, con lo sguardo fisso, eppure così languido – non aveva ancora ventinove anni – maniaco, così che il piccolo avvocato, ma almeno di statura era alto, e muscoloso, con le maniche della camicia rimboccate, preferì alzarsi subito per non vederla, e andare a ordinare al fattorino dell’ufficio che portasse su delle bottiglie, ghiaccio e seltz, e finché non vennero, non tornò da lei: e lei, per fortuna, non guardava più così fisso. «C’è del bitter, del vermut, o vuole un po’ di cognac?» le disse, si slacciò ancora di più il collo della camicia, e allentò ancora la cravatta, e non era solo per il caldo, ma per la vista di quella donna consumata, corrosa, eppure ancora bella, e così viva. «Cognac, grazie.» Il cognac prima di mangiare, come aperitivo, lui pensò. «Vuole un po’ di seltz?» «No, grazie.» Cognac, e nudo, lui pensò. Inghiottì il suo bitter perché la storia, minuto per minuto, sotto gli occhi, gli stava diventando spaventosa, e in quella Milano svuotata dalla vicinanza del ferragosto, vuota come uno smisurato castello abbandonato dai suoi signori, coi tram che per la strada sotto scivolavano vuoti nel vuoto, con qualche passo che risuonava quasi echeggiante come quello di un secondino in un carcere vuoto, quella storia, allora, sembrava più sinistra. «Signora, io sono l’avvocato di suo marito, ma questo non vuol dire che non possa essere anche suo amico, lei deve aver fiducia in me.» «Oh, sì», lei rispose subito e il grosso sorso di cognac che aveva bevuto aveva reso subito più scattanti i suoi gesti. «Signora», lui sedette sulla scrivania davanti a lei col bicchiere del bitter pieno di ghiaccio in mano, e avrebbe voluto carezzarle il capo o metterle una mano sulla spalla, e dirle di non guardare così, con quei grandi occhi, che ogni tanto si fissavano, maniaci, in qualche punto. «Signora, mi dica la verità, vi deve essere qualche motivo perché suo marito la tratti così, da tanti anni, non voglia neppure sentire il suo nome, si rivolga agli avvocati, alla polizia, ai tribunali, appena lei gli si avvicina. Non è possibile che un uomo agisca così, senza nessun motivo, mi dica la verità, la prego, se no non potrò aiutarla, e io voglio aiutarla.» Dovette metterle una mano sulla spalla, ma per scuoterla dalla sua agghiacciante fissità. «Capisce?» Accennò di sì, lei, che capiva, benché guardasse ancora fissamente. «Non lo so», disse. «Non lo so.» Dal modo come guardò la bottiglia di cognac l’avvocato comprese e gliene versò ancora. Cercò di non guardarla mentre beveva. «I primi anni pensavo che fosse perché non mi amava più», lei disse, Elena Cavallaro, alla quale per legge era proibito chiamarsi Elena Pontani, «perché lui mi aveva detto così, ma poi non ho capito più», la voce le si affievolì, «e non lo so, non lo so più.» Non poteva sapere, nessuno poteva saperlo, lui solo, Carlo Pontani, allora non ancora geometra, l’aveva intuito, improvvisamente, come una rivelazione, quando lei, col grembiulino nero che indossava la sera, gli si era avvicinata nel salotto sempre deserto della pensione e gli aveva detto che era stata dal medico e che non c’erano più dubbi. Un giorno lontano, quello, e lui aveva guardato il grembiule nero di lei, quella sera, e il davantino bianco, una cameriera aveva pensato, come se lo scoprisse in quel momento che era una cameriera, d’improvviso, quasi prima lei fosse andata in giro con un cartello al collo con scritto duchessa, e non aveva certo badato al grembiule nero tutte le sere che in quei tre estenuanti mesi di vacanza in mezza montagna era andato nella sua stanza, dove lei lo attendeva appassionata e confusa. E da quella sera lui era stato offeso, umiliato della propria debolezza, e dell’abisso, secondo lui, in cui era caduto, perché conosceva suo padre, il grande geometra, il geometra Ernesto Pontani, e sapeva che non vi era possibilità di sfuggire. «La sposerai perché i Pontani non sono farabutti, e poi finirai di studiare per diplomarti, se non vuoi che un Pontani vada a fare il fattorino», e né i Capetingi, gli Sforza, i Wellington, i Romanov avevano forse mai dato al loro nome il significato supremo che lui, il padre, e poi il figlio, davano al loro: Pontani. Infatti non sfuggì, e una mattina uscì da una chiesa con lei al braccio, e lei era divenuta sua moglie. Per un anno lui aveva dovuto studiare per ottenere il diploma di geometra ed entrare nello studio Pontani e in quest’anno non ebbe tempo da dedicare al problema; quando non era all’istituto, era a casa a studiare, e le era stato vicino solo i primi due mesi quando lei aveva perduto il bambino, ferito ancora di più nella sua superbia al pensiero che per due mesi, due mesi soltanto di differenza, lui si trovava legato per sempre a una donna di quella specie. Anche in quell’anno, però, cominciò ad avvicinarsi alla soluzione: ebbe rapporti con lei solo tre volte e solo perché al principio era ingenuo e aveva mantenuto l’abitudine di andare a letto presto e allora era difficile evitarlo, poi cominciò a studiare fino alle due di notte e fisicamente la dimenticò, l’abolì. Poi, l’ordine, il lindore della casa, la gustosità delle pietanze che lei preparava, il buon odore della biancheria, la modestia delle spese, tutto questo, che lei faceva con tanto amore, gli rammentavano invece ancora più amaramente chi lui aveva sposato, abile per forza in quei lavori. Nessuno venne mai invitato nella loro casa, né lui andò mai in casa altrui con lei, perché inevitabilmente, conoscenze e amicizie – alcune delle quali già sapevano – conversando avrebbero scoperto quale brillante matrimonio avesse fatto. Dopo essersi diplomato, col pretesto del lavoro, non la portò più neppure quel paio di volte al mese al cinema, come faceva prima, e cominciò a parlarle di dividersi. Le aveva parlato sempre pochissimo, solo per dirle di sì, ed evitare discussioni, quasi che il semplice scambio di parole lo insudiciasse, ed ebbe l’altezzosa pazienza di spiegarle, nel povero caramelloso linguaggio che lei poteva capire, che la sua era stata un’infatuazione, non un amore, e che quando due non si amano, non possono vivere insieme senza essere infelici tutti e due, e naturalmente lei si ribellò, ingenuamente piangendo che lei invece l’amava, che era felice con lui, e lui la lasciava dire, poi dopo una settimana o due riprendeva il discorso, e lo rendeva più significativo, col venire a casa solo per dormire e mangiare la sera, e standole fisicamente lontano, mentre lei da mesi e mesi, la sera in bagno, si profumava, si spazzolava i capelli, indossava le vestaglie da notte trasparenti, e attendeva, invano; finché la debole struttura psichica di lei cominciò a crollare, specialmente quando lui le insinuò la speranza che, dopo una temporanea separazione, forse avrebbe sentito la mancanza di lei, e allora avrebbero potuto di nuovo vivere insieme. Fu una fredda e orrenda operazione di chirurgia mentale che lui, piccolo, grassoccio, di un pallido malaticcio, eseguì su una paziente ignara, indifesa e innamorata, e vi furono altre ribellioni, di lei, ma vane, e una mattina, solare come quella in cui l’aveva sposata, le fece firmare davanti al giudice la condanna a non essere più sua moglie, se non nominalmente: divisione consensuale, per incompatibilità di carattere. Il giovane giudice la guardò, mentre firmava, così giovane, così splendente, così vicina alle lacrime – e poi guardò lui, che sembrava così umile, triste, desolato di quanto accadeva, e non capì, come mai nessuno forse avrebbe capito, perché nessuno avrebbe dovuto mai comprendere i bassi motivi che ispiravano il piccolo grassoccio – supremo – geometra. Lui aveva già dimostrato le sue modeste condizioni economiche, effettivamente modeste, non era il potente finanziere che si libera di una moglie sbagliata, era un modesto diplomato con un buio ufficio in una viuzza del centro ereditato dal padre e pieno più di polvere che di carte di lavoro, e così ottenne di pagare poche migliaia di lire al mese di alimenti, e lei si ritrovò, sola, in corso Vittorio Emanuele, in quella solare mattina, dopo averlo visto allontanarsi e salire su un tram, e allora poté mettersi sì a piangere, nascosta, in un portone. «Oh, il primo anno sono stata tanto felice, eravamo sempre soli, avevo tanto da fare per la casa nuova, per tenerlo in ordine, aveva solo tre abiti, uno era anche vecchio ma glieli tenevo che era sempre più elegante di tutti gli altri: lui aveva tanto da fare, prima per diplomarsi, poi quando morì il padre per rilevare lo studio, e non ci parlavamo quasi mai, ma io ero felice solo a stargli vicino, poi era buono, non alzava mai la voce, diceva sempre di sì, qualche volta andavamo anche al cinema, ho visto quasi una decina di film in quell’anno, non sono mai stata così felice come in quell’anno...» L’avvocato piccolo scese dalla scrivania, il modo di parlare di lei, e le cose che diceva, lo inquietavano, sentiva che le cose non erano come lei le vedeva, ma non riusciva a comprendere come potessero essere. Una vicenda così comune da dare la nausea, eppure sentiva che non era comune. Si versò un altro bitter, non c’era più ghiaccio, si era ormai disciolto, e lei aveva finito anche il cognac, e il tic alla palpebra di un occhio le era scomparso, i gesti erano divenuti più morbidi. La città vuota, calda, sinistra, era intorno a loro, e anche buia, doveva essere tardi, si stava sbronzando anche lui con tutti quei bitter. «Senta», disse dopo aver bevuto, «adesso è tardi, io vado a mangiare qualche cosa in una trattoria qui vicina, venga anche lei, mi farà molto piacere.» Distrutta, sul collo magro che mostrava tendini e muscoli a nudo come in un disegno per studenti in medicina, la catenina d’oro di lui che si toccò con magrissime dita, ma gli occhi ancora più languidi per l’alcool, lei scosse il capo. «Grazie, ma alle nove devo andare all’ospedale», disse gentile, «c’è una suora che mi vuole bene, e che mi lascia passare, mi porta sull’ingresso della sala, sa, vicino a lui no, se no sta male, ma lo posso vedere dall’ingresso, il suo letto è il quarto, lo riconosco dalla testa...» L’avvocato piccolo era un iroso, posò violentemente il bicchiere col bitter sulla scrivania, parte del bitter si versò anche su alcuni fogli scritti, ma chi se ne fregava, il lieve tonfo sembrò un’esplosione nella paurosa solitudine ferragostana della città. «Lei non va in nessun ospedale», disse, e poi bestemmiò, aveva perso il controllo, «io sono l’avvocato di suo marito e le dico che lui non vuole essere molestato, sono pagato per impedire con ogni mezzo consentito dalla legge che lei lo molesti, ha capito?» Il volto lucido di sudore, gli occhi arrossati, la camicia aperta sul petto sotto la cravatta, le incombeva sopra. «Lei non va!» urlò. La fragile struttura psichica di lei non poteva resistere a quel colpo di maglio, abituata da ragazzina, da quando aveva cominciato a servire, a non ribellarsi, guardò l’atletico maschio che incombeva su di lei e disse: «No, non vado». Lui si riprese, s’infilò la giacca che aveva buttata su una sedia: «Andiamo», ordinò, con voce violenta, ma non irosa. Per il lungo corridoietto incuboso, una delle più vecchie e marce case di Milano, la vide camminare elegante, ma troppo molle per il cognac bevuto, e davanti all’ascensore lei barcollò del tutto e allora egli la sostenne. «Cerchi di mangiare», le disse. «Non ho fame.» La trattoria era vuota e loro erano gli ultimi e non desiderati clienti, il cuoco magrolino e basso girava per le due salette fumando, col grande cappello bianco in testa, e venne lui direttamente a prendere le ordinazioni perché conosceva l’avvocato e gli disse che era tutta carne vecchia, pesce vecchio, verdura vecchia e che doveva andare in vacanza e non stare a Milano, in quei giorni. Lei cominciò a sorridere, ma senza voglia, e senza voglia mangiò un po’ di lasagne, poi si fermò e lui non riuscì a farle mangiare più niente; però beveva, il rosso acido vino, e lui non osava impedirglielo, perché almeno parlava, parlava, parlava, e forse lui sarebbe riuscito a capire, a un certo punto. Prima, appena dopo la divisione, appena dopo quella solare mattina, si era ammalata, e, benché avesse vicino un’amica che faceva la guardarobiera al Cavalieri, e che era in ferie, gli scrisse per dirgli che non era niente di grave, la solita colite, e che non stesse in pensiero; se voleva, poteva venirla a trovare, c’era anche un orario comodo, dalle sette alle otto di sera. La lettera le ritornò dopo due mesi, quando era già guarita, dopo aver girato ai vari indirizzi che lei cambiava, ed era contenuta nella lettera di un avvocato, e l’avvocato la pregava, dietro richiesta del marito, di non scrivere più per nessun caso e per nessuna ragione. Forse lei non aveva afferrato completamente il senso del messaggio – che lei non esisteva più, per lui, perché lui, Carlo Pontani, l’aveva cancellata dall’albo degli esseri umani, dei viventi – o forse dopo averlo afferrato, passato qualche mese, l’aveva dimenticato ed era tornata a ricordare la solare mattina in cui si era sposata, e il solare anno in cui, senza sapere di essere disprezzata, tenuta lontano come la più bassa, repellente creazione della natura, era stata così felice nel badare alla sua casa, nel rifare il letto, nello stirargli i calzoni, nel dosare le salse dei sughi, che erano il modo che aveva di dimostrargli il suo amore, e aveva cominciato ad aspettarlo perché lui glielo aveva detto che forse dopo un po’ che erano divisi poteva darsi che egli sentisse bisogno di lei, e si può dire che lei vivesse in questa speranza che era quasi una certezza: che egli avesse bisogno di lei. Ma non poteva certo vivere aspettandolo, con gli alimenti che una raccomandata le portava, puntualissimi e oltraggiosi ogni fine mese, e si era rimessa a lavorare a quell’unico lavoro che oltre tutto le piaceva perché, animale femmina, aveva il senso del nido, e come certi paperi cuccioli rimasti orfani prendono qualsiasi bestia, cane, o cavallo, o avvoltoio per loro madre, così lei, in qualunque casa andasse a lavorare, prendeva quella casa per suo nido, lavava la sporcizia degli stracci dei padroni con lo stesso amore con cui aveva lavato le camicie di lui, e alle sette era in piedi, sulla scala, a pulire i vetri o i lampadari e nel momento in cui li puliva erano proprio suoi della sua casa propria, in cui aveva vissuto con lui, quel solare anno di felicità. Il primo Natale gli mandò gli auguri con un piccolo regalo, una cintura di pelle di coccodrillo, perché lui era un diplomato, una persona molto su, e doveva avere cose fini e dopo l’Epifania, cartolina argentata degli auguri e cintura di coccodrillo le tornarono indietro insieme con una lettera minacciosa dell’avvocato, cioè che lui, il supremo diplomato, avrebbe iniziato causa per molestie o per qualcosa che lei non capiva bene, se insisteva nel voler mantenere relazioni non più compatibili con la condizione di moglie separata. Allora lei cercò di parlargli al telefono, ma solo per spiegargli che si trattava soltanto di auguri, e di un piccolo regalo, che non voleva molestarlo, e anche per ricordargli che lo aspettava, come lui le aveva detto, senza rendersi conto nel modo più assoluto di quanto lui volesse allontanarla e cancellarla da sé, come entità mai esistita, il cui solo pensiero umiliava la sua altezzosità; ma per vari mesi riuscì solo a sentire la voce di una cameriera o della segretaria. E non riuscendo per telefono andò ad aspettarlo all’uscita dello studio, e anche davanti a casa, ma lui, o la vedeva dalla finestra, o la vedeva mentre stava uscendo e subito si ritirava. Solo una volta lei trovò modo di bloccarlo, e lui si fermò ad ascoltarla, gentile, rigido, livido, come dovesse tenere un fazzoletto sporco in mano, lì, esposto in mezzo alla strada. «Certo, cara, non preoccuparti, ti ringrazio degli auguri, ma ti prego, ho molto da fare.» Mai si sarebbe abbassato a litigare, a discutere: solo coi propri pari. Per qualche mese le bastò averlo visto per rimanere quieta, e aspettare, e anche della chiamata al commissariato non si preoccupò troppo: il commissario le rammentò ancora che lei non doveva molestare suo marito, né scrivergli, né telefonargli, né altro, o se no lui l’avrebbe rimandata al suo paese di origine, cosa risibile, che neppure materialmente avrebbe potuto fare, perché lei era di un piccolo paese al di là di Trieste e questo era come se lei fosse senza luogo di nascita, come nata nel nulla, e non poteva rimandarla nel nulla. E neppure il Natale seguente riuscì a resistere alla tentazione di mandargli gli auguri, e un regalo, un accendino a gas che il suo padrone le aveva comperato in Svizzera, con le iniziali d’oro C P che fece mettere lei stessa dall’orefice, ma era preparata, malinconicamente, a vederselo tornare indietro, il tutto, come infatti le tornò indietro dalle mani di un avvocato, immediatamente, la vigilia di Natale, insieme con l’ultimatum: ancora un gesto simile e lui, Carlo Pontani, l’avrebbe denunziata, di cosa o per che cosa lei non sapeva, capì solo la parola denunzia e siccome a quel tempo lavorava al Cavalieri, con quella sua amica, e la vigilia di Natale c’era abbondanza e tolleranza, si ubriacò nella sua stanzetta, sua e della sua amica che la trovò addormentata come in coma, chiamò il medico e il medico disse che aveva semplicemente bevuto. E così erano passati quasi tre anni da quando si era separata da lui, e lui non le aveva ancora chiesto di tornare e lei cominciava a sentire che forse non sarebbe mai tornato. Nella trattoria vuota, circondata dalla città vuota, e fuori della porta aperta da cui non veniva aria nessuna passavano ogni tanto estenuate, solitarie e vuote creature, o un’auto vagante nel vuoto metropolitano, come sperduta, il piccolo avvocato iroso bestemmiò sottovoce, facendola deglutire dallo spavento, e guardò iroso il padrone che si era messo a giocare col cuoco e i due camerieri, e provassero a dirgli di andarsene che loro dovevano chiudere e lui li avrebbe picchiati. Bestemmiò e disse: «Ma in questi tre anni, così giovane come è, e allora lo era ancora di più, non le è venuto mai in mente di trovarsene un altro, un giovanotto, un bagnino, un camionista, un qualunque maschio insomma, e chiunque sarebbe andato bene, meglio di quello lì, che non l’ha mai voluta, e glielo ha fatto capire in ogni modo?». E bestemmiò ancora, e il cuoco col cappello alto, che aveva l’udito fine, scosse un momento il capo alla bestemmia e giocò male il settebello e il cameriere suo compagno, vedendo comparire sulla tavola, in un momento così spropositato, quel sette di quadri gli disse di andare a giocare alla lippa. «Ma io lo aspettavo», lei disse, inghiottendo ancora aria, «perché me l’aveva detto.» Lo aspettava, ma senza più credere che lui una volta o l’altra avrebbe potuto richiamarla, lo aspettava senza speranza, senza Fede, ma incapace di non aspettare, incapace di vedere in un altro uomo un uomo, come l’unico vero uomo esistente fosse lui, e gli altri il nulla, respingendo negli alberghi i tentativi dei clienti, o nelle case dove lavorava le attenzioni dei padroni vecchi o giovani, o nelle passeggiate domenica pomeriggio con la sua amica le tenerezze di robusti e candidi giovanotti, in divisa o no, stando nelle sale da ballo tra le braccia di quei giovanotti senza neppure vederli, lontana, e come unico conforto c’era il bere, che le faceva venire sonno, un sonno in cui non poteva né pensare né ricordare. Guadagnava bene perché era brava, le davano quello che voleva, in una casa si fermò più di un anno, si affezionò alle due figlie dei padroni, raccontò alla padrona la sua storia e lei le consigliò allora di sistemarsi con un certo ragazzo che conosceva, glielo presentò, le lasciò tutte le libere uscite che voleva, ma dopo poco il ragazzo venne a dire che lei beveva, era carina, era brava, ma beveva. Ed era vero, aveva solo due modi per dimenticare, ed era lavorare o bere, così quando le due figlie della padrona si sposarono, quasi insieme, e non ebbe più neppure quel minimo legame affettivo, si licenziò, e cominciò a lavorare a giornata, e guadagnava tanto lo stesso, e la sera scendeva nel bar vicino a casa e poi verso il tardi s’incamminava dove lui aveva lo studio di geometra, o la sua casa, ma stava lontana, guardava da lontano, perché aveva paura di quello che le aveva detto il commissario; oppure restava al bar e si metteva a parlare con la padrona, vacillando, col bicchiere in mano, di quando si era sposata, di come era sempre stato gentile lui, e la grassa padrona si sentiva le lacrime dietro gli occhi, e non capiva neppure lei perché un uomo avesse ripudiato una ragazza così, ed era una romagnola impulsiva, raccontò la storia di quella vacillante ragazza al marito, a qualche vecchio cliente, al barista più anziano, a una vicina di casa, finché il supremo, il sommo diplomato, pur vivendo in una metropoli di oltre un milione e mezzo di abitanti, non venne a saperlo: il suo nome, Carlo Pontani, era fatto nelle bettole, da una serva ubriaca. Fu l’occasione perché lei, sia pure in un modo così gramo, potesse sentire parlare di lui, vicino a un avvocato, a un giudice, e leggere delle carte bollate che dicevano che lei non poteva portare più il cognome di Pontani, ma non capì mai bene la cosa, capì solo che doveva cambiare bar e non le fu difficile, perché cambiava padroni e lavoro quando voleva, ma si teneva sempre una stanzetta e due anni prima, tanto soldi ne aveva, aveva affittato due camere e messa la targhetta sulla porta, Elena Pontani e non Elena Cavallaro, come voleva la legge, e gli uomini che fino ad allora avrebbero potuto tentarla non esistettero più, perché finito il suo servizio a giornata tornava a casa e beveva, sola, davanti alla radio accesa, svegliandosi diverse volte durante la notte seduta in poltrona, davanti all’apparecchio che friggeva, e nel suo abisso domandandosi ancora perché, il perché, di quello che le era accaduto. L’avvocato la portò fuori dalla trattoria, sorreggendola, la portò all’Idroscalo, ma non in un bar, dove avrebbe voluto bere ancora, continuò a girare per i bui e misteriosi viali, e a farla parlare, perché voleva sapere, e ancora non riusciva a comprendere, ma sentiva di essere vicino alla soluzione, specialmente quando lei disse che un giorno aveva saputo, girando come tante volte in tanti anni, dalle parti del suo studio, che lui aveva chiuso, lo studio non c’era più, il portinaio gli disse che erano venuti anche gli ufficiali giudiziari, era andato tutto male, lui non era come il padre, ma c’era lei che aveva dei soldi da parte e pensò, esplodendo come una mina rimasta sepolta e quieta fin dalla guerra, che era arrivato il momento in cui avrebbero potuto riunirsi, perché lei doveva aiutarlo, e andò direttamente a casa sua, con la borsa piena di tutti i soldi che aveva ritirato alla banca, e la cameriera prima la fece entrare, non conoscendola, poi la spinse fuori. «Insomma vada via, scompaia, ha detto che non vuole neppure sentirla nominare», mentre lui, chiuso nella sua stanza, rigido pur nel suo viso grassoccio, le ultime ventimila lire nel portafoglio, oltre alcune azioni troppo lontane per essere utilizzate, stringeva i denti per quel nuovo affronto alla sua alterigia. Ma lei gli scrisse, gli disse che aveva tanto in banca, che voleva aiutarlo se lui aveva bisogno, che nelle sue due stanze c’era posto anche per lui, se avesse voluto, perché il pensiero di poterlo aiutare, che egli avesse bisogno di lei, le ridava la vita, per qualche tempo quasi non bevette più, occupata ad attendere la risposta, a cercare di telefonare per parlargli, ad aspettarlo davanti al portone di casa; mentre lui le fece riavere dall’avvocato la lettera neppure aperta e l’ultima, davvero ultima, ingiunzione di scomparire. «Ma lei non è scomparsa», disse l’avvocato, erano fermi in un viale più buio e misterioso degli altri, le zanzare entravano nell’auto, si sentiva il loro ronzio, quando lei faceva una pausa nel suo lungo soliloquio. Forse doveva essere pazza, forse aveva ragione lui, Carlo Pontani, quando aveva scritto all’avvocato grosso che vi era la possibilità di annullare il matrimonio – quel mostruoso errore che lui, un Pontani, aveva commesso – per malattia mentale della moglie. No, non era scomparsa, forse lo avrebbe voluto, ma non se ne rendeva conto. E poi un giorno aveva saputo che lui era all’ospedale e nessuno l’aveva più trattenuta, era arrivata con la borsa più grande che aveva carica di arance e di riviste, credeva che fosse in una cameretta separata, ma era invece nella corsia comune, il viso giallo per il fegato straripato, scoppiato, in un mondo dove essere un Pontani non serviva a niente, ma lui Pontani rimaneva ugualmente, e mentre lei gli si curvava ansiosa e felice sul letto, guardava il soffitto e non rispondeva perché nessuno poteva pensare che un geometra Pontani, anche in miseria, si lasciasse comprare da una domestica, del tutto incidentalmente e disgraziatamente sua moglie, e quando era passata la suora l’aveva chiamata. «Suora, non desidero questa visita, la prego, mandi via la signora», nella sua superbia malata ghignò al pensiero di averla chiamata signora. «La mandi via, o sto male.» «E tu sei andata via e poi sei tornata», disse l’iroso avvocato, doveva tenersi le mani per non picchiarla, e non si era neppure accorto che le aveva dato del tu. «Sì.» Oh, come era tornata, e come aveva cercato di farlo passare in una camera a pagamento, senza che lui sapesse che la pagava lei, ma non ci era riuscita, e lui che cosa aveva fatto? Aveva, dal letto in cui era inchiodato dal suo fegato pesante e corroso, realizzato quelle poche, ultime azioni che gli restavano, in denaro liquido, per dei nuovi avvocati – l’avvocato grosso e il piccolo – perché lo liberassero finalmente dalla sua vergogna, agendo con la massima violenza consentita dalla legge, così aveva scritto, dal suo letto nella corsia comune, la mano guidata dal superbo Satana suo mastro, o suo discepolo?, ed ora lui, l’avvocato piccolo, aveva finalmente compreso, e doveva agire con violenza, era pagato per quello. «Vieni a casa mia», le disse rimettendo in moto l’auto. Lei non voleva, quando fu davanti al portone di casa sua si attaccò al volante e disse che non scendeva, che voleva essere riaccompagnata a casa. «Scendi, o ti riempio di schiaffi.» Con quel viso gocciolante sudore, nel vuoto sinistro della città abbandonata per ferragosto come per la lebbra, le fece paura, scese, salì in casa sua, lui quasi la buttò sul divano, andò nel cucinino e prese dal frigorifero la bottiglia di vino bianco, gliela posò davanti, sul tavolino, con forza, gli occhi rossi di ira – non sapeva perché, per una appena vista, dovesse arrabbiarsi così – le disse torvo: «Aspetta a bere, potrai bere dopo che ti ho parlato. Ti devo dire solo una cosa: hai voluto bene per tanti anni all’ultimo verme della terra, un verme pieno di superbia, che ti ha disprezzato e allontanato perché per lui eri una serva, e solo questo vedeva di te, e tutto il bene che gli volevi non lo ha mai visto e non lo vedrà mai, e lui non è che uno squallido ometto, un niente, sommerso in una superbia ridicola per un geometra fallito, finito in un fondo di ospedale, e non so se è più pazzo lui o tu, ma della sua pazzia non me ne frega niente, mentre della tua sì, anche se non capisco perché. E adesso sta’ attenta: o tu rimani qui, con me, stanotte e finché vorrai o vorrò io, o io ti faccio rinchiudere stanotte stessa al neurodeliri e poi al manicomio, così tuo marito sarà contento dei nuovi avvocati che ha preso. Mi basta una telefonata, guarda, sei ubriaca fradicia, sei quasi alcoolizzata del tutto, e così ti ha ridotta la superbia di tuo marito», allungò la mano verso il telefono, «ma io non ti lascio libera, non ti lascio tornare all’ospedale, dalla suora che ti vuole bene, e che te lo lascia vedere dall’ingresso della corsia, mentre lui fissa il soffitto, per non vederti: non ti lascio, hai capito?». Aveva urlato, senza accorgersene, ma lei ora sembrò non aver paura di quella voce irosa, lui ebbe paura soltanto che, se cedeva a quel violento imperio, se si abbandonava alla disperata dolcezza che le dava l’interesse appassionato di quell’uomo, dopo non avrebbe più potuto aspettare lui, suo marito. Lui lesse nel suo pensiero, divenne improvvisamente buono, come disfatto da quella esasperante pazzia di lei, posò il ricevitore: «Devi smettere di aspettarlo», le prese tutte e due le mani, «non si aspetta un verme», e la tenne così, per le mani, finché non sentì che lei gli si abbandonava addosso, respirando forte, come cominciasse a capire anche lei la verità. «Non devi più andare all’ospedale, a trovarlo.» «No, non andrò più.» «Non devi più pensarci, non ti vuole, non ti ha mai voluto.» «No», parlava abbastanza chiaramente, «non ci penserò più.» Forse questa volta, se lui l’avesse aiutata, sarebbe riuscita. Lui allora le versò da bere, e mentre le versava il vino pensava, e avrebbe voluto sfrenarsi a ridere forte, a quello squallido ometto che nella sua superbia ripudiava, ricacciava indietro, da anni, l’amore di una donna come lei; moriva, o quasi, superbamente, in una corsia d’ospedale, quarto letto, fissando il soffitto, pur di non vedere lei. Ma non rise, si mise a sedere sul divano vicino a lei, un braccio intorno alle sue spalle, aspettando che si addormentasse. 55 · L’ostaggio Alle undici si arrischiò ad andare a comperare i giornali. Guidò l’auto verso Latina, ma non entrò in città, appena vide un’edicola di giornali si fermò, e prima le disse: «Sta’ buona, non ho nessuna voglia di ammazzarti, ma se ti metti a gridare sono costretto a farlo. E abbassa il capo, c’è la tua fotografia su tutti i giornali, se ti riconoscono siamo finiti, tutti e due...». Scese coraggiosamente dall’auto e comprò tutti i quotidiani che avevano, voltando perfino le spalle a lei, così, se avesse voluto, lei avrebbe potuto scappare, ma lei sapeva che lui aveva la Browning, e sapeva che l’avrebbe usata senza sbagliare. Ma lei non si mosse, non gridò, nascosta dietro i grandi occhiali neri, il suo viso non era più nessun viso, basta così poco per non essere più riconoscibili, oltre al fazzoletto a fiorellini rossi in testa che le nascondeva il colore dei capelli. Lui risalì subito in macchina con il fascio dei giornali, ripartì calmo, non avrebbe mai dato l’idea di scappare, ripartì da turista prudente che in una bella macchina scoperta si fa un giretto dal Lido di Roma a Terracina, così, per passare il tempo, e se ne andò calmo fino al suo rifugio, che era il più semplice del mondo: un parcheggio lungo la via Pontina, un parcheggio così desolato, senza alberi, senza ombra, liquefatto dal sole incandescente, e per questo non c’era nessun’altra macchina, e potevano essere certi che mai nessun’altra macchina sarebbe venuta a parcheggiare, o meglio a fondersi lì, sotto quel sole. Loro sedettero in terra, all’ombra dell’auto: lei ubbidiva a ogni suo cenno e occhiata, come un automa. Lui cominciò a leggere i giornali, almeno i titoli. Dalla prima pagina la storia era passata alle pagine interne. I titoli erano ancora su quattro e anche cinque colonne. Un giornale pubblicava: Il bandito con l’ostaggio ha fatto perdere le sue tracce . Un altro giornale pubblicava: Ampia azione di rastrellamento nel Friuli per la cattura del bandito con ostaggio. Fu contento che lo credessero nel Friuli, lui era agli antipodi. Un altro giornale ancora pubblicava: La ragazza che il bandito porta con sé come ostaggio, Rachele Adaron, ha la madre malata di cuore e in questi giorni di angoscia si teme per la sua vita. Rachele leggeva anche lei il giornale a fianco di lui. Alzò le spalle. «Non è vero, non ha niente al cuore, lo ha detto ai giornalisti per montare l’opinione pubblica contro di te. Fa bene, così la polizia ti cerca meglio.» Sì, sua madre faceva bene, dal suo punto di vista. Per lui non era bene per niente. Lesse un altro poco. I carabinieri non possono usare i cani poliziotto perché si lancerebbero anche contro l’ostaggio. Questa era già una bella notizia. E ancora, in un giornale della sera in prima edizione, con titolo a tutta pagina: Rachele Adaron, l’ostaggio del pericoloso Richetto, è ancora viva? L’articolo diceva che si erano diffuse voci secondo le quali lui avrebbe ucciso Rachele che aveva tentato di sfuggirgli. «Ma questa gente non sa nulla, e inventa tutto», disse lui. Un cronista però doveva sapere qualche cosa perché aveva scritto: Richetto Novara, il bandito dell’assalto all’Istituto Ligure di Assicurazione, è riuscito a fuggire solo perché è aiutato da una vasta organizzazione che gli fornisce le auto e i soldi e i luoghi per un momentaneo rifugio. Questo era vero, ma solo in piccola parte: nessuno può fare miracoli, nascondere uno inseguito dai carabinieri e dalla polizia non è semplice: un nascondiglio fisso non è consigliabile, lo scoprono in due giorni. Bisogna continuare a correre, a sgambare, a spostarsi, e soprattutto ad arrangiarsi da soli, non poteva chiedere sempre nuove macchine a Gustavino, o farsi ospitare in qualche pensioncina sicura, che era sicura fino a un certo punto, e in ultimo diveniva una trappola. L’unica vera sicurezza per lui era la Browning che aveva in tasca, e quella ragazza: se tentavano di prenderlo, lui l’ammazzava, lei lo sapeva benissimo, per questo stava buona. Ma gli sarebbe dispiaciuto, a lui, di ammazzarla, anche quando a Genova, all’Istituto Ligure, l’aveva prelevata dall’ufficio cassa, dalla sua scrivania, quasi come i suoi compagni prelevavano le mazzette di diecimila, aveva avuto dispiacere di stuzzicarla così, alla gola, con la Browning, ma doveva coprirsi la ritirata con un ostaggio, perché quello non era mica un colpo in banca, le banche sono a pianterreno, ma una maledetta arrampicata fino al dodicesimo piano, dov’era l’ufficio cassa dell’Istituto, e avevano dovuto bloccare gli ascensori e scendere per le scale, con la ragazza dal viso minuto stretta alla vita, la rivoltella puntata contro le sue reni, e lei non sembrava per niente spaventata, non aveva gridato, non si era mai divincolata. In macchina, fuggendo per le salite e le discese di Genova, le aveva detto, guardando i suoi grandissimi occhi neri: «Sei indiana? Ho conosciuto una ragazza di Nuova Delhi che rassomigliava molto a te...». Lei aveva detto: «Sono ebrea». Gli dispiaceva averla presa come ostaggio, e gli dispiaceva non averla potuta rilasciare subito, come aveva in mente. Ma la polizia aveva incastrato l’auto coi suoi compagni e li aveva arrestati tutti. Lui che correva dietro a loro aveva fatto in tempo a invertire la marcia e a fuggire, e così teneva ancora la ragazza: un ostaggio può essere la salvezza. Lui si alzò e buttò i giornali in macchina. «Andiamo», disse. Stava in piedi, vicino a lei seduta in terra, dalla tasca laterale dei calzoni vicino a lei, lei vide luccicare il calcio della rivoltella. Fu un impulso irresistibile, affondò fulminea la mano nella tasca e afferrò la Browning. Una mano di lui afferrò la sua mano, l’altra le piombò pesante sul viso in uno schiaffo che era una mazzata e che per un momento le oscurò il mondo. «Ti credevo più intelligente, non dovevi farlo», lui disse rabbioso. «La prossima volta sei morta.» Lei inghiottì, per il dolore alla mascella colpita e accennò di sì. «Hai ragione, non dovevo farlo, sono stata una stupida», parlava sinceramente. «Sali, sbrigati.» Sapeva dove andare, glielo avevano detto al telefono, la sera prima, a Nettuno, ma non a fare i bagni: nella campagna intorno c’era una casetta, non una villetta, molto isolata, tra i piatti campi, nascosta da striminziti alberelli disseminati radi radi, ma che servivano a nasconderla, dallo stradone, alle macchine che passavano. «Lì potrai stare cinque o sei giorni, almeno finché non riusciamo a farti scivolare in Corsica. C’è anche il telefono, così ti avvertiamo noi se c’è pericolo...» Guidò piano verso questo rifugio seguendo mentalmente la via che gli era stata descritta al telefono, perché non poteva permettersi di domandare informazioni ai passanti. Doveva andare prima ad Acciarella, poi prendere lo stradone per Nettuno, poi doveva oltrepassare un autogrill, e voltare subito per la strada a destra, che non era neppure asfaltata: due chilometri avanti c’era la casetta, un vero e proprio cubo di mattoni, era servita un tempo all’ingegnere che dirigeva i lavori per la messa in opera dei cavi ad alta tensione, e consisteva soltanto in due camere e un gabinetto con doccia. Non fu facile trovarla. Sbagliò strada, ed era pericoloso per lui girare a quell’ora in cui tutti correvano verso le loro case o le trattorie per mangiare all’ombra e al fresco, con quella ragazza che era abbastanza di buon senso da stare quieta, ma abbastanza intelligente da saper cogliere la minima occasione di fuggire e mettere tutta la polizia sulle sue tracce. Finalmente trovò l’autogrill e subito dopo la svolta a destra, andò avanti piano, per la strada che sembrava di un secolo prima, bianca, sollevando ondate di polvere. Quasi in fondo vide gli alberelli radi radi e dietro di essi lui sapeva che vi era la casa, ma uno che fosse passato di lì in auto non se ne sarebbe accorto. Attraversò la fila di alberi sulla stretta stradina che conduceva direttamente alla casetta, sistemò l’auto dove gli era stato detto di sistemarla, di fianco alla casetta, dietro a un carretto, coperta col telone che era sul carretto. Trovò la chiave della porta, sempre come gli era stato detto, sotto un sasso vicino all’entrata, aprì e fece entrare per prima Rachele, poi entrò lui e richiuse la porta. Era tutto buio e terribilmente caldo, caldo da forno. Ma al telefono Gustavino si era spiegato bene: «Tieni tutte le finestre chiuse, non fare rumore, la casa deve sembrare disabitata, accendi la luce elettrica, ti abbiamo messo un poco di scatole sul tavolo, non telefonare mai tu, telefoniamo noi. Tieniti la ragazza, se ti scappa sei finito, non possiamo più aiutarti...». Richiuse la porta e accese la luce, una lampada senza paralume, squallida, sul tavolo, e vide lei che si teneva una mano alla guancia, ma la levò subito appena lui, alla luce accesa, la notò. «Ti fa male?» le chiese. Lo schiaffo che le aveva dato era stato piuttosto forte. Lei non rispose neppure, la bella carnosa bocca socchiusa per il caldo da fornace, col filo luminoso dei denti che l’attraversava, la tagliava, come un perlaceo fiume, e gli occhi scuri socchiusi, sembrava in un’espressione di sprezzo, ma lui non era sicuro che fosse sprezzo. «Dobbiamo stare qui chiusi e al caldo, mi dispiace», disse lui. Anche questa volta lei non rispose. Allora le disse: «Siediti». C’erano due sedie e una poltroncina di plastica tutta smangiata. Lei sedette su una delle due dure e polverose sedie, davanti al tavolo, ancora più polveroso. Ecco, il tavolo, Gustavino aveva fatto le cose per bene, il tavolo era pieno di scatolame, carne, sardine, frutta, e tante scatole di birra e un mucchio di buste di grissini. Non mangiavano dal giorno prima, a mezzogiorno, in certe condizioni non si può andare troppo in giro nei ristoranti, quelli della rapina in via Osoppo, a Milano, si erano fregati perché uno era andato a farsi fare un panino col prosciutto dal salumiere prima del colpo. «Mangiamo qualche cosa», lui disse. Si tolse la giacca e anche la camicia, il calore faceva venire le vertigini, il sudore gli colava dal torace, come colava dal viso di lei. «Speriamo che venga presto sera», disse, parlava sempre lui, lei, dopo lo schiaffo, non aveva detto più nulla. Gustavino aveva pensato a tutto, anche a quattro caricatori per la Browning, ma non aveva pensato all’apriscatole. Girando per le due magre stanze lui riusci a trovare un lungo chiodo, un pezzo di mattone e, miracolosamente, una pinzetta da meccanico, e con questi strumenti riuscì ad aprire diverse scatole, sia pure ferendosi alle mani, ma lei non volle niente, bevette solo un po’ d’acqua dal rubinetto, ed era nauseante, non solo perché calda, ma per un terribile odore di cloro, e stette seduta, il viso gocciolante di sudore, davanti a lui, che, affamato, mangiava tutta una grossa scatola di carne e un’altra di peperoni, poi vuotava le lattine di birra, anche se era disgustosamente calda, così, direttamente dal barattolo. D’un tratto, per un istante, la sentì ridere. Allora lui mise in bocca, con le dita, la manciata di carne in gelatina, perché non vi erano certo né posate, né bicchieri, masticò contemporaneamente un grissino, sempre fissandola, alla scialba, irrazionale luce artificiale di quella lampadina, in un mondo che fuori era affocato dalla calura di mezzogiorno. E, quando ebbe educatamente masticato tutto, le disse: «Perché hai riso?». I denti di lei avevano per lui una carica sensuale che non avrebbe immaginato. «Mi è venuto in mente», lei disse, rigida e gocciolante sudore dal viso, «che in italiano si dice andare al fresco per dire andare in galera. Io al tuo posto andrei subito al fresco...» A lui piacevano le donne spiritose, anche se quella spiritosaggine non gli piaceva troppo. Ma gli venne da ridere anche a lui, e disse: «Preferisco questo caldo». «Sono affari tuoi», lei disse laconica. Sì, erano affari suoi, lui pensò, sgranando un grissino dopo l’altro avvolto in una fetta di prosciutto di San Daniele in scatola. «Cosa vuoi dire, che dovrei costituirmi?» Non lo avrebbe mai fatto, ma voleva che lei parlasse, il silenzio di lei lo irritava. Parlasse di quello che voleva, ma parlasse. «Non sembri uno stupido, eppure fai le cose da stupido.» Lui spezzò bruscamente un grissino: non ricordava che mai altre volte gli avessero detto che era stupido. Troppo pericoloso dirglielo. Ma lasciò correre: era una donna che glielo diceva. «La prima cosa da stupido che hai fatto è di prenderti un ostaggio. Non hai pensato come ci sguazzano i giornalisti a scrivere di un bandito che fugge con una ragazza come ostaggio. Se fuggivi da solo, dopo tre giorni ti dimenticavano, invece con l’ostaggio sarai il fatto più importante del giorno fino al momento in cui ti arresteranno. Dopo lo sbaglio di prenderti un ostaggio, la seconda cosa stupida che hai fatto è stata quella di non esserti liberato subito di me. No, mi hai portato in giro per mezza Italia e, se io avessi gridato o chiamato aiuto tu saresti stato costretto a uccidermi, così il conto con la polizia diventava ancora più grosso. Adesso sei arrivato al risultato che i giornali insinuano che tu mi abbia uccisa e cercano il mio cadavere: così, senza avermi uccisa, sei già considerato un assassino. Questo è autolesionismo.» Lui cominciava a bollire. «Chiacchieri sempre così tanto?» «Sì, la mia famiglia è chiacchierona, vengo da gente chiacchierona, quando sono a casa non facciamo che chiacchierare», con le mani si asciugò, o meglio scolò, il sudore che le gocciolava sul viso. Lui si rabbonì. «Va bene, se ti va, chiacchiera...» Ricominciò, spietata e tagliente, ironica eppure quasi affettuosa. «Adesso avresti un’occasione per liberarti di me e per fare una bella figura di gentiluomo: mi lasci andare, così dimostri che non mi hai ucciso e che non sei quindi un assassino. Poi io dirò alla polizia che mi hai trattato come una principessa e che sei un bravo ragazzo, stupido, ma bravo.» Lui sussultò. «Non mi piace la parola stupido», disse come ringhiando. «Dovrai abituarti. È la parola che uso di più quando parlo con uno stupido.» Si irrigidì in attesa dello schiaffo, ma lo schiaffo non venne. «Vai avanti, chiacchierona», disse lui, poi subito tossì per la rabbia repressa. «Lasciamo andare, Richetto, non hai neppure il nome di un bandito, Richetto sembra il nome di un garzone di drogheria a Trastevere. Lo so che non mi lascerai andare, perché sei stupido. Gli stupidi infatti non si fidano. Tu hai paura che se mi lasci andare io corro subito in polizia, dico subito che sei qui, e così ti arrestano subito. Senti bene, Richetto», lei smise il tono ironico, «lasciami andare, io non ti denuncio subito, prendo invece il treno per Venezia, vado a Udine, prima di denunciarti, la polizia ti cerca nel Friuli e allora io ti denuncio lì, a Udine, dico che tu sei lì, nella zona, che sono riuscita a scappare da te e racconto un sacco di storie su dove mi hai portata in questi giorni per metterli fuori traccia. Così tu avrai tutto il tempo per fuggirtene in Corsica, l’ho capito benissimo dalle telefonate che hai fatto che è la Corsica l’ultima tappa...» Lui aveva smesso di mangiare e di bere e non fumava neppure. Rifletteva. Era un piano attraente: se lei davvero avesse messo fuori strada la polizia lui avrebbe avuto quei tre o quattro giorni di respiro che gli occorrevano per andare in Corsica. «Ma tu non ti fidi, vero? Tu pensi che io ti dica così, ma che poi ti denuncio subito appena fuori di qui, e dico la verità alla polizia, invece che metterla fuori strada. È così?...» «È così», lui assentì. «E poi penso un’altra cosa: perché lo faresti?» Lei non gli rispose, lo fissò soltanto, e la risposta del perché era nei suoi occhi: senza parole. Allora lui si alzò, molto lentamente, le si avvicinò, continuando a leggere in quegli occhi quello che lei gli diceva, così appassionatamente e apertamente, e allungò una mano per farle una carezza sul viso, ma lei si scostò e si alzò di scatto. «Vado a fare una doccia», disse. Era troppo sudata per farsi accarezzare. Lui la seguì con lo sguardo, poi col chiodo fece altri due buchi in una scatola di birra e bevette qualche sorso, poi ascoltò il fruscio dell’acqua della doccia che veniva dallo stanzino alle sue spalle. Poi aprì di colpo la porta dello stanzino e la guardò. «Lo sapevo che avresti fatto così», lei disse sotto il getto dell’acqua. Richetto Novara si risvegliò sul lettino, sussultando, non era neppure un lettino, era un materasso di plastica lasciato lì perché troppo corroso, macchiato e bucherellato per traslocarlo. Lei era distesa vicino a lui. «Avevi paura che fossi fuggita?» lei disse. Lui le appoggiò un braccio sul petto e nascose il viso nei suoi capelli. «Sì», disse. Lei mormorò con amarezza: «Vivi sempre nella paura, hai sempre paura di qualche cosa, anche prima, sembrava che tu mi carezzassi con la Browning, non con le mani, mi amavi, ma avevi paura di me». Alla parola Browning, lui allungò subito una mano in terra, verso la scarpa nella quale aveva nascosto la rivoltella. Ma non trovò nulla, e nello stesso tempo sentì lei che scattava via da quel pagliericcio, e balzava in piedi. Non aveva nulla indosso, escluso la Browning che gli puntava contro. «Sì, è così», gli disse, vedendo la smorfia di disprezzo nel suo viso, «la prima cosa che dovevo fare era di levarti questa rognosa rivoltella, a qualunque costo e con qualunque mezzo.» «Sei la solita...» e le disse l’ingiuria più scurrile del genere. «Non è così, ma non importa. Non mi crederai mai, ma a questa credi», lei disse. «Stai lontano da me e vestiti.» Anche lei si allontanò da lui, perché lui non tentasse di strapparle d’improvviso la rivoltella e si rivestì rapidamente. Avevano appena finito che squillò il telefono. Lui corse nell’altra stanzetta e lei lo seguì. Udì tutta la breve conversazione. «Pronto?» diceva la voce che veniva dal microfono, nitidissima. «È meglio che te ne vai subito da lì, non è posto sicuro.» «Ma perché?» disse Richetto. «Ho detto subito, va’ via subito», disse la voce dal microfono, era Gustavino, «telefona stasera alle nove il più lontano da lì e intanto ti troverò un altro buco dove sistemarti...» Gustavino riattaccò, doveva avere molta fretta. Lui si volse, l’occhio rosso di furore perché si sentiva in pericolo e perché vedeva lei con la rivoltella puntata. «Dammi quella roba», le disse avvicinandosi di un passo, «dobbiamo andar subito via di qui e non posso perdere tempo a giocare a guardie e ladri con te.» «Fermati perché faccio sul serio», lei disse. «Sono abituata a sparare fin da quando avevo nove anni, tu non sei mai stato a faccia a faccia con un arabo che ti vuole sfondare la faccia col calcio del fucile, ma io sì, e ho imparato così a sparare. E se non fai quello che ti dico io, sparo.» Solo guardandola negli occhi, capì che era esattamente così: avrebbe sparato. E allora non si avvicinò oltre a lei. «Se i tuoi amici ti hanno avvisato di andar subito via di qui», lei disse, «vuol dire che il posto non è più sicuro.» Lui sorrise, sprezzante: straordinaria deduzione. «Se il posto non è sicuro, vuol dire che qualcuno ha informato la polizia che tu sei da queste parti e non nel Friuli, dove ti stanno cercando. Questo va molto bene per te.» Questa volta lui non sorrise, rise apertamente, anche se brevemente. «Non ridere: va bene per te perché così non mi occorre andare fino a Udine per mettere la polizia fuori strada: basta che esca di qui, che vada alla prima stazione di carabinieri, e racconto quello che voglio io. Ho già pensato che cosa devo dire, sai, tu dormivi e io pensavo, e io dirò che tu mi hai portato ad Anzio, dove c’era un piccolo yacht, e sei salito su quello, e che poi un tuo amico mi ha portato qui, vicino a Nettuno e lasciata libera...» «E la polizia crederà a una storia simile?» lui disse sarcastico. «Sì, e per due ragioni. La prima è che la racconto io, questa storia, e io sono l’ostaggio. La seconda è che avendo saputo che sei da queste parti, immaginano facilmente che ci sei perché vuoi scappare in Corsica.» «E io che cosa dovrei fare?» lui domandò, quieto. Ogni tanto guardava la Browning che lei teneva in mano, ora non puntata verso di lui, ma a canna in giù, verso terra. «Tu vieni con me, ti porto in auto a Nettuno, prendi la corriera per Roma, e vai a Roma dai tuoi amici, in casa loro, diretto dentro la loro casa, perché quello è l’unico nascondiglio sicuro: dovranno salvarti, per salvare loro stessi.» «E secondo te un uomo inseguito da tutta la polizia può girare per le corriere e andarsene a Roma, così alla buona?» La derideva. Lei restò seria, non si offendeva. «Sì, se ti metti quella tuta, appesa a un chiodo, e vai in giro con quella borsa di attrezzi sfondata, e ti sporchi un po’ le mani. Così loro ti cercheranno in mare, verso la Corsica, e invece tu sei a Roma, e a Roma non si trova mai nessuno.» Lui guardò istintivamente la vecchia tuta appesa a un chiodo e, in terra, la sventrata borsa d’attrezzi vuota, residuato di quando l’ingegnere era lì coi suoi operai. «E come fai a essere così pratica di queste cose?» Lei gli sorrise, quasi con dolcezza. «Perché i miei genitori, i miei nonni, e tutta la mia gente, tante volte abbiamo dovuto fuggire, nasconderci, e io ho sentito tanti racconti e so come fare...» Adesso lui cominciò a capire che cosa voleva lei: portarlo fuori di lì con la scusa di salvarlo e filare diritto in polizia. Sapeva recitare molto bene, anche prima lo aveva quasi convinto che era sincera, gli si era abbandonata, e invece gli aveva preso la rivoltella. Guardò ancora la Browning. «No, Richetto, cerca di essere intelligente», disse lei intuendo i suoi pensieri, e puntandogli ancora la Browning contro, «non saltarmi addosso per portarmi via la rivoltella, perché sparo.» Ma non fece in tempo a finire di parlare che lui le si buttò addosso. E lei sparò. Aveva sparato basso, ma una pallottola in una coscia è sempre una pallottola in una coscia, lui cadde in ginocchio e si appoggiò a terra anche con le mani. «Perché sei così stupido?» lei disse, con voce improvvisamente acuta, isterica, e spezzata dalla disperazione. «Io volevo salvarti, se avessi voluto consegnarti alla polizia bastava che telefonassi. Adesso non posso fare più niente per te...» Ma lo aiutò a distendersi in terra e gli guardò la ferita: il proiettile tamponava perfettamente la ferita, usciva solo pochissimo sangue. E intanto continuava a sgridarlo e a insultarlo. «Hai rovinato tutto, ero così contenta che tu riuscissi a scappare, a fargliela alla polizia, sei il più grosso stupido che abbia conosciuto, ma non sei un farabutto, se no non sarei stata con te», gli occhi le divenivano umidi, «e adesso è finita, non hai più nessuna speranza.» Si mise a piangere a viso aperto, infantilmente, tirando ogni tanto su col naso. «Adesso non ti resta che continuare a fare il bandito con l’ostaggio», gli gettò in terra, quasi addosso, la rivoltella. «Tieniti la tua Browning, signor Richetto, avanti, alzati, ce la fai benissimo, ho visto dei sabra con le gambe riempite di schegge di una bomba araba, che camminavano benissimo, non sarà quel sassolino nella coscia che t’impedisce di camminare, alzati e fai il bandito, tu credi solo al pum pum: eccolo, adesso ce l’hai...» Infatti lui aveva preso subito la Browning, poi tentò di rialzarsi: fu difficile, e doloroso, ma ci riuscì. Lei stava a guardarlo, ferma e colante lacrime senza aiutarlo. In un certo senso camminare fu più facile. Agitando la Browning davanti a lei, disse: «Usciamo, tira fuori la macchina e mettiti al volante». Tra le lacrime lei trovò una nota di sarcasmo. «Sì, signor bandito.» Dovette appoggiarsi a lei per camminare, le strinse il braccio, finché non furono in macchina, finalmente al sole, anche se al caldo rovente del mezzo pomeriggio, finalmente all’aria libera. «Dove devo andare?» lei disse. «Al primo bar che trovi, voglio bere qualche cosa di forte.» «Ma non puoi girare per i locali pubblici», lei disse. «Cerca un bar e basta.» Solo dopo una diecina di minuti trovò un locale, più osteria che bar. «Portami un mezzo bicchiere di cognac», lui disse. Lei entrò nell’osteria, ritornò poco dopo vicino all’auto col cognac. «Non fermarti troppo, cominciano a guardarci», lei disse. Lui sorrise con sprezzo, ma questa volta sprezzava sé stesso, infinitamente. Era proprio stupido, non aveva capito nulla di lei, della sua sincerità, del suo impulso generoso e istintivo. Lui capiva solo la Browning. Lei voleva salvarlo e l’avrebbe potuto, e lui era stato troppo stupido per crederle: gli stupidi non si fidano di nessuno, e aveva ragione lei di dirlo. «Vattene, non mi servono più ostaggi, via...» le disse duro. «Cosa vuoi fare?» «Sono affari miei. Va’ via.» «Ma non puoi guidare la macchina, non puoi camminare, dimmi che cosa vuoi fare.» Allora lui disse quello che veramente sentiva: «Voglio solo che tu vada via, mi vergogno a vederti, mi vergogno di me. Vai via, così almeno mi passa...». Lei capì che finalmente lui aveva capito, e ne fu roventemente felice, ma gli disse: «No, non vado via, se non mi dici che cosa vuoi fare, qui, su questa auto, immobilizzato, davanti a questo locale». «Volevo solo farmi tre o quattro bicchieri, o cinque per dormire, e poi stare qui. Una volta o l’altra qualcuno mi riconoscerà, o riconoscerà te, siamo famosi come Caterina Caselli e Little Tony, le foto su tutti i giornali, chiameranno la polizia e verranno a prendermi. Non ho voglia di sprecare un gettone per farmi arrestare. Che vengano loro ad arrestarmi, io non scappo, non sparo, guarda, scarico la Browning.» Lei assentì. Questa volta lui era saggio, e non stupido. «Voglio restare con te, fino all’ultimo.» «Se ti piace.» Lei andò a prendere ancora da bere e salì in macchina accanto a lui. Piangeva. 56 · La spirale L’uomo e la donna erano seduti sul letto. Non erano molto vestiti, quasi niente lui, niente lei. Dalla finestra della villetta appena sotto Superga nonostante una leggera foschia si vedeva tutta Torino e il nastro del Po. Nella modesta ma comoda stanza da letto le voci dei due che parlavano risuonavano sordamente agitate. Poi l’uomo dette un violento schiaffo alla donna, lei si coprì il viso con le mani, ma fu inutile, l’uomo continuava a colpirla con tutta la sua forza, poi coi pugni. Era molto alto, robusto, il viso rosso di collera. D’un tratto la donna smise di difendersi e crollò a terra vicino al letto. Allora lui si inginocchiò davanti al corpo della donna, la scosse, le sollevò una palpebra, e capì. La donna era morta. Si alzò, si coprì il viso con le mani poi se lo scoprì e sedette sul letto. Guardava il corpo della donna morta per i suoi pugni. Sapeva di essere un violento, ma non fino a quel punto. Pensò, continuò a pensare finché non si alzò, si rivestì, uscì. Da lì, su un’auto parcheggiata in un piccolo spiazzo, scese con prudenza sullo stradone e si diresse verso Torino, L’auto era una 850 blu. Un modesto appartamento in corso Unione Sovietica. Un tardo pomeriggio di sole ancora freddo ma luminosissimo. A una finestra stava un uomo, si vedevano solo le larghe spalle e la testa grossa, il collo un po’ corto. Poi si volse: «Ehi, siete pronte?». Aveva lo stesso profilo, lo stesso viso dell’uomo che aveva ucciso quella donna a pugni. «Altrimenti arriviamo a Superga che è quasi buio e sarebbe un peccato, perdiamo tutto questo sole.» «Siamo pronte, Erberto.» Nella sala entrò una giovane donna, non era molto bella ma era alta, elegante e aveva dei grandissimi occhi verdi. Era la moglie del dottor Erberto Socchetto, modesto medico chirurgo. Entrò anche una bambina di sei anni, alta, dai grandi occhi verdi, la copia in piccolo di sua madre. L’anno prima aveva cantato allo «Zecchino d’Oro» e la sua canzone aveva avuto molto successo. Si chiamava Nicoletta. «Brava», disse il dottor Erberto, uscendo, a sua moglie. «Senti, Lorenza, ti sei ricordata di comprare le pile per la radio? Domenica scorsa già non funzionava quasi più.» «Certo, le ho nella valigetta.» Dabbasso c’era una 850 blu scuro. Vi salirono. Il traffico si snodava a fatica e così arrivarono un po’ tardi. Il dottor Erberto parcheggiò l’auto nella piccola piazzuola accanto alla villetta, poi aprì il portoncino. Prima di entrare disse alla moglie e alla figlia: «Guardate laggiù Torino che meraviglia». Poi entrò. «Dammi le pile, così intanto che voi mettete un po’ in ordine, io cambio le pile.» «Eccole», gli disse con tono tenero e felice Lorenza. Seduto vicino alla finestra, il dottor Erberto si mise a cambiare le pile dando ogni tanto un’occhiata al panorama nel cielo adesso completamente rosso che tendeva però un poco a illividirsi. Era arrivato a sistemare le pile e accese la radio per provarla. La radio suonò subito nitidissima, era un programma di musica da ballo. Aveva appena ascoltato qualche battuta del motivetto che un urlo quasi disumano di sua moglie lo interruppe. «Erberto, Erberto, vieni!» gridava Lorenza, e il suo urlo veniva dalla stanza da letto. Accorse dimenticandosi di spegnere la radio e sua moglie intanto usciva dalla camera. Gli occhi allucinati dal terrore, la voce singultante, disse: «Guarda lì, guarda lì». Spinse indietro Nicoletta perché non vedesse un’altra volta e tutt’e due, lei e suo marito guardarono. Il dottor Erberto vide in terra, vicino al letto, un poco raccolto su sé stesso, il viso orrendamente sfigurato da orrendi colpi, il corpo di una donna nuda. S’inginocchiò vicino a lei, non la toccò, la guardò soltanto. «È morta. Bisogna chiamare la polizia. Voi andate in cucina e bevete un po’ di cognac, anche tu, Nicoletta, mezzo cucchiaio.» Tornò nella sala e solo allora si accorse che la radio suonava ancora. La spense, poi cercò nell’elenco telefonico il numero della polizia. Lo compose, non dovette attendere neppure un istante. Una voce d’uomo rispose: «Polizia». «Ho trovato una donna morta nella mia villetta qui a Superga. È morta. Io sono il dottor Erberto Socchetto.» «Mi dia il suo recapito esatto e il suo numero di telefono.» Il dottor Erberto glieli dette. «Adesso deponga il ricevitore che la richiamo fra un istante.» «Bene», lui depose il ricevitore. Si passò la mano sul viso massiccio una, due volte. Stava per passarsela la terza volta quando il telefono squillò. «Il dottor Socchetto?» «Sì, sono io.» «Polizia, veniamo subito.» Il dottor Erberto andò in cucina. Sua moglie Lorenza e la bambina sedevano al piccolo tavolo, erano pallide, ma non piangevano e non erano più terrorizzate come prima. Sedette anche lui tra di loro. «Vengono subito, calmatevi. Ci sono qui io, non dovete avere paura.» Bevve un poco di cognac nel bicchierino della moglie. Poi cominciarono le angoscianti, lunghe, irritanti formalità volute dalla legge, le ricerche, le inchieste e gli interrogatori. Dal dottor Socchetto l’inquirente seppe assai poco. «Appena il lavoro me lo permette, io vado con mia moglie e la mia bambina nella nostra casetta a Superga...» disse il dottor Socchetto. «E l’ultima volta quando c’è stato?» domandò l’inquirente. «Sabato scorso, oggi sono tornato e ho trovato il cadavere di quella donna.» «Senta, dottore, lei usa prestare le chiavi della sua villetta a qualche parente o amico perché vi passi qualche giorno?» «Oh, no, assolutamente.» «Glielo domandavo perché, siccome la serratura della porta d’ingresso della sua villetta è intatta, poteva essere che quell’amico o conoscente sapesse qualche cosa sull’uccisa.» «Le ripeto che non ho mai prestato a nessuno le chiavi della villetta.» «Lei non ha mai visto nei paraggi della sua villetta questa donna? Potrebbe essere l’inquilina di una villa vicina.» «Non credo proprio. La villa più vicina è a duecento metri. Non si fanno molte passeggiate su quei ripidi pendii.» «Va bene, forse dovrò farle delle altre domande. Le sarò grato, dottore, se potessi reperirla subito.» «Certo, basta che mi telefoni nel mio studio.» «Grazie», disse l’inquirente. Poi la perizia medica. Punto primo: la donna era morta non più di tre giorni prima del ritrovamento del suo cadavere, cioè al massimo mercoledì. Punto secondo: aveva ricevuto dei colpi in faccia ma non sembrava un corpo contundente e nudo, forse un bastone rivestito di gomma o forse dei pugni. Questi colpi però non potevano aver provocato la morte direttamente, anche se avevano inferto ferite gravissime, la morte doveva essere sopravvenuta per trauma cardiaco in seguito al terrore e al dolore per quelle selvagge percosse. Punto terzo: non si conosceva l’identità della donna. La borsetta non conteneva documenti né agende, né altro che potesse portare alla sua identificazione. Conteneva delle chiavi, i soliti rossetti, astucci, scatoline, duemila lire e qualche spicciolo, un fazzoletto. Poi la perquisizione nella villetta. Tutto era stato trovato a posto: la serratura non era stata scassinata, nell’interno della villetta tutto era in ordine, non c’era un cassetto aperto e non mancava nulla. Il problema era questo: una donna era stata assassinata nella villa del dottor Socchetto. Non si sapeva nulla di questa donna. Il dottor Socchetto dichiarava di non averla mai vista. Non si sapeva quindi perché uno sconosciuto assassino fosse andato ad ammazzare quella donna, o ne avesse portato il cadavere, proprio nella villa del dottor Socchetto. La prima strada e la più urgente per arrivare alla soluzione era di sapere chi fosse la donna. Conosciuta la sua identità, si sarebbe fatta un po’ di luce. Allora nugoli di poliziotti si dettero alla caccia in tutti gli ambienti di Torino mostrando la foto di quella donna, ma i giorni passavano e non si trovava nulla. Nello stesso tempo l’inquirente interrogò ancora due volte il dottor Socchetto. Furono interrogatori serrati con domande trabocchetto e, per quanto l’inquirente non credesse alla colpevolezza del dottor Socchetto, pure fece il suo penoso dovere e torturò per diverse ore il giovane e robusto medico. Ma c’era un muro contro questa ipotesi: uno non ammazza una donna, poi dopo un paio di giorni porta la moglie a vederne il cadavere e avvisa la polizia. Più che audace, questo piano sarebbe stato schizofrenico. In tutte le lunghe ore d’interrogatorio le risposte del dottor Socchetto non ebbero mai incertezze, mai la minima contraddizione. L’inquirente lo lasciò andare pur pregandolo di restare a disposizione della polizia. «Certamente», rispose il dottor Socchetto. Era un tardo dolce pomeriggio. Lorenza Socchetto era in cucina e cominciava a preparare il pranzo. Nicoletta era nella sua stanzetta. Suonò il campanello e Lorenza andò ad aprire. Fuori della porta c’era un giovane. Piccolino, bruno, era già in maglione senza giacca come fosse primavera avanzata. «C’è il dottor Socchetto?» disse con fortissimo accento napoletano. «No.» A Lorenza l’uomo non piaceva, lo tenne sulla porta. «Lei è sua moglie?» «Sì.» «Signora, mi lasci entrare, le devo parlare della morta che è stata trovata nella vostra villetta. È suo marito che l’ha ammazzata...» disse il giovane. Non parlava neppure a voce troppo bassa. Sconvolta, terrorizzata, Lorenza pensò che era meglio lasciarlo entrare. Il giovane entrò. Non si sedette, andò molle alla finestra. «Lei è pazzo», disse Lorenza con la voce strozzata. «Mamma, guarda che cosa ho disegnato», disse Nicoletta, entrando nella sala con un foglio dipinto. «Per favore, Nicoletta, devo parlare con questo signore, torna nella tua cameretta, lo guarderò dopo», disse lei vicina alle lacrime. «Io non sono pazzo», disse il giovane. «E glielo dimostro subito. È vero che l’anno scorso suo marito andò a Napoli per il congresso di medicina, e precisamente dal 10 al 30 aprile?...» Lorenza sedette. Non era. più capace di stare in piedi. Era vero, lo ricordava benissimo perché aveva sofferto molto di stare tanto tempo senza di lui. Annuì: era vero. «È vero che suo marito le telefonò una sera che sarebbe rimasto ancora quattro o cinque giorni perché c’era il primario di una clinica che voleva assumerlo come suo vice?» Era vero e Lorenza annuì ancora disfatta. «Senta, signora, io non so se lei lo sappia ma a suo marito piacciono molto le donne ed è anche un po’ viziosetto. Per questo, a Napoli, non si limitò a partecipare alle riunioni del congresso ma cercò anche di divertirsi. Per sua sfortuna incontrò una cattiva donna, una vera cattiva femmena, vede che glielo dico io per primo. Oltre che donnaccia era anche ladra, ricattatrice, senza nessuno scrupolo morale. Ma si vede che a suo marito piaceva.» «Ma perché mio marito l’avrebbe uccisa?» «Perché lei è venuta su a Torino per ricattarlo. Voleva un poco di soldi, esattamente due milioni. Lo so bene perché Danielina me l’ha confidato e mi ha detto che mi avrebbe regalato un orologio nuovo d’oro. Se suo marito non le avesse dato quei due milioni, Danielina sarebbe venuta da lei, signora, e le avrebbe raccontato tutta l’avventura galante del congresso, poi avrebbe fatto grosse scenate alla napoletana nel suo studio, in clinica, all’ambulatorio...» Una lunga pausa, poi l’uomo ricominciò a parlare. «Lo avrebbe moralmente rovinato. Suo marito forse al principio pensò di darle i due milioni e liberarsene, ma poi comprese che era inutile. Se le dava i due milioni, Danielina dopo un poco ne avrebbe chiesti altri due e così all’infinito. Ma non aveva scelta, o glieli dava per evitare lo scandalo che lei avrebbe provocato, o l’ammazzava. E ha scelto di ammazzarla, visto che Danielina è stata trovata morta a casa sua.» Il giovane si accese una sigaretta: «Signo’, quando torna suo marito?». A Lorenza occorse un po’ di tempo prima di rispondere per riprendersi dallo sconvolgimento, poi disse: «Domattina. Per il turno di notte in clinica non torna a casa stasera». «Bene, gli dica che torno qui domattina alle dieci, gli voglio parlare. E che si faccia trovare, è meglio per lui.» E il giovane uscì. Erano le sette e mezzo della mattina dopo. Lorenza piangeva seduta, disfatta. Davanti a lei in piedi era suo marito. «È vero tutto quello che mi ha raccontato quell’uomo?» disse. «Tutto vero.» Lorenza si asciugò le lacrime: «Ma perché l’hai uccisa? Va bene, io avrei sofferto molto nel sapere che a Napoli mi avevi tradito con un’altra. Ci sarebbe stato un po’ di scandalo, certo, ma quasi tutti gli uomini quando sono lontano dalla moglie ne combinano qualcuna. Non sarebbe stato niente di veramente grave. Non c’era bisogno di uccidere.» «Ma io non volevo ucciderla. Mi ha fatto arrabbiare, mi è venuto un colpo di furia e l’ho colpita. Quando mi sono ripreso era morta», disse il dottor Erberto. «Volevo costituirmi subito, ma al pensiero di te e di Nicoletta sole mentre io ero rovinato per sempre non ho resistito. Volevo difendermi fino all’ultimo per difendere anche voi. Allora ho levato dalla borsetta i documenti, in modo da rendere difficile l’identificazione, la ragazza veniva da Napoli, era ben difficile che la polizia di Torino riuscisse ad arrivare fin laggiù. E non ho fatto altro. L’ho lasciata lì com’era. Al sabato vi ho portato alla villetta, saresti stata tu che avresti scoperto il cadavere, com’è avvenuto. Nessuno avrebbe potuto credere che un uomo ammazza una donna nella sua villa, la lascia lì, e poi porta la moglie a vedere il cadavere e telefona alla polizia. E infatti nessuno ci ha pensato.» Si passò una mano sul viso. «Ma adesso è arrivato questo ricattatore...» Alle dieci, puntuale, il piccolo bruno napoletano. Andò ad aprire lui e lo fece entrare. «Il dottor Socchetto?» «Sì, sono io. Scendiamo per parlare», disse lui. «E perché non parliamo qui?» disse il giovane. «Perché qui ci sono mia moglie e mia figlia e noi dobbiamo fare dei discorsi molto delicati.» «Per me, parliamo pure dove volete, basta che parliamo.» Scesero. Da basso era parcheggiata la 850. Salirono. «Facciamo un giretto fino al Valentino», disse il dottor Erberto. «Intanto dica pure quello che vuole.» «Trenta milioni», disse il giovane, poi, intanto che lui guidava in silenzio, gli spiegò con prolissità napoletana che era il minimo che poteva chiedere, che lui era un ricattatore onesto, che se lui gli avesse dato quei trenta milioni, lui non si sarebbe fatto vedere più. La noia dei discorsi dei farabutti. Il dottor Erberto entrò nel Valentino. «Io non ho trenta milioni», disse. «Gliene posso offrire al massimo dieci e subito, facciamo ancora in tempo ad andare in banca. Se no, mi denunci pure e torni a Napoli senza una lira.» Doveva difendersi e difendere Lorenza e Nicoletta fino all’ultimo. «Dieci milioni? Dottò, ma lei scherza. Io quando dico trenta, vuol dire trenta.» Doveva difendere Lorenza e Nicoletta sino all’ultimo. Fermò l’auto in un angolo solitario. «Allora senta», disse cortese, «possiamo fare così...» Un omicidio o due omicidi fanno lo stesso per la legge. Il dottor Erberto tornò a casa alle undici e mezzo. Lorenza gli aprì la porta e lo fissò. «Voleva trenta milioni», disse lui. «Gliene ho offerto dieci e se li è presi. Non avere paura, Lorenza.» La mattina dopo i giornali pubblicavano la notizia che una coppietta aveva trovato in un grosso cespuglio decorativo il cadavere di un giovane piccolo, bruno, che indossava un maglione senza giacca. Era stato strangolato. Indosso non aveva nessun documento. Pioveva molto forte quella sera. Erano le otto passate. Il dottor Erberto Socchetto stava levandosi il camice, nell’ambulatorio non c’era più nessuno, ma d’improvviso si aprì la porta ed entrò l’infermiera. «Ne è arrivato ancora uno, insiste per farsi ricevere», disse. Il dottor Erberto si rimise il camice. Vide entrare un ragazzo piccolo, bruno; col maglione, sembrava la copia di quell’altro della settimana prima. Ma forse era una combinazione. «Si sieda...» disse al ragazzo. «No, io sto in piedi», disse quello con profondo accento napoletano. «Io sono amico di Danielina e tu me l’hai ammazzata. Sono anche amico di Peppinello che è venuto qui a parlarti e mi hai ammazzato anche quello. Non credere di fare lo stesso scherzo con me perché io ho il coltello», lo tirò fuori. «O mi dai quaranta milioni o vai in galera tutta la vita...» Il dottor Erberto cercò di trattenere il riso. Ma poi non ci riuscì. Dopo aver ammazzato Danielina, aveva dovuto eliminare Peppinello, e dopo Peppinello avrebbe dovuto disfarsi di questo col coltello, ma poi sarebbe stata la volta di un quarto, un quinto. Rise sino alle lacrime. Fu tra un singulto d’ilarità e l’altro che disse al ragazzo: «Aumentate sempre la cifra?...» poi si calmò, anche se le lacrime continuavano a scivolargli sul viso. «Allora», disse, «la polizia la chiami tu o la chiamo io? Fa’ tu, per favore, io sono stanco. Se puoi risparmiarmi una fatica in più...» 57 · La confessione «Sai, caro», disse lui al suo ragazzo, che era un ragazzo anche se aveva ventisei anni, dal suo letto dove ormai giaceva da settimane, «se mi succede qualcosa, la povera Carla rimane sola, con due bambini, e non ho potuto né sposarla, né dare il nome a quei due innocenti...» «Papà...» disse il ragazzo, interrompendolo, a capo basso per non guardare il viso del padre corroso dalla malattia. «Se avessi potuto almeno dargli il nome, a quelle due creature», continuò lui. «Carla non me ne parla mai, ma lo so quanto ci soffre, dopo tanti anni che siamo insieme, non ha avuto che tristezze da me.» «Papà...» lo interruppe ancora il ragazzo. «È stata sempre nascosta come una colpevole, poverina, perché non potevo sposarla», continuava lui, forse senza ascoltarlo, o senza udire. «Papà...» disse il ragazzo, interrompendolo di nuovo, nervoso, «puoi sposarla, se vuoi, la mamma è morta.» Lui tacque di colpo, non capiva, poi capì. «Oh, poverino», disse, «e tu sei venuto qui, a trovarmi, tutti questi giorni, anche se avevi la mamma malata, e poi è morta, e il funerale, e non mi hai detto niente perché ero malato anch’io.» «No, papà», disse il ragazzo, le mani sulle ginocchia, rigido, «mamma è morta quattro anni fa, ma io non volevo che tu sposassi Carla, mamma ha sofferto tanto per lei, e non ti ho detto che mamma era morta. Tu mi domandavi ogni tanto come stava, non la vedevi mai, e io ti dicevo che stava bene, così tu non sapevi di essere vedovo e non potevi sposare Carla, ma adesso la puoi sposare.» Non gli chiese perdono: la sua voce lo chiedeva, da sola. 58 · Poi il silenzio Una macchina rallentò nella nebbia davanti alla sbarra di confine. Dal finestrino dell’auto si sporse un braccio d’uomo che nella mano teneva due passaporti. Il milite prese i due libretti, li aprì, li sfogliò, attraverso la nebbia e le altissime montagne bianche di neve anche in quel mese di luglio, traspariva ogni tanto il sole. Il milite ridette i passaporti alla mano fuori del finestrino dell’auto e fece segno al suo collega di alzare la sbarra. La macchina passò. Si udì per un poco, sempre più tenue, da rombo a ronzio, il suono del motore. Poi silenzio. Dopo mezz’ora passarono due escursionisti tedeschi, una coppia di cui non si distingueva chi fosse la donna, tutti e due in calzoni. Poi, mentre nella casermetta stava facendo colazione coi suoi due colleghi, il milite sentì arrivare una macchina, e andò fuori. Era una potente auto a due posti, schiacciata come una cimice. Un braccio si sporse dal finestrino, la mano tese due passaporti. Il milite prese i passaporti, li guardò, guardò nell’interno: al volante c’era un vecchio dall’aria robusta, abbronzato di montagna e giovanile, corrispondeva alla foto, il più grosso, ricco, importante ingegnere e donnaiolo della regione, e accanto a lui, l’aveva già visto prima del passaporto, il milite riconobbe la propria moglie, da cui era separato da anni, che da anni non vedeva e che, in quella gelida solitudine montana, tante volte aveva sognato di rivedere, se fosse stata meno infedele. Non aveva nulla da dire, o molto, ma sarebbe stato inutile dirlo, restituì i passaporti alla mano tesa fuori dal finestrino e fece alzare le sbarre. L’auto attraversò il confine, il milite rimase ad ascoltare, il rombo, poi il ronzio, poi il silenzio. 59 · Appena gliel’ho detto Il giovane era grassoccio, parlava quasi piagnucolando, ma con una certa dignità. «Appena gliel’ho detto, ha lasciato tutti gli altri, e ha cominciato a venire con me...» «Chi sono questi altri? E che cosa le avete detto?» urlò il vicebrigadiere. «Aveva sempre intorno tutti gli altri», il giovane disse, mite, «a me non mi guardava neppure; sono piccolo, grasso, io non so fare niente, non so neppure giocare a bridge... Gli altri corrono in macchina, io, più che a novanta non vado, gli altri sono sub, sono tennisti, ci sono due che sanno lo judo, e lei correva appresso a quegli altri e non mi guardava mai, tutti gli altri andavano a letto con lei e io solo no... Uno era stato a un safari e aveva ucciso un leone, e allora lei andò con quello lì. Tutti gli altri facevano tante cose che io non so fare e lei andava con loro... E allora io gliel’ho detto, e lei da quel giorno è venuta solo con me, e ha guardato gli altri come se fossero cretini...» Il vicebrigadiere urlò ancora: «Che cosa le avete detto?» «Che avevo preso il fucile a cannocchiale di mio padre», disse il giovane. «Lo avevo fatto per lei, così capiva che facevo anch’io qualche cosa di grosso, mica solo gli altri, e dalla finestra della villa avevo mirato sullo stradone a un chilometro di distanza, su un ciclista, non lo credevo mica, ma è caduto come al bersaglio... E appena gliel’ho detto non ha più voluto stare con nessuno, solo con me, e io ero tanto contento, al principio, ma è un mese che non dormo più, che non vivo più, anche se sto con lei quando voglio, me lo sogno di notte, quel ciclista che cade, dovete arrestarmi...» E si mise a piangere, forte, il giovane grassoccio. 60 · L’infermiera inamovibile «Lei è un’ottima infermiera», disse il primario con risoluta gentilezza, «ma, benché sia qui da diversi anni, devo dirle francamente che la sua condotta lascia molto a desiderare. Corrono troppe voci sui suoi rapporti con i malati più ricchi della clinica, con i medici, e non sono soltanto delle malignità. Abbiamo anche delle prove: mi risparmi di insistere sull’argomento, sarebbe imbarazzante. Accomodiamo le cose amichevolmente. Io la licenzio, le do il migliore dei benserviti e lei potrà trovare lavoro in qualunque altro posto...» L’infermiera, splendida nel suo velo bianco sul capo, sembrava una sposa pronta per andare all’altare, non disse niente per molto, poi mormorò: «Sono tutte calunnie delle mie colleghe. Ne dicono di ogni genere. Dicono anche che io aspetto un bambino da lei...». E fissò sorridendo il vecchio, robusto primario. «È divertente...» disse il primario, era divertente davvero, l’avrebbe raccontata a sua moglie, pensò ignaro, ma gli occhi bellissimi, verdi e freddi della ragazza gli dettero un principio di sospetto. «Ho già preparato il suo benservito.» «Se lei mi licenzia», disse l’infermiera sposa, «diranno tutti che mi manda via per liberarsi di me e del bambino...» Il primario tentò ancora di sorridere. «Nessuno crederà a una sciocchezza simile», disse alzandosi. «Ma io aspetto davvero un bambino», anche lei si alzò, «e non può mettermi in mezzo alla strada proprio adesso, per la disperazione non so cosa potrei dire o fare.» Dal viso del primario divenuto rosso, capì di aver colpito giusto, avrebbe mandato in rovina la clinica con uno scandalo, se la licenziavano. Il vecchio primario era un saggio e comprese di aver perduto, con le donnacce si perde sempre. «Ne riparleremo un altro giorno...» disse, sconfitto. 61 · L’uomo che non voleva morire Svaligiare una villa è un lavoro un poco complesso. Prima di tutto occorre un grosso camion, se non due, non è come una rapina che basta anche un’utilitaria, qui bisogna caricare quadri, porcellane preziose, mobili di antiquariato, e nella Villa Picena vi era un cassettone Bossuet che era valutato undici milioni, e nello stesso tempo ci voleva un vero e proprio imballaggio dei delicati pezzi. Tutto ciò richiede molto tempo: a sbrigarsi, mezza giornata. Quindi non è una cosa da fare di notte, bisognava farla in pieno giorno. Come facevano loro. Erano in quattro, con tute un po’ consumate che sembravano di veri addetti ai traslochi, e poi c’era la scritta sul petto e sulle spalle della tuta: Autotraslochi Gassinelli. Lavoravano dalle otto, avevano attraversato mezza Valle Padana per arrivare lì davanti a quella grandiosa Villa Picena, a tre piani, di un moderato, piacevolissimo barocco. Il custode venne ad aprire il cancello, e li guardò senza simpatia, anche se non ancora con sospetto. «Villa Picena?» disse uno dei quattro, il più anziano, anzi vecchio, e con un’aria fine fine che contrastava con la rozza tuta e il rozzo lavoro di trasloco che avrebbe dovuto fare. «Sì», disse il custode, sempre con meno simpatia, e ora con sospetto, perché non gli sembrava che avessero l’aria di onesti operai. «Siamo venuti per il trasporto dei due pianoforti», disse il vecchio tendendo una carta, intestata Autotraslochi Gassinelli. «Io non ho nessun ordine», disse seccamente il custode. Ma, d’istinto, come i quattro avevano previsto studiando il lavoro fino ai minimi dettagli, allungò la mano oltre le sbarre, per prendere il foglietto. Allora, nello stesso attimo, i tre più giovani gli afferrarono la mano, mentre il vecchio si tirava indietro e sorvegliava la strada che era deserta. Attraverso le sbarre del cancello tapparono la bocca al custode con un fazzoletto già pronto, lo perquisirono attraverso quelle sbarre e gli trovarono subito la scacciacani e le chiavi. Così entrarono nella villa, fecero tacere anche la moglie e cominciarono a lavorare. Alle undici e tre quarti stavano finendo. Naturalmente in un camion, per quanto grosso, non si può mettere tutto quello che contiene una villa a tre piani, ma c’era il vecchio che sceglieva, e indicava quello che si doveva mettere nel camion e quello che si doveva lasciare. Doveva intendersene: prima aveva fatto caricare sul camion gli arazzi e i tappeti. Ognuno era un capitale. Poi le porcellane e i pezzi rari di argento. Poi uno dei due pianoforti, quello che non suonava più. «Dottore», disse uno dei due giovani, «ma perché portiamo via questo che non suona, e lasciamo lì quello che è più grande e suona così bene?» «Perché è così», disse irridente il vecchio, chiamato dottore. Poi fece caricare tutta la collezione di pistole del Sei e del Settecento, il proprietario doveva essere maniaco, erano tutte autentiche, pensò il dottore esaminandole, ed erano quasi un centinaio. Era evidente che merce del genere non poteva essere rivenduta in Italia, e infatti il dottore non aveva mai pensato di smerciarla in Italia. Aveva già gli acquirenti che lo attendevano in Corsica e da lì si sarebbero portati via la roba dove volevano. E per portare quella merce in Corsica era semplice, sarebbero andati in Toscana, sarebbero scesi lungo il Tirreno, col grosso camion rimpinzato di pezzi di alto antiquariato e lì, al porticciolo de La California, avrebbero trovato, combinazione, uno yacht. L’uomo che ha prestato il camion Autotraslochi Gassinelli, azienda inesistente, si sarebbe ripreso il camion insieme con un pacchetto di due milioni. Era novembre, dunque, il sole era dello stesso colore del vino bianco secco e non scaldava nulla, però dava un riflesso oro a tutto quello che toccava, una delicata luce d’oro. Faceva freddo, abbastanza da condensare il fiato nell’aria, il freddo faceva venire appetito e i ragazzi erano stati già un paio di volte in cucina, a vuotare il frigorifero. Ma lui non aveva fame, pensava alla moglie del custode, legata laggiù in cantina, bella donna, e scaricato l’ultimo arazzo s’allontanò. «Dove vai?» Era il dottore che, pur non portando occhiali, aveva occhi acuti, piccoli, fissanti, come li portasse, e vedeva tutto. «Non abbiamo tempo da perdere, siamo già in ritardo di undici minuti sull’orario. Va’ nel salone e sbrigati a imballare le pendoline che ti ho preparato sul grande tavolo.» «Le pendoline te le imballi da solo.» Si avviò ancora, ma ancora si fermò alla secca voce del vecchio. «Prova a fare un altro passo in avanti e ti stendo», disse il dottore. Non lo fece, si volse lentamente, e come prevedeva lui aveva in mano quel bel pistolone che ogni schiacciata di grilletto sputava quattro sassi: non c’era troppo bisogno di prendere la mira, con quella roba. Un giorno o l’altro glielo avrebbe rubato. Gli altri due giovani guardavano in silenzio. Uno di loro disse: «Ha ragione il dottore, sbrighiamoci, se no alla fine ci pescano». Guardò in fondo al viale alberato che, lungo trecento metri, arrivava al cancello che dava sul canale. Il camion era nascosto dagli alberi, e anche loro, ma c’è sempre qualcuno che ha la vista troppo acuta, oppure poteva sempre arrivare un fornitore, un operaio, il postino: e bisognava andare ad aprire, per non insospettire. «Non fare il buffone, dottore, lo sai che non puoi sparare: se spari ti sentono fino a Padova», disse insultante il giovane. Si avviò verso la villa e questa volta la voce del dottore non lo fermò più, e tanto meno, si capisce, lo fermarono degli spari, perché il dottore non sparò. Fece presto ad arrivare in cantina dove erano chiusi i due custodi. Erano legati con del filo di rame trovato dietro la villa, nell’autorimessa che serviva anche da magazzino attrezzi. In bocca avevano uno straccio e sulla bocca un grosso nastro adesivo. L’uomo era legato con quel filo di rame a una conduttura di acqua e la donna, a un metro circa, era legata alla stessa conduttura. Stavano tutti e due seduti in terra, le spalle appoggiate al muro nel buio, e, quando lui accese la luce, sbatterono le palpebre. Lui si chiamava Giannetto, guardò irridente il custode, che lo fissava con odio. «Sta’ buono, non ti faccio niente.» Guardò la donna. Mise un ginocchio a terra e osservò il filo di rame che avvolgeva le gambe della giovane donna, anche se la lampada in quell’angolo di cantina non illuminava molto, pure il bel rame nuovo scintillava tutto intorno alle gambe e al corpo della donna, fin oltre il seno, in strette spirali di un filo sottile ma tenacissimo. E appena data un’occhiata a quella legatura, Giannetto capì che non sarebbe stato un lavoro facile. Il nodo terminale, infatti, era stato fatto con la pinza, avvolto e riavvolto sempre con la pinza. Sarebbe stato meglio tornare di sopra, nell’autorimessa, e cercare una pinza e una forbice da meccanico, ma non ne aveva voglia, il dottore poteva vederlo e richiamarlo. Provò un momento con le mani a rigirare il nodo terminale per scioglierlo, ma il rame è un metallo serio, un nodo di rame è un nodo serio, non si scioglie senza gli attrezzi necessari. Giannetto riuscì soltanto a ferirsi, e smise solo quando ebbe la mani impiastrate di sangue. I due lo fissavano, in un silenzio obbligato, per il bavaglio, ma ugualmente carico di odio, di disprezzo, di disgusto. Allora lui si pulì le mani sporche di sangue sui capelli di lui, neri e folti. «Non ti preoccupare, signor custode, non mi serve neppure scioglierla, la tua sposina.» Cominciò a strappare le vesti della donna, da sotto le spirali di filo di rame, e continuava a tirare e strappare finché non compariva la pelle. «E guardatemi pure bene per informare la polizia, e descrivere come sono. Ci faranno il brodetto, col mio identikit.» Alle dodici e diciannove minuti il dottore avvertì i giovani che bastava, il camion era pieno, non c’era più posto neppure per una tabacchiera, fosse stata anche quella di Luigi XVI, calcolando che nell’interno del camion dovevano stare due uomini un po’ comodi, perché il viaggio era lungo. «Avete visto Giannetto?» disse il dottore, con voce molto normale, lui sapeva contenere l’odio di cui si era riempito quando Giannetto se ne era andato ugualmente in cantina, anche se lui l’aveva minacciato con quella specie di mitra. Nessuno dei due ragazzi lo aveva visto. Doveva essere ancora in cantina. Era infatti ancora in cantina, ma aveva la nuca in parte sfondata. Il custode e sua moglie erano sempre legati. Il dottore capì benissimo come era avvenuta la cosa. Il custode era strettamente legato, ma poteva alzare e abbassare tutti e due i piedi legati insieme, e quando Giannetto si era un poco abbandonato, aveva alzato i piedi, calzati di robuste scarpe venete da contadino, perché lui faceva anche il giardiniere, e gli aveva sfondato la testa con un terribile colpo di tacco. I piedi del custode erano infatti ancora appoggiati sulle spalle di Giannetto, e si vedevano benissimo i robusti, ferrati tacchi delle scarpe, ancora lucidi di sangue. Il fatto doveva essere successo anche meno di due minuti prima. «Gliel’avevo detto io che non doveva perdere tempo...» disse il dottore. Adesso il camion era pieno, il giovinastro che prima gli aveva fatto perdere la faccia era morto, e poi ci sarebbe stata una parte in meno da distribuire: invece che in quattro si divideva in tre. «Ma come è successo, dottore?» disse uno dei due giovani. «Non l’hai ancora capito? Mentre lui faceva il bello con la donna, il marito, anche se legato come un salame, poteva sempre alzare i piedi, e li ha alzati: guarda i tacchi delle sue scarpe», spiegò il dottore. L’altro giovane si era inginocchiato a guardare il viso di Giannetto che si appoggiava sulla spalla della donna, e saltò su come fosse stato beccato da un’aragosta affamata. «Dottore, è vivo! Mi ha guardato, ha mosso gli occhi!...» Anche il dottore mise un ginocchio a terra e Giannetto mosse gli occhi e guardò anche lui. Non poteva parlare, una schiuma rosea gli fluiva dalle labbra, ma era vivo, certo non per molto, ma vivo. Questo creava un grosso problema, e lui, il dottore, doveva risolverlo subito, erano già troppo in ritardo. «Portatelo fuori», disse. Sperò che morisse nel trasporto dalla cantina al giardino: con la testa sfondata, ogni movimento è fatale. Invece restò vivo. «Prendete un copriletto e avvolgetelo, se veniamo fermati dalla polizia deve sembrare un tappeto o qualche cosa di simile.» Lo avvolsero nel tappeto, lo ficcarono per lungo nel camion e uno dei due ragazzi gli si mise vicino, per quanto con una certa repulsione, perché gli occhi di Giannetto continuavano a fissarlo. La villa venne chiusa ordinatamente, ogni traccia di disordine venne cancellata, almeno dall’esterno, i due custodi vennero abbandonati al loro destino, l’altro giovane salì allora al volante del camion e il dottore sedette al suo fianco e si accese una sigaretta. Il camion infilò il viale che conduceva al cancello, vi arrivò placidamente, ronfando come un gatto che fa le fusa, si fermò, il giovanotto che guidava scese, aprì il cancello, risalì al volante, oltrepassò il cancello e si mise sulla stradina col muso diretto a sud, poi discese ancora, chiuse il cancello e, secondo le istruzioni del dottore, buttò le chiavi nel canale. Quindi risalì e partì. Erano le dodici e trentatré, in quattro ore e trentatré minuti avevano portato via da Villa Picena tutto il meglio del meglio. Quello che era rimasto, in confronto, pur di valore, era paccottiglia, il dottore a suo tempo aveva avuto un padre che faceva l’antiquario e gli aveva tenuto scuola in negozio, dal vivo e dal vero, peccato che il padre avesse il gusto delle falsificazioni di oggetti d’arte e quello degli assegni a vuoto, se no anche lui sarebbe divenuto un onesto e agiato antiquario. Così pensando mentre il camion seguiva il solenne canale, per la strada deserta perché a quell’ora tutti andavano a mangiare, gli ritornò alla mente quello nell’interno del camion, spostò il telone e disse al giovanotto: «È vivo?». «Sì», disse il giovanotto. Era proprio incredibile, comunque non avrebbe potuto vivere per molto ancora. «Appena muore, avvisami.» «Sì, dottore», disse il giovanotto dall’interno, con la voce di uno che sta per buttare fuori tutto, «ma perché ce lo portiamo appresso? A me fa impressione, continua a guardarmi.» «Dove volevi lasciarlo? Nella villa coi custodi? Così in serata ci avrebbero già pescati?» disse il dottore. «Ma qui sul camion è ancora più pericoloso», disse il giovane. «Non è vero, sembra un tappeto, te l’ho detto. E poi non deve rimanere sempre sul camion. Appena muore, lo scarichiamo nel posto giusto.» Poteva darsi che Giannetto sentisse, se vedeva e muoveva gli occhi, era molto probabile che sentisse, comunque al dottore non importava. «Avvisami, appena muore.» Il giovane che guidava disse: «Ma può durare ancora a lungo, che facciamo, allora?». «Non credo, non può durare più di mezz’ora, dovrebbe essere in coma.» «Ma se dura? Tutto oggi, tutta stanotte...?» insisté quello che guidava. «Allora vedremo», disse il dottore. Le strade per andare da Padova al Tirreno, sulle coste toscane, sono diverse, la più facile è naturalmente la Padova-Rovigo-Ferrara-Bologna-Firenze, ma il dottore non aveva in mente di fare la strada più facile, ma quella, anche più difficile e lunga, che però confondesse la polizia. Perciò disse al ragazzo che guidava di dirigersi verso Mantova. «Ma non andiamo a Cecina?» disse il ragazzo che guidava, si chiamava Tito. «Sì», disse il dottore, «e questa è la strada più lunga per arrivare a Cecina.» A un certo punto i custodi di Villa Picena sarebbero stati liberati. Allora avrebbero dato alla polizia tutte le indicazioni possibili, e probabilmente la polizia avrebbe saputo che un camion così e così aveva percorso la strada per Mantova. Quindi, se era sulla strada di Mantova voleva dire che andava verso Milano, o verso Torino, o verso Genova. Ma arrivato a Mantova, lui disse a Tito di piegare a sud: «Andiamo a Parma». E dopo le quattro erano a Parma, imboccavano viale Partigiani, proseguivano per lo stradone Martiri della Libertà, arrivarono a piazza Marsala e furono sullo stradone che conduceva alla Cisa. «Io mangerei qualche cosa», disse Tito guidando. È vero che avevano svuotato il frigorifero di Villa Picena, ma adesso erano le quattro. A novembre a quell’ora è quasi sera, qualche auto aveva già i fanali accesi. Il dottore accennò di sì: avrebbero mangiato qualche cosa. Poi si rivolse al ragazzo nell’interno del camion. «È morto?» «No», disse il ragazzo, si chiamava Luigi. Aveva sempre gli occhi aperti, Giannetto, avvolto nel copriletto come fosse un tappeto arrotolato, e lo guardava, sembrava volesse parlargli, e muoveva anche le labbra, solo che non ci riusciva. Videro da lontano l’insegna di un ristorante, già accesa, e da un lato della costruzione erano tre grossi camion con rimorchio, ma non si fermarono proprio lì davanti, Con un agonizzante a bordo che da un momento all’altro poteva mettersi a gemere, non era prudente, andarono oltre per un centinaio di metri, poi il dottore fece fermare e mandò Tito a prendere dei panini e delle bottiglie di birra. Quando ripartirono era buio completo. «È morto?» domandò ancora il dottore. «Non lo so, non ci si vede niente e non lo voglio toccare», il ragazzo stava per vomitare il panino appena mangiato. Il dottore aprì un cassetto del cruscotto, tirò fuori la lampada a pile e gliela dette, già accesa. «Guarda un po’.» «No, è vivo», disse Luigi, gorgogliando. Era vivo, e nel breve cerchio di luce aveva sbattuto gli occhi, lo aveva fissato e aveva mosso le labbra. Il camion arrivò a Fornovo di Taro e cominciò ad attaccare la Cisa. La Cisa, pensò il dottore mentre il camion saliva le rampe, non è certo una grande montagna, non arriva neppure a mille e cento metri, ma ha il cipiglio delle grandi montagne, i tornanti che vogliono imitare quello dello stradone per lo Spluga, e il cattivo tempo quasi continuo, infatti appena dopo Fornovo cominciò a piovere, e man mano pioveva sempre meglio. Ma per loro la Cisa aveva due grandi vantaggi, era sempre piena di camion, anche d’inverno, e così il loro camion si confondeva con tutti gli altri. E infine, vi era di sicuro la polizia stradale. A suo tempo, studiando il piano, il dottore si era informato e sapeva che vi erano almeno due coppie di militi in motocicletta che facevano da cani pastori ai camion che passavano di lì, una sul versante di Parma, e l’altra su quello di Sarzana. A lui non è che piacesse molto la polizia stradale, ma in quel caso gli era utile. Soltanto che prima doveva sistemare Giannetto, se la polizia lo avesse trovato con un moribondo sul camion sarebbe stato troppo difficile dare spiegazioni. Ma non lo avrebbe trovato. «Fermati lì in quella rientranza», disse a Tito. Erano a metà strada della prima rampa che conduceva a Poggio di Berceto, i fari illuminavano un buio piovoso e viscoso, e per il momento nessun altro camion seguiva o sopraggiungeva, comunque non c’era niente di strano che un camion sostasse un po’, la strada era disseminata di grossi automezzi che facevano il pisolino, a qualunque ora. «Tu resta al volante», disse il dottore a Tito. «Io e Luigi sistemiamo Giannetto.» Lo sistemarono bene: sul bordo dello stradone iniziava un sentiero che scendeva ripido, e adesso anche fangoso, verso il rumoreggiante Taro colmo d’acqua per le continue piogge. Tenendolo in due, avvolto nel copriletto, guidandosi alla luce della lampada a pile, lo trasportarono più in basso possibile, scivolando spesso nel fangume del sentiero, rimanendo spesso attaccati a rami spinosi, finché il dottore non disse: «Qui». Lo deposero fuori del sentiero, tra i rovi. Il dottore lo guardò con la lampada. Aveva gli occhi chiusi, ma non era morto, muoveva le labbra. Gli era costata cara la violenza alla moglie del custode, pensò il dottore. «Aiutami a levargli il copriletto e la tuta», disse a Luigi. Lo svolsero dal copriletto e gli levarono la tuta. Sotto aveva lo smoking, come tutti loro quattro. Quando si va a una festa elegante su uno yacht ci si veste da società, lo smoking è un abito da società: arrivati al porticciolo davanti allo yacht, si sarebbero liberati delle tute nell’interno del camion e sarebbero saliti sullo yacht come ospiti di riguardo, ricevuti dal proprietario e dalla sua signora. Chi poteva immaginare che quegli eleganti gentiluomini solo poche ore prima avevano finito di svaligiare una delle più sontuose ville del Veneto? Naturalmente, nel fango, a faccia in giù, Giannetto si rovinò il candore della camicia col sottile jabot; schizzate di mota copersero subito tutto il bell’abito da società, ma quell’abito gli dava lo stesso un aspetto signorile, veramente da signore, un signore che non voleva morire, perché, anche con la faccia nel fango, continuava a dire, sia pure senza voce: «Assassini, assassini, assassini». «Ma è ancora vivo!» disse il ragazzo, Luigi, sconvolto. «Sì, è ancora vivo», disse il dottore. «Ma allora è meglio ammazzarlo», disse rauco Luigi, «non si può lasciarlo qui, vivo.» «Se vuoi, ammazzalo tu», disse il vecchio dottore, freddamente. «Io non sono un assassino, sono un semplice ladro. Basta che gli dai un altro calcio in testa, se ne hai tanta pietà, e lui finisce di soffrire.» «Non parlare così, maiale!» e il ragazzo alzò un pugno, come per colpirlo. «Se invece sei un santo, sei libero di riprenderti in spalla Giannetto, di riportarlo sullo stradone, e alla prima macchina che passa farlo caricare e portarlo all’ospedale. Nessuno te lo impedirà. Io e Tito, però, continuiamo il viaggio, perché non siamo santi.» Luigi abbassò il pugno. Non c’era niente da fare, il dottore glielo aveva fatto capire. Risalirono fin sullo stradone e ripartirono. Questa volta Luigi, sempre nell’interno del camion, aveva più posto, e appoggiandosi ai rotoli di tappeti e arazzi riuscì ad addormentarsi. Si svegliò quando il camion si fermò. Guardando oltre il telone, capì perché il camion si era fermato: era la polizia stradale. Scese allora dal camion, pronto a fuggire se qualche cosa andava male, anche il dottore e Tito erano scesi. Tito aveva dato i documenti del camion e uno dei militi, insensibile sotto la pioggia, li esaminava scrupolosamente. Li restituì perché erano in regola. «Che carico avete?» disse l’altro milite. Intervenne il dottore e porse un foglio che subito si macchiò di pioggia. «È un trasloco, gente che viene a trasferirsi a La Spezia, gente ricca.» Il milite lesse la bolla, con l’elenco della merce trasportata e col timbro dell’ufficio imposte che si trattava di roba usata. Un’imitazione perfetta. Ma i militi vollero vedere lo stesso nell’interno del camion, uno salì e con la lampada a pile guardò bene tutto, non perché volesse rubare il mestiere alle guardie di finanza, ma perché non gli piaceva essere preso per stupido, cosa che i camionisti facevano sempre molto volentieri. Sul pavimento vi erano delle macchie di sangue, ma il sangue diventa subito nero, specialmente alla luce artificiale, e il milite non vi badò. Scese, e fece cenno che andassero pure. E loro se ne andarono via tranquilli: se erano passati di qua, dal versante di Parma, al controllo della polizia stradale, sarebbero passati di là, dopo il passo della Cisa, sul versante di Sarzana. Per lo meno c’erano buone speranze. Infatti passarono ancora, vennero fermati ancora dalla paletta fosforescente della polizia stradale, la regola era forse di fermare un camion su dieci, chi sa; e ancora un milite salì dentro il camion, ma un pianoforte usato, dei tappeti puzzolenti di tarmicida, dei vasi alti quanto un uomo e qua e là sbrecciati non erano cose che dessero sospetto. Ripartirono col permesso dei superiori, e si accesero finalmente la prima sigaretta da fumare senza angosce, adesso erano a posto. A Pontremoli si fermarono a bere, a mangiare dei panini, erano quasi le otto, valicata la Cisa la pioggia era diminuita, il traffico anche, sarebbe ripreso, quello dei camion, verso mezzanotte, ma a quell’ora loro sarebbero arrivati a destinazione. E vi arrivarono: Sarzana, Viareggio, Pisa, Livorno e Cecina. Erano in ritardo di un’ora e mezzo sull’orario fissato dal dottore, ma lo yacht avrebbe atteso anche tre ore. Attraversarono Cecina, scesero per lo stradone pochi chilometri, poi, all’altezza di Bibbona, voltarono a destra verso il mare, e furono quasi subito al porticciolo. La California, non era neppure un porticciolo, avevano semplicemente scavato il fondo in un certo punto della spiaggia, per fare posto anche a yacht di una certa stazza. E lo yacht era lì, due lucine azzurre sul ponte lo rivelarono. Ed erano appena arrivati che dalla passerella già calata scesero nel buio piovoso una mezza dozzina di marinai, erano loro che dovevano caricare la roba sullo yacht. E c’era anche il compare del camion, fu il primo ad arrivare. «È tutto preparato, caricheremo in un’ora e mezzo», disse. «Bravo», disse il dottore, cominciò a togliersi la tuta, anche Tito e Luigi lo fecero, e, sotto, tutti e tre avevano lo smoking. Nel camion si misero le scarpe da smoking, poi salirono svelti la passerella aiutati da un marinaio, perché ondeggiava parecchio, e furono sullo yacht. Il dottore strinse la mano a un signore alto e magro, e disse con noncuranza: «Il camion è pieno». «Complimenti, vorrai rilassarti un poco», disse l’altro. «Venite anche voi, ragazzi, ci sono bellezze esotiche e nazionali, intanto che gli uomini caricano.» Andava tutto così bene, era impossibile credere che a Monaco, a oltre metà novembre, ci fosse tanto sole e che si potesse stare seduti ai tavoli del caffè con una maglietta a vivaci colori, e con tutti quei milioni in tasca. Al dottore no, non sembrava impossibile, ma ai due ragazzi sì. La somma più grande che avessero posseduta, una volta, in seguito a un furto in una tabaccheria, era stata trecentomila lire. Adesso avevano ciascuno dieci milioni di lire in una cintura che faceva da panciera, e si sentivano un po’ a disagio. Ma a Monaco arrivavano anche i giornali italiani e, dovendo fare qualche cosa, li leggevano. E al secondo giorno lessero: Un cane trova sulla Cisa un uomo in smoking, gravemente ferito al capo. Nel sottotitolo veniva spiegato: Non ha nessun documento indosso, i medici hanno proibito che la polizia lo interrogasse . L’indomani il dottore e i due giovani lessero una notizia più confortante: Lo sconosciuto della Cisa sta morendo e non ha potuto rivelare la sua tragica e misteriosa storia. Il fatto che Giannetto non fosse ancora morto, era una cosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Ma c’era qualche cosa di ancora più spaventoso: se i medici fossero riusciti a dargli solo cinque minuti di fiato prima che morisse, Giannetto in quei cinque minuti diceva tutto, perché sapeva tutto, nomi, cognomi e indirizzi di tutti, anche di quelli che avevano fornito gli smoking e loro tre potevano ordinarsi le divise da ergastolano su misura, se ci tenevano all’eleganza in galera. Il giorno dopo fu ancora più terribile. Nessuna notizia sul moribondo della Cisa. Continuavano invece i titoli, ma sempre più piccoli, sul colpo a Villa Picena. I custodi avevano dato molti particolari, ma si capiva che la polizia non sapeva ancora che strada prendere. Ormai vivevano solo di giornali italiani e di roulette, la gioia del colpo riuscito era stata del tutto avvelenata: bastavano poche parole di Giannetto per scatenare tutta l’Interpol addosso a loro, li avrebbero presi in mezz’ora, se Giannetto avesse parlato. Il quarto giorno i quotidiani italiani scrissero: Dopo la crisi di giovedì notte, i medici non disperano di salvare lo sconosciuto della Cisa. Forse questa sera la polizia potrà interrogarlo. Nella sontuosa stanza di quell’albergo vicinissimo al casinò, loro si sentirono inaridire le labbra e tutto il palato, leggendo. «Bisogna fare qualche cosa», disse Tito. «Non possiamo stare qui ad aspettare che vengano a prenderci. Se Giannetto parla, lo dice subito che siamo in Francia, e che nel programma c’era di rimanerci due o tre mesi in attesa che tutto sbollisse. Dobbiamo andare in un altro paese.» «Sta’ zitto, cretino», disse il dottore, «se Giannetto parla, ci trovano qui, come ci trovano in Turchia. L’unica nostra forza è di stare insieme, qui, e dare meno nell’occhio, non fatevi vedere troppo al casinò a sperperare, e aspettiamo.» Aspettarono. I giornali italiani del mattino non pubblicavano nulla, ma il «Corriere d’Informazione» che arrivò la sera, diceva: I medici hanno autorizzato la polizia a interrogare l’uomo in smoking. Sarà presente anche il procuratore della Repubblica. Allora Tito scoppiò: «E adesso che cosa fai, superuomo? A quest’ora Giannetto avrà già parlato e magari fra poco bussano alla porta questi bei gendarmoni di Monaco. Io non ho voglia di farmi prendere come un pesce in un vivaio. Me ne vado». «State fermi tutti e due, ignoranti», e il dottore levò il suo meraviglioso rivoltellone dalla cintura. «Farsi prendere qui, in questo bell’albergo, è molto più comodo che farsi prendere scappando per qualche montagnola di questo principato. Se Giannetto ha parlato, è finita e buonasera. Ma se volete andarvene, prima mi date i soldi. Non vi lascio prendere dal primo poliziotto con tutta quella roba addosso.» Al mattino dopo andarono tutti e tre alla stazione, presto, per prendere i giornali appena arrivati dall’Italia, perché né la radio, né la TV avevano detto niente di nuovo. C’era il sole, ma cominciava a far freddo, anche nella tiepida Monaco. Il «Corriere della sera», a pagina 9, pubblicava: L’uomo in smoking è morto appena iniziato l’interrogatorio. Ha pronunziato solo la parola «assassini», e niente altro. Le indagini continuano. Eh, sì, sarebbero continuate per molto, ormai, pensò Tito. Guardò il dottore, sollevato. Era proprio così: il dottore aveva sempre ragione. Tutti e due, Tito e Luigi, lo guardarono con ammirazione. Solo lui aveva tenuto i nervi a posto fino all’ultimo. Era il dottore. 62 · Un cappello di paglia rosso L’osteria sul fiume dormiva. Sotto un’esile tettoia di canne che dava un’ombra rigata, luminosa, c’erano tre lunghi tavoli grezzi e a uno di quei tavoli era seduto il vecchio, ma non era vero che dormisse anche lui, era soltanto il suo modo di vivere, vicino al bicchiere di vino, la mente immobile, che non pensava più rodendo e ronzando colma di fantasie e di pensieri come in passato. Ma ogni tanto la mente riprendeva, sia pure incepposa, stridendo, a pensare qualche cosa, e in quel momento il vecchio pensò ai ragazzi, a dove fossero andati, guardò torpidamente l’automobilina che li aveva portati fin lì al fiume, i due giovani fidanzati, e lui che doveva esserne il cane da guardia, ma dopo l’ingozzata di pesce fritto aveva chiuso gli occhi e loro erano scomparsi. Si alzò e li andò a cercare, verso il fiume, per fare il suo dovere, e arrivò alla fine del sentiero che dava sul fiume, inseguito da gentili farfalle primaverili, fino al punto in cui il sentiero precipitava verso il fiume, per diversi metri, in una discesa materialmente impossibile alla sua età, e li vide, i due ragazzi, dall’alto, in un anfratto, semicoperti da un arbusto, ma visibile la lunga bianca gamba della nipote in un occhieggiare di bianchi merletti. Il vecchio cane da guardia si fermò e, stridendo, la sua mente gli pensò che se avesse gridato poteva fermarli, impedire il peccato, ma il cappello di paglia rossa della nipotina, vicino all’acqua del fiume, gli dette tenerezza, forse anche lui da ragazzo era stato con una ragazza dal cappello rosso, o forse era un vecchio tonto incapace di agire e fermare quei due disgraziati. Se ne tornò in silenzio, stanco, all’osteria fingendo di non aver visto. 63 · Infatti nessuno lo credette Aveva preso lei la guida dell’auto all’imbocco dell’autostrada a Firenze perché Carpuccio non gliela faceva più, e guidava tra i centosessanta e i centottanta nell’alba piovosa di quel lunedì, verso Milano: se riusciva a tenere quella velocità sarebbe arrivata in ufficio in orario, come sempre, e non rispondeva neppure a Carpuccio che sonnecchiava accanto a lei e le parlava dormendo: «Ma tu hai il padre scemo, io non la sposo una col padre scemo, adesso gli è scoppiata la fissazione di farti lavorare...». Già, forse era una fissazione, pensava sorridendo lei, guidando, anche in ufficio tutti erano rispettosi, anzi scivolosi, perché era la figlia del Dottore, con la D maiuscola, ma non la prendevano sul serio, si capiva che pensavano: ma cosa viene a giocherellare questa qui in ufficio con tutti i miliardi di suo padre? E rimanevano un po’ male quando lei compariva, implacabilmente puntuale, tutte le mattine e lavorava davvero come le altre e usciva per ultima. Poteva sposare Carpuccio subito, invece di attendere un anno, gliene era venuto il desiderio il giorno prima, quando era arrivata a Pisa dopo aver lavorato fino a sabato sera tardi e aveva assistito al matrimonio di Missi con quello straordinario abito bianco. Altro che lavorare; ma amava suo padre, lo amava e lo ammirava, e faceva con piacere quel che lui le diceva: lavorare, lavorare duro, lavorare più degli altri, e orario, oooraaaariooo! «Ehi, bambina, corri meno, se ci spacchiamo la testa nessuno crederà che l’hai fatto per arrivare in orario in ufficio...» le disse Carpuccio dormendo. Infatti nessuno lo credette: una rivista pubblicò la fotografia della macchina schiantata, scrivendo che l’ereditiera, cioè lei, tornava da una festa di nozze, a Pisa, dove aveva bevuto molto. 64 · L’angelo A dodici anni ormai si capisce la vita e anche il grosso albero di Natale con tutti i suoi lumi non la incantava più, né tanto meno la incantavano tutti i pacchi e pacchetti messi sotto l’albero, perché sapeva già cosa contenevano, da una settimana aiutava la mamma a prepararli, come del resto aveva fatto tutti gli altri anni da quando aveva imparato a camminare, e le sorprese erano sempre le stesse, così figuriamoci che sorprese erano, e quella caterva di parenti che arrivava per Natale, e scartavano i loro pacchetti, e poi si abbracciavano, ma che scene, ed era lei incaricata di dare i pacchetti, così sbaciucchiavano anche lei. «Questo è per te», disse allo zio Mario, quello che aveva rifilato un assegno a vuoto a papà e poi a momenti si picchiavano, e giù il bacione dello zio Mario. «Per nonno Rodolfo», e tese il pacchetto a quello che lei chiamava il suocero di papà, odiandolo lucidamente come lo odiava papà, e giù il bacione del vegliardo. «Ecco, per te», dette il pacchetto alla cognata, la moglie di un fratello di mamma, e di questa cognata in casa sentiva solo dire che era la donna più tradita d’Italia, ma non dicevano proprio tradita. «Per te», disse alla zia Sandrina, la svanita, dicevano che era caduta da piccola o, come diceva papà, la scema della dinastia. E poi continuò a consegnare i regali ai cuginetti cretinetti, tutti maschi, tutti insipidi e mollicci come zucche. Le facevano un poco pena, i parenti, a lei. «È un angelo quella bambina», dissero i parenti andando via alla fine del pranzo. «È un angelo», disse lo zio Mario Assegno a Vuoto, il nonno Rodolfo odiato, la cognata tradita, la zia scema. «È un vero angelo», dissero sinceramente, commossi. Lo dissero quasi tutti. Qualcuno no, perché cominciava ad avvertire i sintomi dell’avvelenamento. Nonostante il teschio con le tibie incrociate, però, quell’insetticida non era un gran veleno. Si salvarono due cuginetti, la cognata tradita e la zia scema che per l’occasione diventò ancor più scema. 65 · Non per cattiveria Ancora sulla porta la magra, nervosa donna, nel suo acido paltò verde, ripeté quello che aveva continuato a dire per tutta la visita: «Lei, signorina, lo capisce che non è per cattiveria... ma mio figlio non ha ancora ventun anni e sua sorella ne ha trentotto, quasi trentanove, insomma è come fossero quaranta, e ancora oggi sono usciti insieme e mio figlio mi ha detto che ha intenzione di sposarla, non vorrà dire che sarebbe una cosa seria...». E allora lei la rassicurò che avrebbe parlato alla sorella, che stesse tranquilla, poi per tutto il pomeriggio si mise ad attendere, questa sorella, ma all’ora di cena la trentottenne quasi trentanove, insomma quarantenne, come diceva la madre del ventunenne, non era ancora tornata e arrivò solo verso le dieci, il viso ancora giovane, forse un poco più giovane da quando conosceva quel ragazzo e tornava a casa dopo essere stata con lui, sapendo che non avrebbe dovuto andarci, ma incapace di vincere quel potente richiamo di cui non era responsabile. «Lo so che è stata qui la madre», disse lei togliendosi la pelliccia, «sta’ tranquilla non lo rivedrò più, è stata l’ultima volta...» Ma la sorella non era tranquilla, e la seguì in camera, e le prese la borsetta che lei aveva messo sul letto, e come temeva da tanto tempo, quella volta vi trovò quanto temeva, tutti quei tubetti di sonnifero che prese e tenne in mano, perché anche lei, zitella anziana, come la sorella minore aveva una volta desiderato di fare così, per amore, e non ne valeva la pena. «Dormiremo insieme per un poco di notti», disse, compassionevole. «Ti passerà...» 66 · La ragazza calibro 22 Beatrice Laederys discendeva direttamente dagli armaioli Laederys che furono tra i primi in Italia, nel 1500, a fabbricare pistole. I primi modelli di pistole Laederys, come tutti quelli di quella lontana epoca all’alba delle armi da fuoco, avevano gravi inconvenienti. Avevano un colpo solo in canna e per ricaricarle – erano ad avancarica – occorreva del tempo, così chi non aveva centrato al primo colpo l’avversario, questi aveva tutto il tempo di infilzarlo con la spada. I Laederys, benché siano stati armaioli per circa quattro secoli, non furono mai molto famosi, perché non si dedicarono mai alle armi d’arte, alle pistole e agli schioppi cesellati, istoriati, decorati con miniature di celebri artisti. Furono, invece, noti per la praticità e la perfezione tecnica delle loro armi, anche se queste avevano un aspetto estetico piuttosto rozzo. Soldati di ventura, mercenari, generali che volevano rinnovare l’armamentario, andavano a Cuneo e si rifornivano di ottime armi, sempre più perfezionate. Verso la fine del 1800, quando già stavano approntando il primo modello di rivoltella a ripetizione, ancora prima degli americani che realizzarono la loro Savage solo nel 1908, i Laederys si resero conto che non era più tempo per la piccola industria, vendettero la fabbrica e si ritirarono a Dogliani, dove possedevano grandi proprietà terriere e avevano un’antica bellissima villa vicino al fiume Rea, a sorvegliare le tenute, a pescare, ad andare a Cuneo o a Torino in carrozza. La passione per le armi rimase in famiglia. I Laederys non fabbricarono più armi, ma le collezionarono. Il terzo piano costituiva una delle più aggiornate armerie private d’Europa. Con la praticità che aveva sempre distinto i Laederys da decine di generazioni, essi non collezionavano armi preziose e antiche, ma armi moderne, sempre le più moderne e le più efficienti. Andrea Laederys, il nonno di Beatrice, aveva già buttato via, nel 1918, tutte la armi della prima guerra mondiale, ed era andato in giro per gli Stati Uniti a rifornirsi delle nuove armi, quelle che sarebbero servite per la seconda guerra mondiale e confessava con amarezza agli amici che forse avrebbe visto le armi della seconda guerra mondiale, ma purtroppo non quelle della terza. Infatti, fece in tempo a sentire parlare delle katiusce russe e delle MaschinenPistolen tedesche e delle V1 e V2, ma gli sfuggì la bomba H. Cresciuta in un ambiente di armi – fin da quando aveva quattro anni la nurse londinese per tenerla calma la portava a giocare nell’armeria dove lei mugolava di gioia davanti alle rivoltelle e ai fucili – avendo il gusto delle armi nel sangue, a nove anni Beatrice Laederys già sparava con rivoltelle giocattolo centrando bersagli alla distanza anche di venti metri. Suo padre le insegnò a sparare con la destra e con la sinistra e anche con due rivoltelle insieme, le insegnò a resistere al rinculo dei pesanti fucili coi quali la faceva sparare, e come se fosse una recluta di caserma, invece che una femminuccia, le faceva smontare pezzo per pezzo ogni arma che adoperava e poi gliela faceva pulire e rimontare. Così che quando Beatrice ebbe l’età per iscriversi al tiro a segno, un piccolo poligono vicino a Cuneo, che risaliva ancora ai tempi in cui Agostino Depretis aveva fondato in Piemonte la prima società di tiro a segno, nel 1848, non ebbe bisogno di seguire alcun corso preparatorio, né di alcun consiglio o raccomandazione dell’istruttore. Impugnò prima una pesante Beretta Brigadier, e colpì il bersaglio abbastanza vicino al centro. Poi sparò con la sinistra ed ottenne lo stesso risultato. Poi si provò col fucile, un Franchi automatico del peso di quasi cinque chili, e questa volta prese il centro del bersaglio. Ma Beatrice Laederys, non si interessava soltanto di armi. Le piaceva anche essere elegante, e le interessavano i giovanotti. Nonostante gli abiti eleganti si rendeva conto di non essere bella, anzi, tutt’altro. Come donna latina era troppo alta. Poi, senza essere grassa, era, come dire?, quadrata, e solo i raffinati cerebralismi delle più alte sartorie italiane o francesi, riuscivano ad attenuare un poco questa quadratura. Era nubile volontaria. Avrebbe certo potuto sposarsi quando avesse voluto, la sua dote costituiva un’attrattiva maggiore che se fosse stata Miss Universo, ma l’idea di vivere con un uomo che la sposava come per compiere un’operazione in Borsa la rendeva troppo malinconica. Aveva ventinove anni e non pensava più neppure a sposarsi. Cinque anni prima era morto suo padre, ed era rimasta sola, nelle sue tenute, nella sua grande villa, con la sua grande armeria e con una montagna di soldi. Nel testamento suo padre le aveva raccomandato solo due cose, di comprare terreni e di ingrandire sempre di più le tenute. E la seconda, di comprare sempre nuove armi moderne, e disfarsi delle vecchie. «Specialmente rivoltelle», si era raccomandato, «le rivoltelle saranno sempre più perfette, e la nostra armeria deve far collezioni non di vecchiumi, ma di quanto c’è di migliore e di moderno.» Quel giorno lei guidò la sua Citroën verso Torino. Faceva un poco caldo, anche se era fine maggio soltanto. Lei era già con l’abito a fiori, ma da previdente piemontese aveva sui sedili di dietro la pelliccia sportiva di lontra beige. Andava a Torino non solo per fare un po’ di compere – tra l’altro un Hammerli Match Pistol del modico prezzo di 320 dollari, una delle più moderne e micidiali Maschinen-Pistolen – e non solo per fare colazione con Righetto, un romanaccio che aveva conosciuto per caso due mesi prima in un bar. Ma andava a Torino soprattutto per vedere suo figlio, Ludovico, di quattro anni, che ogni tanto affidava a una famiglia di inglesi, vecchi amici di suo padre, perché il piccolo non crescesse sempre nella solitudine della grande villa in campagna. Essendo nubile, lei era dunque una ragazza madre. Ma anche questo volontariamente. Cioè, lei era l’ultima dei Laederys. Suo padre non aveva avuto figli maschi, con lei si estingueva la dinastia che dal 1500 era il lustro della zona. Noncurante della legge salica che vieta la discendenza per via materna, ed essendosi trovata un giorno ad aspettare un bambino, sapeva benissimo da chi, pensò che, se lei non avesse disturbato il padre per farsi sposare, il bambino avrebbe avuto solo il nome della madre, cioè Laederys, lei gli avrebbe lasciato tutto in eredità e quindi Ludovico Laederys avrebbe continuato la dinastia dei Laederys, a dispetto, appunto, della legge salica. Alle dieci era a Torino e passò due ore col piccolo Ludovico. Gli aveva portato in regalo una tenda da indiano con un costume con lunghe penne da gran capo e per centoventi minuti si godette il suo mini-Laederys e si mise anche lei in testa tutte quelle penne da gran capo per farlo ridere. Poi corse dall’armaiolo, prima che chiudesse. Sfortunatamente l’Hammerli Match non era ancora arrivato. «Guardi invece che cosa è arrivato, signora...» le disse l’armaiolo. «Questa è una Colt», disse lei, guardando la potente rivoltella che l’armaiolo le tendeva. «Signora, lei ha ragione. Questa sembra assolutamente una Colt, antico modello, ma sono costretto a correggerla, e gliene chiedo scusa, non è una Colt, è una Dakota calibro 22, è uscita nel 1964, ma la nostra burocrazia l’ha fermata. Ora, osservi, signora: sull’alto della canna è inciso: Intercontinental arms Inc. Mentre sul lato sinistro è scritto Dakota cal. 22. Ma adesso la sorpresa, legga qui, alla base della canna.» Lei lesse. Vi era scritto: Made in Italy. «Capisce, signora? Questo gioiello viene fatto in Italia. Negli Stati Uniti la usano normalmente, noi qui appena ora possiamo venderla. Senta il peso: esclusa lei, non conosco nessuna donna che possa tenere in mano un cannone simile, però questo peso è utile perché così la mira non salta mentre si spara...» «Me ne dia due», disse Beatrice: sembrava stesse acquistando delle calze o dei reggiseni. «Sì, signora», disse l’armaiolo. Ormai la conosceva, non si sarebbe meravigliato neppure se fosse venuta lì a chiedergli un bazooka. «E i proiettili?» «Naturalmente.» Suo padre le aveva spiegato che quando si tengono delle armi bisogna sempre tenere anche i proiettili. Lei provò attentamente tutte e due le Dakota, mise i proiettili nel tamburo e li levò, chiuse e aprì la sicura, controllò il funzionamento dell’eiettore, poi tenne in ciascuna mano le due pesanti Dakota, a braccio teso e mirò verso uno specchio che rifletteva lei stessa in gesto di puntamento. «Prezzo?» «Coi proiettili settantamila lire.» Era un’arma meravigliosa e lei se ne intendeva. Alla genialità di base della Colt, di cui era praticamente una copia, si univa la maestria artigianale italiana per cui ogni meccanismo, ogni particolare era stato migliorato, curato e perfezionato fino all’estremo. E fu con grande felicità che caricò il grosso scatolone con le due Dakota nel baule della Citroën. Poi era felice anche perché andava da Righetto. Righetto era uno di quelli che lei chiamava i suoi amicietti. Era evidentemente un fannullone, un pataccaro romano che viveva di piccoli espedienti, ma che aveva il buon gusto, almeno con lei, di accontentarsi di poco. Naturalmente pranzi o colazioni li pagava lei. Trovò Righetto al ristorante San Giorgio, che l’aspettava. Quel mattino lui aveva l’aria più romanaccia e pataccara che mai, e per questo le piacque di più. Mangiarono molto, poi andarono nella pensione dove lui abitava e che aveva l’aria ambigua di tutte le cose che lui usava, o in cui viveva o circolava, ma lei si divertiva anche di questo ambiguo che costituiva l’ambiente. Alle quattro e mezzo del pomeriggio lo lasciò, arrivò a Bra poco dopo le cinque, e alle cinque e mezzo passate era a Dogliani. La villa sorgeva piuttosto lontana dal paese, in una zona collinosa, tutta circondata da verdissimi alberi, in fondo in fondo a un viale, lungo oltre un chilometro, che partiva dal cancello sullo stradone e arrivava all’ingresso dell’edificio. Fermata la Citroën davanti al cancello lei stava per sonare perché il vecchio Marco venisse ad aprire, quando si accorse d’improvviso di due cose. La prima che il cancello era aperto, spalancato, e questo non era mai assolutamente accaduto, e secondo, Frankenstein, il mastino che faceva la guardia, non veniva di corsa ad abbaiare forsennato al cancello. Rifletté un momento nell’aria già senza sole di un grigio tramonto; poi, con la Citroën, oltrepassò il cancello e imboccò il lungo viale aperto nella fitta boscaglia, che conduceva alla villa. Per quanto riguardava Frankenstein comprese subito perché non fosse venuto a ringhiare e ad abbaiare all’ingresso sullo stradone: a cinquanta metri dal cancello lo vide disteso in mezzo al viale. Aveva il muso nettamente sfondato da un colpo di rivoltella. Non scese neppure dalla Citroën per guardarlo meglio, ma scese altri cinquanta metri più in là perché aveva veduto sul bordo del viale un corpo umano. Ancora prima di curvarsi su quel corpo, vide che era il vecchio Marco, avevano sparato anche a lui in pieno viso, se non lo avesse conosciuto tanto bene, fin da quando era bambina, avrebbe stentato a riconoscerlo, ora. Non c’era niente da fare, era morto. Risalì in auto, corse verso la villa, entrò, gridando con tutta la sua voce e la sua disperazione: «Lillina, Lillina!». Nessuno le rispose. Le rispose solo il disordine caotico della sala a pianterreno. Più che ladri, coloro che erano entrati nella villa dovevano essere stati dei vandali, e avevano portato via ogni cosa di valore, il grande tappeto cinese, i due quadri, non dei pezzi rari, ma abbastanza importanti, e tutti i soprammobili di argento. Ma a questo non badò troppo. Salì al primo piano gridando ancora: «Lillina! Lillina!». Anche al primo piano c’era la stessa feroce devastazione che al pianterreno. Lillina era la nipote del vecchio Marco. Lei, il nonno e il mastino Frankenstein, erano i guardiani della villa. Il cane e il vecchio erano stati trucidati, e Lillina non rispondeva. Non rispose neppure quando lei arrivò al secondo piano ed entrò una per una in tutte le stanze e le sale, devastate anch’esse. E Lillina non rispose neppure al terzo piano, nelle grandi sale che formavano l’armeria. Non rispose, però c’era. Era nella sala più grande, sul grande tavolone coperto da un panno felpato grigio, dove si posavano i fucili o le rivoltelle, per osservarli meglio o per pulirli. Giaceva su quel tavolone, nuda nella parte inferiore, il viso coperto dalla gonna sollevata in su. Beatrice abbassò quella gonna per vederla in viso, ma subito ricoprì quel volto segnato dalle sevizie più atroci e disfatto dalla morte per strangolamento. Si sentì male. Si portò il fazzoletto alla bocca per dominare il convulso di nausea e si guardò attorno, distrutta, e solo allora si accorse che nell’armeria non c’era più un’arma, non più un fucile, una rivoltella delle centinaia di modelli che gremivano le quattro grandi sale del terzo piano. Per fare più presto si erano portati via le rastrelliere, senza star lì a prendere arma per arma. Poi si mise a piangere guardando Lillina distesa sul tavolo. Lillina aveva quattordici anni. Strappò una tenda da una delle finestre e la coprì con quella. Poi scese al primo piano e telefonò ai carabinieri. Tutto finì dopo le due di notte. Il corpo del vecchio Marco e quello di Lillina vennero portati via. I carabinieri fecero tutti i rilievi, la polizia scientifica fotografò e prese nota di diverse tracce. Il maresciallo dei carabinieri le rivolse molte domande, soprattutto insisteva nel chiederle: «Lei ha qualche sospetto su chi possa aver fatto questo macello? Gli assassini sapevano molte cose di lei: che lei oggi non c’era, e che la villa era piena di armi, perché sono le armi che essi volevano, poi hanno rubato anche il resto, per avidità ma soprattutto per confondere le cose. Forse lei conosce questi assassini, anche se non ha mai supposto che fossero dei delinquenti». «No, non ho proprio nessun sospetto...» disse. Mentiva, ma il maresciallo non lo poteva immaginare. Arrivò a Torino dopo le quattro, perché era troppo scossa e guidava pianissimo. Fermò in corso Cairoli, vicino al fiume, ed aspettò. Doveva aspettare le sette, ora in cui avrebbero aperto i portoni. Aveva quindi tempo per riflettere. Lei non amava portare uomini nella sua villa a Dogliani, non solo per i pettegolezzi, ma perché tra quelle mura aveva vergogna della sua condotta tanto disinvolta. Aveva fatto solo tre eccezioni, la prima col padre del suo piccolo Ludovico che, ignaro di essere padre, era poi scomparso dalla sua vita. La seconda con uno studente contestatario francese che appena aveva visto l’armeria al terzo piano, si era messo a gridare. Nessuno di questi due uomini poteva essersi messo a capo della squadra di assassini che avevano trucidato il vecchio Marco e Lillina. Però c’era un altro uomo che lei, in un momento di debolezza, aveva portato nella villa: Righetto, il pataccaro romano. Alle sette meno dieci prese dal baule la scatola con le due grosse Dakota calibro 22. Riempì il tamburo di proiettili e mise le Dakota nella grande borsa che si era portata apposta. Alle sette, appena aprì il portone, entrò nell’ambigua pensione di Righetto, e l’ambigua padrona, nonostante l’ora mattutina, la fece entrare con un equivoco sorriso. «Credo che dorma», le disse. Beatrice Laederys entrò, richiuse la porta, aprì di scatto la borsetta, prese la Dakota e fece scattare la sicura. Il sinistro clic svegliò di colpo il giovane pataccaro. «Ma sei matta?» «Buttati a terra a faccia in giù o ti faccio saltare.» Righetto era un ragazzo intelligente e ubbidì prontamente. «Ieri nel pomeriggio, mentre ero con te», continuò Beatrice, «una squadra di assassini è andata almeno con un paio di camion alla mia villa a Dogliani, e l’ha saccheggiata completamente, specialmente ha portato via tutte le armi che serviranno certo per rapine e cose del genere. Non basta, questa banda ha ucciso un povero vecchio, il custode, e ha ucciso la sua nipotina di quattordici anni dopo averla selvaggiamente seviziata. Questi assassini erano perfettamente informati di tutto, sapevano dove trovare la roba e che roba c’era, e sapevano che io ero qui a Torino con te... Quindi sei stato tu che li hai informati, perché tu sei stato nella mia villa e hai visto tutto. Tu hai venduto le informazioni a quei banditi e certamente ti avranno pagato bene. Adesso tu mi devi dire il nome di questi assassini ai quali hai venduto le informazioni...» «Ma io non so niente, Beatrice, te lo giuro, non so come ti sei messa in testa queste cose!» lui mentiva faccia a terra. Lei tese il braccio e prese la mira. Sparò, mirando alla gamba destra. Il proiettile calibro 22 entrò nel polpaccio come un dirompente e spezzò anche l’osso. L’urlo di Righetto quasi coprì la detonazione. «Dimmi il nome, altrimenti sparo più in su.» «Non so niente, non so niente», lui urlò. Voleva richiamare gente, con quelle urla, e infatti la padrona della pensione che aveva udito lo sparo, accorse e bussò: «Ma che cosa succede?». «Signora, si tolga dalla porta perché sparo», disse Beatrice, e infatti sparò due colpi, uno contro la porta, e il proiettile passò dall’altra parte come attraverso il burro, e il secondo contro Righetto, mirando alla coscia sinistra. «Cerca di dirmi i nomi di quegli assassini, se no sparo ancora più in alto, e non ti conviene. E non aspettare che venga la polizia a fermarmi, perché appena arriva ti finisco.» Gemendo e mugolando per il dolore, Righetto cominciò a fare i nomi dei suoi amici e dove lei li avrebbe potuti trovare. Non mentiva, sentiva la morte alle sue spalle. Con la Dakota nella sinistra, Beatrice scrisse con la destra tutto quello che lui le diceva. Aveva appena finito di scrivere che bussarono energicamente alla porta. «Polizia!» «Apro subito», lei disse. Guardò disteso in terra colui che era il vero colpevole del massacro della povera Lillina e del vecchio Marco, e che se la sarebbe cavata con due o tre anni di carcere. Per questo aveva detto no, al maresciallo, che non aveva alcun sospetto, su nessuno. Due o tre anni erano davvero una pena irrisoria, per un delitto così atroce. «Aprite, polizia, o sfondiamo la porta!» Beatrice Laederys, prima sparò, ma non più in basso: in mezzo alle spalle, poi aprì la porta e consegnò subito la Dakota ai carabiniere. «Questo era il principale colpevole, poi ve lo spiego», disse, «e su questo foglietto ci sono i nomi degli assassini suoi compari.» Al suo avvocato, in carcere, Beatrice disse: «Dica al mio bambino Ludovico che sono andata a fare un lungo viaggio per cercare delle rivoltelle atomiche. È una scusa che crederà di sicuro...». 67 · Gliela lasciarono baciare Quella mattina lo vestirono molto bene, anche con i guanti e la sciarpa bianca sotto il paltò, e anche papà e mamma si vestirono molto bene e lui sapeva perché erano tutti vestiti così bene e ciò che andavano a fare. Al mare il nonno diceva sempre: «I maschi devono giocare coi maschi, e le femmine con le femmine.» E, legnoso, peloso, energumeno pur coi suoi settant’anni, in calzoncini da bagno, vegliava sulla bionda, fragile cugina di lui, di lui che poteva sorriderle solo passando accanto a lei col pallone, o dirle buongiorno, e non starle vicino, come gli occhi di lei dicevano di desiderare; non baciarla, come oscuramente desiderava lui, da quell’anno, che erano divenuti grandi e non li lasciavano più insieme e tutto quell’estate, e poi l’autunno lui si era bruciato in quel sordo tendere a starle vicino, a baciarla, ma lei era sempre sorvegliata. Tutti vestiti così bene, quella mattina, però, lo portarono in casa della cugina, e lui sapeva perché, e papà gli disse di non piangere e di fare esattamente come faceva lui, e papà entrò nella bella stanza dove c’era anche molta altra gente, si avvicinò al letto carico di fiori, e baciò la bambina che sembrava dormire, e anche mamma si avvicinò e la baciò, e poi lui, il giovane cugino, vestito così bene, come una copia in piccolo del padre, con guanti scuri e la sciarpa bianca, si chinò, senza piangere, ma avrebbe pianto dopo, e baciò per la prima volta, finalmente e disperatamente, la bionda fragile cugina ammazzata, lui non lo sapeva esattamente, aveva appena ascoltato qualche discorso confuso, ammazzata dopo essere stata seviziata da un bruto di settant’anni, la stessa età del nonno, uno che con il nonno giocava a carte e a bocce: la bionda, infranta cugina troppo lontana ormai e insensibile per sentire quel bacio come avrebbe voluto sentire. 68 · Il marito dell’amazzone Dopo la dodicesima partita a biliardino, aveva anche vinto, lui s’avviò piccolo e felice, tutto rosso violaceo di pelle perché era il secondo giorno che era al mare, verso l’ombrellone giallo alla cui ombra stava accosciata lei, sola, con la grande oca di plastica, grande quasi quanto lei e una radiolina con la pila scarica che emetteva i suoi ultimi gemiti, soffiando e muggendo, e, arrivato, sedette davanti a lei, accendendo una sigaretta. «Ho vinto nove partite», disse felice fissando lo scialbo, amato viso attraverso il lungo collo dell’oca. «Non stai mai con me...» lei si lamentò con dolcezza, «ieri sera hai giocato a carte fino alle due, stamattina sei andato a pescare e adesso è tutto il pomeriggio che giochi a biliardino. Non hai mai fatto così.» Non rimproverava, era un dolce lamento. Non aveva mai fatto così, lui lo sapeva, in otto anni di matrimonio, non l’aveva mai lasciata un istante, non la lasciava mai neppure uscire sola, legato come schiavo a lei da un’angosciosa gelosia. Eppure era la stessa di ora, scialba, impersonale, tranne il seno. Ricordava gli sguardi degli uomini su quel seno alto, vivo, che niente poteva nascondere, né accollature, né abiti scuri; che guizzava, palpitava anche sotto il paltò; non l’aveva mai portata al mare, né a ballare, per questo, ma poi c’era stata quella terribile infezione e lei era uscita dalla clinica come un’amazzone, priva della mammella destra, e la sinistra, più che sfiorita, estinta. Era stato tragico, anche lui aveva pianto e si era disperato per lei, poi si era accorto che non doveva più sorvegliarla, nessuno gliela concupiva più, era libero di andare con gli amici, di stare fuori la sera. «Dopo pranzo andiamo a ballare, sei contenta?...» disse; ormai non c’era più pericolo che gliela rubassero. 69 · Con la musica è bello Ecco, la radio, miracolosamente, funzionava ancora, anzi, dopo lo schianto qualche contatto stringeva meglio e la voce si levava potente, molto più forte di prima quando loro l’ascoltavano e ora non più, lei esplosa contro il parabrezza che aveva sfondato con la gonfia crinita testa, e quindi era volata via, sbattuta contro le travi metalliche del traliccio dell’alta tensione tra le quali si era infranta ogni sua corporea bellezza; e lui annichilito e compresso contro il volante; e per la piccola strada tra i campi dove avevano cercato rifugio ne avevano trovato uno definitivo cui non pensavano, così ardenti di desiderio com’erano un attimo prima. Solo lontano, sullo stradone, si vedeva qualche faro di macchina, ma tutto intorno era profondo buio, dove la voce di una donna si levava altissima dalla radio cantando. Dopo molto i due giovani che passeggiavano stretti dal vicino paese si avvicinarono, nulla vedendo nel buio, solo attirati da quella acerba e melodiosa voce che cantava dalla radio, viva tra morti. «Mettiamoci qui, Chicca, così sentiamo anche la musica...» disse lui, la fece sedere sull’erba accanto a sé. «Stiamo meglio noi due qui, che quelli in macchina, in macchina non mi è mai piaciuto.» La strinse. «Lasciami sentire la musica...» disse lei, languida, ma già non sentiva più. «Con la musica è bello, no?...» lui disse, ma non sentiva più neppure lui la pur altissima voce: «Perché perché mi lasci sempre sola la domenica...». 70 · Oltre la morte La vecchia spiò dall’uscio: sua figlia stava ascoltando dei dischi, una musica estranea, roca, come suonata da strumenti scordati, rotti, eppure lamentosa; si vergognava un poco, lì, sulla porta, con quella ingiallita fotografia in mano, ma doveva sapere, doveva sapere, doveva sapere, se no non avrebbe avuto più pace, non avrebbe più dormito, né vissuto. Allora entrò e con gesto goffo tese la foto alla figlia, al di sopra della musica, al di sopra dell’espressione chiusa, nervosa di sua figlia. «Sai chi è?» disse, senilmente isterica. La ragazza che non l’aveva ancora vista pur vedendola, si stirò come si svegliasse, riemergendo dal subacqueo rauco mondo della sua musica, guardò la foto, guardò la madre. «Non ne so niente», disse, gentile. «Eh, no», la vecchia gridava anche se il disco suonava basso, «tu lo sai, chi sa le volte che hai tenuto mano a tuo padre, te le faceva anche conoscere, le sue donnacce...» La ragazza spense il giradischi. «La vuoi smettere?» disse guardandola con pietà e con fastidio. «Papà è morto da due anni. Lascialo in pace, almeno adesso che è morto.» Ma era lei, la vecchia, che non riusciva a stare in pace. «L’ho trovata in un libro che aveva nascosto in una valigia, deve essere una straniera che ha conosciuto in viaggio», gridò alla figlia. «Una tedesca, è anche bionda, e tu lo sai chi è.» La ragazza scosse il capo, niente da fare, la gelosia di sua madre scavalcava anche le tombe, forse era morta anche la ragazza della foto, ma non per la madre che la vedeva viva tra le braccia di papà vivo anche lui. 71 · La signora ha freddo Il primo tavolo di marmo, entrando, era vuoto, pulito e lucido sotto la luce accecante dei due tubi al neon che attraversavano tutto il locale. Il secondo tavolo, invece, era pieno. C’era qualcosa sotto il lenzuolo di plastica. «Se la sente di guardare?...» disse il brigadiere. Morini o Marini, un cognome del genere. Si era compitamente e pedantemente presentato, quando le era apparso in casa con quella storia della macchina. Era un piccolo uomo un poco frusto, eppure lei aveva cominciato a tremare. Si ripeteva di star calma, una storia assurda che non la riguardava, inammissibile che la riguardasse. Il piccolo uomo un poco frusto, ma tenace, che si chiamava Marini o Morini, era, al contrario, di un’altra idea, dell’idea opposta addirittura. «Allora, signora?...» disse il brigadiere. Isabella Quarini di Varga annuì. «Signora?...» disse il brigadiere. Non si accontentava di un cenno della testa, voleva la sua voce. Lei si sforzò di recitare: «Le ho già detto di sì». Il brigadiere sorrise. O almeno atteggiò la faccia avvizzita a una smorfia che nelle intenzioni doveva essere un sorriso. Ovviamente non ne venne fuori un sorriso. La smorfia, casomai, risultò patetica. «Non mi sembra... Le chiedo scusa, comunque. Forse sto diventando sordo...» Puntò l’indice verso il secondo tavolo. L’inserviente tolse il lenzuolo di plastica. Realmente, sotto, c’era una cosa, definirlo un corpo sarebbe stato veramente troppo. «Signora», disse il brigadiere, «le chiedo di aiutarci a capire perché questa donna si trovasse sulla sua macchina stanotte, sull’autostrada MilanoBergamo, quando è avvenuto l’incidente... Non la riconosce?...» Lei continuava a tremare. Lì dentro faceva freddo. Non era per il freddo, comunque, che batteva i denti. Però lei aveva sempre avuto coraggio, tirò su la testa, recitò persino meglio di prima: «E se lo chiedessi io a lei, di aiutarmi a capire, brigadiere?... Non ricordo il suo cognome...». «Morini», sospirò il piccolo uomo. «Ma è proprio sicura di non riconoscerla, questa donna, signora?...» La smorfia della faccia avvizzita diventò più patetica che mai. «Vede, signora, dai documenti capitati nelle nostre mani, questa donna risulterebbe al suo servizio da... un anno, presso a poco, tredici mesi... Oscarin Marcella di Mogliano Veneto, di anni diciannove...» L’ufficio in questura era peggio che triste, squallido. Il brigadiere Morini disse: «Dunque, era la sua domestica... E come mai la sua domestica guidava una macchina intestata a lei?...». Era la risposta che lei andava provando dentro di sé da un poco. Non sapeva se quella messa insieme potesse funzionare, ma in qualche modo doveva rispondere. Irrigidì la schiena contro la sedia. «Ogni tanto io davo le chiavi della mia milledue a Marcella, quando aveva il suo pomeriggio di libertà. Noi abitiamo a San Siro, lei andava in centro, anche a fare qualche piccola spesa, altrimenti avrebbe perso troppo tempo e sarebbe tornata a casa tardi.» Sentì che il brigadiere non era invece molto convinto che una signora lasciasse le chiavi della propria macchina alla domestica. Allora aggiunse: «Nel box della villa ci sono anche un’Alfa e una Ferrari...». Il brigadiere non parlò per un poco, poi disse: «Nella borsetta della ragazza perita nell’incidente non è stata trovata la patente, né tra i rottami dell’auto. Ma certo la ragazza doveva avere la patente, se lei le lasciava l’auto...». «Oh, sì», lei disse, «mi ha detto che aveva la patente.» «Gliel’ha soltanto detto o le ha mostrato effettivamente la patente?» «No, la patente non l’ho vista mai, ma Marcella mi ha assicurato che l’aveva.» «Prima di dare le chiavi della propria auto a una ragazza di diciannove anni bisogna assicurarsi che abbia la patente, altrimenti lei è corresponsabile.» Ancora silenzio, poi il brigadiere domandò: «C’è un particolare che risulta poco chiaro. Lei ha detto che lasciava la milledue alla sua domestica perché potesse andare in centro a fare delle compere senza perdere troppo tempo... Il fatto, però, è che l’incidente non è accaduto nel centro di Milano, ma sull’autostrada per Bergamo, proprio al principio. La guidatrice, certo inesperta, appena imboccata l’autostrada è andata a finire con l’auto sotto il rimorchio di un autotreno...». Lei rifletté, poi disse, di nuovo con molta cortesia: «Non so che cosa dire. Io le davo l’auto solo per girare in città. Evidentemente Marcella ha approfittato della mia concessione». «È evidente», disse il brigadiere. «Ma c’è un altro particolare, la ragazza aveva in borsetta quattrocentomila lire...» L’agente in divisa sulla porta tossì e quello fu l’unico suono per quasi un minuto. «Lo stipendio non è certo un mistero, le davo settantamila lire al mese. Siccome in casa aveva tutto, compresi anche molti oggetti di vestiario, non è difficile che abbia potuto mettersi da parte quella somma, lavora in casa mia da quasi un anno.» «Ma non potrebbe darsi che abbia portato via quel denaro da casa sua?» «Non è possibile...» disse lei, «in casa non abbiamo quasi niente liquido, solo gli spiccioli per le mance e qualche diecimila lire per la benzina. Per il resto paghiamo i conti con assegni. Quattrocentomila lire liquide non le terremmo mai in casa nostra.» «Capisco», disse il brigadiere. «Ci sono ancora delle pratiche sgradevoli. Me ne spiace molto. Ma verrà fatta l’autopsia della ragazza, poi dovremo vedere se la ragazza avesse la patente o no, può darsi che l’avesse e non l’abbia portata con sé, comunque può darsi che debba ancora disturbarla...» Si alzò, era come la scrittura esibita su quel foglio, tutto asprezze e svolazzi, un piccolo uomo cortese e temibile. «Non ne abbia alcun timore», lei disse con infinita cortesia. Guidò la sua Alfa grigio piombo fino a San Siro, davanti alla tristissima villa che suo padre aveva avuto la tristissima idea di farsi costruire lì. Sotto la pioggia e nella nebbia vide Carlo, in giacca a righine e con l’ombrello, venire ad aprirle il cancello, e, appena gliel’ebbe aperto, lei schizzò con l’auto per il vialetto fino davanti a una delle tre porte del box, facendo una brusca frenata lacerante. Lasciò la macchina lì, che ci pensasse Carlo a ripararla nel box, e salì la breve gradinata che conduceva nella villa. Vide subito Arturo che le veniva incontro e un’ondata di furore la sconvolse. Ma si dominò e, pur rifiutando di essere abbracciata da lui, gli disse: «Andiamo in studio, devo parlarti...». Lo studio era lo studio di papà, professore di storia, era freddo, del resto come tutta la casa. Telefonò irritata in cucina: «Per favore, c’è qualcuno che può venire ad accendere il caminetto nello studio?». «Sì, signorina, subito, mando subito Carlo», disse Vera. Isabella depose il ricevitore, guardò Arturo in piedi vicino al termosifone. Arturo le disse: «Questa è la stanza più fredda della casa», sorrise, con tenerezza e con puerilità, ma anche con una certa volgarità, «non vorrai farmi prendere un mal di gola, così non posso più cantare...». Lei lo guardò con odio. Doveva confessarsi che, nonostante tutto il trasporto caldo e sensuale che provava per lui, vi erano dei momenti in cui lo odiava sinceramente. «Lo sai che sono stata chiamata dalla polizia?...» gli disse. Andò anche lei vicino al termosifone, anche lei appoggiò le mani sui tepidi elementi. «No», lui disse, carezzando il termosifone. «Quindi non sai neppure perché sono stata portata prima all’obitorio e poi in questura.» «Eh?...» disse lui. «Sì, all’obitorio, e poi in questura...» lei ripeté. «Ma perché?» lui disse staccandosi dal termosifone, un poco allarmato. «Perché Marcella questa mattina all’alba, sull’autostrada per Bergamo, è andata contro un grosso autotreno guidando la milledue, e si è uccisa», lei disse anche a voce molto bassa, poi d’improvviso perse il controllo, la voce le divenne rauca e gridò: «E vuoi che ti spieghi chi è Marcella, o meglio chi era, prima che tu faccia finta di non ricordarti neppure di chi si tratta? E vuoi anche ti spieghi che Marcella guidava la milledue di cui tu hai la chiave, e che Marcella è quella ragazza che serve in tavola quando noi ceniamo qui a casa, col grembiulino nero così attillato che tu giri la testa, da cafone come sei, seguendola con gli occhi, sfacciatamente, davanti a me?». Non smise di gridare, riprese solo appena fiato, e continuò: «Ti sto dicendo che Marcella è la nostra domestica e che tu le hai dato la chiave della macchina, oppure che te la sei portata a spasso con la mia macchina, la mia benzina e le avrai dato forse anche i miei soldi, perché aveva quattrocentomila lire nella borsetta e poi l’hai lasciata lì, così che lei, che non sa guidare, che non ha la patente, è andata ad ammazzarsi sotto un camion...». Inginocchiato davanti al camino, Carlo, correttissimo nella sua giacca a righine, aveva acceso il fuoco. «Sei pazza», disse Arturo, quando Carlo andò via, guardandola, davvero come la credesse pazza. «Allora domattina leggerai i giornali», lei disse, ma a voce ora molto bassa, vincendo il suo furore. «Domestica di giovane nobildonna milanese si sfracella sotto un camion con l’auto della padrona. Ti piace questo o vuoi di più? Ecco un altro titolo: La ragazza era sola o era accompagnata da qualcuno?» Arturo sedette sulla poltroncina davanti al camino, guardò le fiamme che cominciavano a bruciare intorno ai piccoli ceppi, disse senza volgersi verso di lei, con quella sua voce-flauto che chi sa che successo avrebbe avuto se non ci fosse già stato Bobby Solo: «Sei proprio pazza, stai straparlando, la chiave della milledue io la lascio sempre in auto, caso mai è Carlo che ha la chiave di tutte e tre le macchine perché è lui che le mette e le tira fuori dal box. Perché te la prendi con me? Che c’entro io in questa storia? Se si è ammazzata in auto, che c’entro io? Perché la guardavo quando serviva a tavola con quei grembiulini stretti? Certo che la guardavo, mi faceva ridere». Lei si sentiva stanca, ma doveva spiegargli che cosa stava succedendo. «Sta’ a sentire, tu sai meglio di me che Marcella non avrebbe saputo guidare neppure un triciclo in un giardino infantile, quindi non poteva guidare la macchina da qui fino all’autostrada per Bergamo attraversando tutta la città. Quindi qualcuno deve averla accompagnata in macchina fino all’autostrada, almeno fino all’autostrada. Io ho detto alla polizia che usavo dare la milledue a Marcella quando era di libera uscita, ma tu sai bene che è una bugia. L’ho detto perché ho capito che c’eri di mezzo tu e ho voluto evitare del chiasso sul tuo nome, e sul mio, ma sei stato tu che hai accompagnato Marcella in macchina.» Arturo si alzò lentamente dalla poltroncina, era uno dei tanti giovani pallidi con molti capelli neri sul viso e sul collo, l’abito grigio scurissimo che, fra i tanti che lei gli aveva fatto fare, s’intonava molto al suo pallore. Di solito l’espressione era mite, timida, quasi ritrosa, ma in quel momento fu rabbiosa e villana, anche se parlava a bassa voce sullo scoppiettio dei ceppi che cominciavano a bruciare. «A te ti fanno male i sonniferi, ti fanno male tutte le vodke che bevi a cominciare dal mattino presto e ti fanno male anche i tuoi avi che ti montano la testa. Io sarò quello che sarò, però non ho mai fatto la corte alle tue cameriere, e ora comincio a essere stufo delle tue crisi. Se la tua cameriera si è ammazzata in un incidente d’auto io non c’entro, io, la chiave dell’auto, non gliel’ho data, te l’ho già detto che può avergliela data Carlo, o anche la cuoca, tra domestici s’intendono bene, e può avergliela data anche tuo fratello, se vuoi saperlo, essendo regolarmente ubriaco dal mattino alla sera, può fare qualunque cosa, anche incendiare la villa.» Andò verso la porta. «E adesso basta. Io sono un volgarissimo cantante e tu una supernobildonna, però sei troppo pazza per i miei gusti semplici e popolari...» Lei lo rincorse prima che aprisse la porta. «No, resta qui, sono sconvolta, ho visto quella ragazza, tu non immagini come era ridotta, l’ho riconosciuta quasi soltanto dalle scarpe che aveva, erano quelle blu scuro che le avevo regalato proprio due giorni prima...» Fu felice che lui la stringesse un poco, ricambiando la sua stretta. «Sai, ci sarà un poco di scandalo, e sono molto sensibile a queste cose.» Si vergognava un poco. Di tutto, di tenersi in casa quel ragazzo che le guardava le camerierine pimpanti e anche la giovane cuoca che camminava dimenandosi, si vergognava di suo fratello che beveva fino all’abbrutimento e a trentanove anni era un uomo finito, e infine si vergognava di sé stessa, di come era inerme e debole, e disponibile a ogni errore, da quando suo padre non c’era più ed era rimasta sola. E, vergognandosi un po’ di tutto, si strinse ancora di più a lui e lo baciò. «Mi spiace di averla dovuta disturbare ancora una volta», disse il brigadiere Morini con quello sguardo freddo e temibile. «Non vorrei averla disturbata inutilmente.» Il brigadiere aprì un cassetto, ne tolse un piccolo foglio, né lo lesse, né glielo fece leggere, solo disse: «Questa è una dichiarazione dell’Ispettorato della motorizzazione civile di Milano in cui si afferma che la detta Marcella Oscarin di Mogliano Veneto ha preso la patente qui a Milano, sei mesi fa». Lei sorrise. «Sono contenta. Vede che la mia domestica mi aveva detto la verità quando mi aveva detto di avere la patente.» Ma dentro di sé non sorrise, dentro di sé si sentì un poco come morire. Marcella sapeva guidare, una ragazza venuta dalla campagna che non distingueva un trinciapollo da una forbice aveva preso la patente di guida mentre era al suo servizio. Come aveva fatto? Chi l’aveva aiutata? «C’è un’altra cosa della quale non sarà molto contenta», disse il brigadiere, questa volta anche la voce era temibile. «L’autopsia ha accertato che la ragazza aveva nel sangue una percentuale molto alta di barbiturici.» Lei non disse nulla, pensava soltanto, pensava: barbiturici, cioè sonniferi, cioè Marcella era al volante della milledue carica di barbiturici, cioè di sonniferi, cioè guidava e dormiva. Il brigadiere continuò: «Vorrei spiegarle che cosa questo significa. Al principio si tratta di un incidente stradale: un’auto s’incastra sotto il rimorchio di un autotreno sull’autostrada. È un po’ strano che l’auto, di proprietà di una nota signora milanese, sia guidata dalla domestica e che la domestica abbia in borsetta quattrocentomila lire, ma sono particolari. Adesso, però, dopo l’autopsia, noi sappiamo che la ragazza guidava in stato di crescente sonno, provocato dai barbiturici. Che cosa dobbiamo pensare di questo fatto?» «Vede», spiegò il brigadiere con gelida cortesia, «le ipotesi sono due. O suicidio, o assassinio. L’incidente di macchina è scartato: uno non prende dei sonniferi prima di imboccare un’autostrada, e la perizia ha stabilito che la sua domestica ha preso i sonniferi mezz’ora prima della sua morte, e mezz’ora è il tempo necessario e sufficiente perché un barbiturico possa avere effetto durevole. D’altra parte riteniamo che anche il suicidio possa essere escluso. Una persona che prende del sonnifero per suicidarsi, non salta poi in auto sull’autostrada per Bergamo. Direi che si stende su un divano ad aspettare la fine.» Era anche troppo logico e lei non aveva nulla da dire o da commentare. «Resta dunque l’assassinio», disse il brigadiere, una voce così pacata che sembrava stesse parlando di quello che avrebbe preferito mangiare a colazione, ma quello sguardo così chiaro, e gelido e temibile, che riusciva a scuotere l’alterezza di lei che ascoltava alteramente. «Da quasi un anno lei ha avuto alle sue dipendenze questa ragazza», disse il brigadiere, «lei può forse dirci se fosse fidanzata, o se parlasse di qualcuno.» Lei scosse subito il capo. «No, Marcella non mi ha mai parlato di nessuno.» Il brigadiere si alzò e disse con quella sua voce pacata che poteva incutere più paura che se avesse urlato: «Si tratta di un assassinio. Hanno messo la ragazza al volante dell’auto dopo averle fatto ingerire una dose molto forte di sonnifero. L’incidente, che non è stato un incidente, non è accaduto perché la ragazza non sapeva guidare, dato che aveva la patente e sapeva guidare, ma perché era sotto l’effetto del sonnifero. Dovremo fare delle indagini molto rigorose su questo punto. Sarà meglio che si tenga a disposizione della polizia.» Non disse neppure di sì: era ovvio che doveva tenersi a disposizione. Tornò a casa. Piovigginava sempre e c’era sempre nebbia, specialmente lì a San Siro. Una nebbia così fitta che distinse appena l’ombrello nero tenuto da Carlo e la giacca a righine di Carlo. Come sempre, appena Carlo ebbe aperto il cancello schizzò rombando verso i box e arrestò l’Alfa a due centimetri dalla saracinesca. «Buonasera, signorina», disse Carlo, sotto l’ombrello, e sotto la pioggia, e sotto la luce dei fari. Lei lo guardò, solo un attimo, quel viso grassoccio e flaccido e vecchio, eppure con un che di equivoco, di falso, e pensò in quell’attimo che Marcella era una domestica, e quello era un domestico, e che la morte di Marcella poteva trattarsi di una questione tra colleghi. Che ne sapeva lei? Poi smise di guardare l’ossequiente individuo sotto l’ombrello, e fumoso nella nebbia, ed entrò in casa. Non c’era nessuno, né suo fratello, né Arturo: a metà pomeriggio gli uomini non stanno in casa, specialmente in una casa come quella, sprofondata nella solitudine. Allora fece un bagno e dopo il bagno andò m cucina e trovò Veruska, come la chiamava, ma il suo nome era semplicemente Vera, la giovane cuoca, e aiutata da lei si preparò un panino farcito con carciofini, e, cominciando a morderlo, guardò la ragazza Era piuttosto bellina, meno bella di Marcella, ma piaceva parecchio anche a suo fratello, tanto che Veruska si era lamentata con lei, e lei aveva dovuto litigare col fratello. La guardò, così come aveva guardato Carlo, pensando che era una storia tra domestici, che Marcella forse era morta così, per rivalità e gelosie tra colleghi. Poi si fece dare un bicchiere di vino bianco ghiacciato e fu mentre glielo versava nell’alto calice con mano tremante che Veruska disse: «Signorina, io non ne posso più», e gli occhi le si riempirono di lacrime. Lei disse dolcemente, fraterna: «Dimmi». Temeva di immaginare. Suo fratello era tornato a darle fastidio. Che fosse stato suo fratello ad avere la velenosa idea di addormentare Marcella e di metterla in macchina perché andasse ad ammazzarsi? Con tali gentiluomini in casa, nulla era da escludersi. Attese ancora una parola da Veruska, ma la ragazza si era messa a piangere. «Avanti, cosa c’è?» Cominciò a innervosirsi, posò il panino che aveva mangiato a metà sul grande tavolo di marmo. Ancora per un poco la ragazza continuò a piangere senza parlare, poi cominciò ad asciugarsi gli occhi e parlò. Parlò molto. Lei, Isabella Quarini di Varga, andò a distendersi sul letto alle undici dopo aver visto alla televisione un film su una spedizione al Polo Sud. Non dormì, non lesse, non spense la luce. Continuava a pensare, tante cose forse sciocche, del perché si era innamorata di una voce, che senso ha innamorarsi di una voce? Così, poco dopo mezzanotte, sentì benissimo suo fratello che rientrava, era venuto in tassì e fece un sacco di rumoracci per aprire il cancello, per aprire la porta della villetta, per accendere le luci e aprire le porte. Invece, solo verso le due arrivò Arturo, il rombo di una Ferrari è distinguibilissimo. Naturalmente, dopo una decina di minuti, mentre era seduta sul letto e lo attendeva, sentì la maniglia della porta cigolare e lui entrò. «Scusami, ho fatto più tardi di quello che volevo.» Sì, lei lo sapeva, andava al Medusa o al Cirano’s a cantare le sue canzoncine, l’empito dell’arte e le ragazzòle che giravano per quei locali lo prendevano e allora faceva tardi, non gli davano niente, solo da bere e da mangiare, ma a lui sembrava di avere la gloria. «Non fa niente», lei disse, distendendosi sul letto completamente vestita, cioè col bel tailleur celeste col quale era stata distesa sul letto fino ad allora. «Volevo solo dirti che tra qualche minuto arriva la polizia ad arrestarti.» Non lo guardò neppure, non le interessava che espressione potesse avere, ma ascoltò la sua voce che, dopo la brusca dichiarazione, divenne come improvvisamente vecchia, invece che flautata. «Hai chiamato la polizia?» Stava in piedi, davanti a lei distesa sul letto, col suo smokinghino da ex magliaro, da bru bru. «Perché hai chiamato la polizia?» Lei continuò a parlargli distesa sul letto, nel suo bel tailleur celeste, e con le scarpine classiche, rigidamente composta. «Perché tu hai ucciso Marcella», lei disse signorilmente, ma inflessibilmente. «L’hai mandata fuori di qui, dandole la chiave della milledue, dopo averle fatto bere un tè carico di Vantotal, combinazione lo stesso sonnifero che uso io e che infatti hai preso dal mio bagno. Tu sapevi benissimo che dopo venti minuti, mezz’ora al massimo, Marcella non sarebbe stata più in condizione di guidare e che sarebbe avvenuto un incidente mortale. E infatti è stato così...» Arturo si avvicinò ancora di un passo. «Tu stai delirando.» «Non sto delirando, tu volevi uccidere Marcella e ci sei riuscito.» Lui fece ancora un passo. «Cerca di calmarti, Isi, forse hai bevuto, forse ho bevuto io e ho un’allucinazione.» Ma, inflessibile, lei disse: «No, non hai allucinazioni. Ti sto dicendo che tu hai assassinato Marcella, con una specie di delitto perfetto, l’hai buttata in macchina sbronza di sonnifero, così che andasse ad ammazzarsi da qualche parte». «Ma perché l’avrei fatto?» Il pallido Arturo cominciò ad alzare la voce. «Che c’entro io con le tue domestiche?» Lei si mise a sedere sul letto. «Perché sono carine, giovani, e io, così, un poco appassita, non riesco a tenerti tutto. Poi perché sono qui, a portata di mano, in casa», concluse. «Non hai pensato, però, che una domestica, cioè Marcella, si sarebbe approfittata delle tue attenzioni verso di lei: ha cominciato a ricattarti, a dirti che sarebbe venuta a raccontare tutto a me, se tu non la sposavi davvero come le avevi promesso, perché tu prometti a tutte di sposarle, dimenticando il particolare che sei già sposato, non ho voluto neppure indagare con chi. E tu avevi paura che lei raccontasse tutto a me, che mi raccontasse che l’avevi perfino aiutata a prendere la patente, perché avevi paura di perdere il comodo posto che avevi qui con me.» Si alzò, sdegnata di essere arrivata a quell’abiezione, e, anche se a voce bassa, parlò ancora più gelidamente: «E per non perdere questo posto che cosa hai fatto? Hai imbottito di denaro la povera Marcella dicendole di andare al suo paese, a Mogliano Veneto, dove tu l’avresti raggiunta, l’hai imbottita di promesse dicendole che l’avresti presto sposata e l’hai imbottita di sonnifero perché, guidando l’auto, si sfracellasse contro qualche cosa in modo da liberarti per sempre da un’ingenua e infiammata domestica che poteva rovinarti la carriera». Gli andò incontro, lo oltrepassò, aprì la porta della stanza. «È meglio che tu esca, ho chiamato la polizia e sta arrivando.» Lui non si mosse, stette rigido, seguendola solo con lo sguardo. «Quando hai sognato queste cose? Dopo quattro pastiglie di Vantotal e quattro vodke?» Appoggiata alla maniglia della porta, perché si sentiva anche molto debole, lei disse: «Non le ho sognate. Me le ha dette Veruska, forse te la ricordi», disse ironicamente, «è la cuoca. Veruska era un’amica di Marcella, Marcella faceva tutte le sue confidenze a Veruska...». Lui la interruppe, sarcasticamente: «E Veruska come fa a sapere che io ho dato il Vantotal a Marcella?» Respirò profondamente: «Stai delirando, Isi, non puoi credere alle insulsaggini velenose di una cuoca». Quando la chiamava Isi, per una infantile sensibilità, lei si sentiva commossa, e dovette fare uno sforzo per vincere quella commozione. «Non perdere tempo», gli disse, ferma e precisa. «Dopo quello che mi ha detto Veruska ho chiamato la polizia. Fra qualche minuto arriva. Veruska non sa che tu hai dato le pastiglie di Vantotal a Marcella, lo hanno scoperto con l’autopsia. Se vuoi fuggire, non hai molto tempo. Ti consiglio di non prendere la Ferrari, è troppo conosciuta, meglio che ti perdi a piedi.» Se fosse rimasto, voleva dire che era innocente, che non aveva paura della polizia, che erano solo calunnie di una cuoca pettegola, e dentro di sé si sentì accendere da questa speranza: non era lui, non era lui, non poteva essere lui. Invece lo vide avere una terribile, amarissima smorfia con la bocca, sembrava perfino che volesse sputarle addosso, poi lo vide correre goffamente fuori della stanza. Poco più tardi sentì il rombo della Ferrari che partiva: i cretini sono sempre cretini, e, benché lei lo avesse avvisato che era meglio che non partisse con una macchina tanto riconoscibile, quello era partito con la Ferrari. Allora richiuse la porta e andò a sedersi sul letto. Il curioso, in quel fallimento di lei, dei suoi sentimenti, era che lei non aveva per niente avvisato la polizia. 72 · Il vecchio c’è riuscito Era uscito dall’ufficio molto tardi perché l’amministratore delegato lo aveva trattenuto quasi un’ora, praticamente gli aveva consegnato l’ufficio, ma aveva fatto ancora in tempo ad andare dal dottore, e lì era passata un’altra mezz’ora, col dottore che tentava di ingannarlo: «Ma oggi, cosa vuole, è un’operazione da niente», e lui che aveva avuto e aveva troppi amici dottori per non sapere che era l’ultima inutile operazione senza speranza, e che gli rispondeva: «Sì, sì» come se ci credesse, e l’unica cosa che sapesse e credesse veramente, mentre il dottore gli mostrava la radiografia, commentandola con inutile bonarietà che non poteva rasserenarlo, era che l’anno dopo, al massimo, sua moglie e i due figli sarebbero venuti a trovarlo al cimitero, e se li vide, in piedi davanti alla sua tomba. Poi, salutato il dottore, mentre guidava la macchina verso casa, cercò di mandar via quell’immagine e ci riuscì, e si fermò anche davanti al bar, dove prese un aperitivo, ormai non gli poteva fare più male nulla e si fece dare anche una bottiglia di spumante, perché doveva festeggiare l’altro evento, poi salì a casa, suonò il campanello, e vennero tutti ad aprirgli, perché attendevano la notizia, da tempo in gestazione, la moglie ancora così giovane e rosea, e i due figli così lunghi, il teddy boy e la teddy girl, come li chiamava, e lo guardarono ansiosi. «Ohé, il vecchio c’è riuscito», disse lui, dando la bottiglia del festeggiamento alla moglie, e il vecchio era lui, «da questa sera chiamatemi direttore generale...» perché quella sera, appunto, al culmine della sua carriera, l’amministratore delegato gli aveva detto che lo nominava direttore generale dell’azienda. Allora lo baciarono tutti, e nessuno gli domandò se fosse stato dal dottore, non se ne ricordarono. 73 · Una notte di luna Fu una notte di luna che lui scoprì di averle ucciso il padre. Era il quattordicesimo o il quindicesimo giorno del viaggio di nozze e stavano sulla terrazza dell’albergo, guardando, sotto, il quieto, incolore giardinetto cui la luna piena dava una lucida apparenza di irrealtà che di giorno certo non aveva, così geometrico, modesto come era, e continuavano con le parole a frugarsi, anzi a sfogliarsi, l’un l’altro, come grandi misteriosi libri che si vorrebbe subito aver letto tutti senza il lento percorrere riga per riga, pagina per pagina; e lei allora disse che la luna le suscitava ricordi penosi e lui le domandò quali ricordi, così lei raccontò di quella sera, molto tempo prima di sposarlo, quando in una notte di luna come quella era andata a riconoscere il padre, investito da un’auto sullo stradone che conduceva al loro piccolo paese, e ricordava il lungo viale che conduceva all’ospedale, tutto macchie di luna, percorso due volte all’andata e al ritorno, e tutte quelle macchie di luna, tutta quella luce di luna legata indissolubilmente al ricordo del corpo del padre martoriato, al vano rancore verso quello che lo aveva investito ed era fuggito, rimasto per sempre sconosciuto. «Allora rientriamo...» lui le disse. Gli bruciavano le mani e tutto il collo, le tempie, perché dal nome del paese di lei – che sempre gli aveva dato un oscuro senso di rimorso – dal giorno e l’ora, di notte, con tanta luna, in cui era accaduto l’incidente, o assassinio anche se non premeditato, sapeva con totale certezza di essere lui il colpevole. «Oh, no, stiamo ancora qui», lei disse, «con te è così bello...» appoggiando tenera e bionda il capo sulla sua spalla. 74 · In ricordo di Ulisse Andarono al funerale del canarino Ulisse, cioè, non è che andarono semplicemente, è che Furio aveva detto che l’indomani avrebbe fatto i funerali al suo canarino e, con gli occhi cerchiati di rosso e con quel gonfio in basso alla giacca, a destra, della calibro nove, tutti dissero seriamente che non sarebbero mancati, e non mancarono, l’indomani, era anche un giorno di pioggia, cinque macchine s’avviarono verso la campagna, per ultima quella coi tre pistoleros, penultima la sport della Federica Non Ce La Faccio Mica, con le altre due donne della società, terzultima la Mercedes del vicecapo che per partecipare a quel funerale rischiava di farsi prendere dalla polizia e tornare all’ergastolo da cui era evaso per omicidio plurimo aggravato, quartultima la milleotto dei due amministratori, e infine, prima, la Impala, con lui chiuso nel suo disperato lutto, e sul sedile la scatola dorata con dentro la spoglia di Ulisse e la targhetta di oro puro con inciso il nome del canarino perduto per sempre, Ulisse. E, quando arrivarono alla villa sul lago, sempre sotto la pioggia, le cinque macchine si allinearono sul viale del giardino, Furio scese con la sua scatola dorata, si accucciò, scavò con la mano in una aiuola, vicino a una pianta di rose, una fonda buca nel terreno fangoso, vi depose la scatola con dentro l’unico essere col quale al mondo fosse stato buono, dimentico delle persone che aveva ucciso o fatto uccidere, delle empietà commesse, da anni gentile e umano, generoso, comprensivo solo col canarino, pronto a dargli ogni cibo, felice solo di poterlo guardare nella sua gabbia, e disumano con tutto il resto del mondo. Poi si alzò e disse: «Se qualcuno ha voglia di ridere, ride per l’ultima volta...». Tutti pensarono alla sua calibro nove, e lui si asciugò finalmente gli occhi umidi. 75 · Le donne non sanno aspettare Lei entrò in camera e vide che lui stava preparando il valigione grosso. «Perché ti porti via tutta la roba? Stai via solo dieci giorni.» Lo vide mettere nella valigia perfino il quadretto con la fotografia di lui vicino all’autotreno. «Perché me ne vado», disse lui. «Ma sei matto?» disse lei fingendo di voler ridere. «E perché?...» Lui finì di riempire la valigia, la chiuse, la portò in anticamera. Dal taschino della tuta levò ventimila lire e le mise su una sedia. «Questo per pagare i conti della spesa che hai indietro.» Andò in cucina, cercò nel frigo una bottiglietta di birra, fece saltare il tappo col grosso, ferreo pollice e la bevve piano, senza bicchiere. «Tu non mi lasci così, sai?» gridò lei. «Non fare scene», le disse, «tanto è inutile. Non è mica colpa tua, io a te non dico niente. Sono a casa due o tre volte al mese, perché giro sempre col camion, e ti rimane troppo tempo. Resisti un anno, un anno e mezzo, e poi te ne trovi un altro per quando io sono in viaggio. Non sei mica la prima... È la terza casa che metto in piedi con una ragazza. Al principio si lamentano che le lascio sempre sole, ogni volta che arrivo sono felici, mi saltano al collo, poi passa qualche mese, un anno, o poco più e vedo che cominciano a diventare calme, non strillano perché sono sempre via, non si mettono a piangere quando parto, né smaniano troppo quando ritorno... Sono tutti segni che ne hanno trovato un altro. Io parto, e lui arriva. Io arrivo, e lui parte. E non dire di no, perché ho trovato in casa anche un pacchetto di sigarette col filtro e io non le fumo col filtro. Ciao, statti bene, non è mica colpa tua, sarà il mio mestiere. Saluti...» E se ne andò, senza ira, rassegnato: le donne non sanno aspettare. 76 · Pesca alle anguille Roma, e una brutta sera di maggio. Non pioveva ma l’aria era tanto umida che era come se piovesse. Achille Mursoli camminava per il Lungo Tevere Marzio, cercando di stare lontano dalla luce dei lampioni, nelle zone meno illuminate, perché non era un gran bene per lui essere visto da troppa gente. C’è sempre qualcuno che legge i giornali e la sua foto era stata pubblicata dai più importanti quotidiani italiani e francesi, oltre che su molte riviste illustrate. Il leggero, anche se ingegnoso travestimento da clergyman poteva al momento ingannare, ma non avrebbe resistito a un osservatore attento, diciamo un poliziotto. Il falso clergyman aveva in mano una piccola e modesta valigia, proprio da prete, ma per quanto modesta e piccola, la valigia conteneva oltre centomila franchi francesi. Achille Mursoli, infatti, romano di Roma, veniva un poco da lontano, da Lione, più esattamente dal Crédit Lyonnais, dove insieme con tre amici còrsi, aveva compiuto una fulminea rapina, una vera e propria azione di commando, che aveva fruttato quasi mezzo milione di franchi. Dopo essersi spartito il bottino, tutti e quattro con gli opportuni travestimenti già preparati, si erano dispersi, è il caso di dirlo, ai quattro venti. Lui, Achille, era tornato a Roma, dove aveva amicizie capaci di nasconderlo e proteggerlo. Tutto sarebbe andato bene, se uno dei tre còrsi non fosse stato preso dalla polizia e interrogato sul come avesse tutti quei franchi e avesse sparato addosso a due flic che gli – diciamo «le» – avevano chiesto i documenti, e soprattutto perché si fosse travestito da bella ragazza bruna, lui che era un baldo rappresentante della virilità còrsa. L’interrogatorio era stato fatto in modo così suasivo, anche se non delicato, che il còrso travestito aveva confessato tutto in meno di un’ora, facendo tutti i nomi dei suoi compagni. Quindi la foto dell’italien Achille Mursoli, e quelle dei suoi tre compagni, erano state pubblicate sui giornali italiani e francesi. In quel momento Achille aveva già attraversato il confine, era entrato in Italia, e si trovava su un treno diretto a Roma, esattamente vicino a Firenze. Che poteva fare? Nel suo abito da clergyman, con la sua valigia modesta e preziosa, con una piccola ma micidiale rivoltellina francese nella tasca della giacca al posto del libro delle preghiere, Achille non poté che continuare il viaggio e a leggere di lui, che alcuni giornalisti fantasiosi definivano «la mente della più audace rapina dell’anno». Ma, essendo stato scoperto, con nome, cognome e foto, Roma rappresentava per lui, invece di un rifugio, una trappola mortale. Non fidandosi neppure di prendere un taxi, Padre Rapinatore Achille aveva attraversato a piedi mezza Roma, andando in quella zona monumentale che dal Quirinale porta al Tevere, e che non era mai stata la sua zona, dove sperava di non incontrare conoscenze che anche sotto il travestimento talare potessero individuarlo. E adesso, camminando per il Lungo Tevere, vide, dall’altro lato del viale, l’insegna di una piccola trattoria. Erano le dieci passate e aveva fame. Sognava le fettuccine. Si fece coraggio ed entrò. La trattoria, per l’abitudine dei romani di mangiare tardi, era ancora piena, ma un volonteroso cameriere gli trovò un posticino su qualche cosa che rammentava più una mensoletta che un tavolino, tanto era piccolo, in un angolo buio, vicino alla botola che conduceva in cantina e nella quale il pio cliente, se distratto, poteva rotolare con tutta la sedia. Ma questo per lui era l’angolo migliore, decentrato, oscuro, fuori dalla curiosità dell’affollato locale. C’era poi un altro inestimabile vantaggio: proprio davanti a lui si apriva la cabina del telefono. Le trattorie romane non hanno quasi mai la cabina telefonica: quella l’aveva. Prima attese che fossero pronte le fettuccine, poi se le mangiò con una perizia e una rapidità che un clergyman di solito non ha, poi si fece portare due gettoni dal cameriere e, in attesa del pollo col peperoncino, entrò nella cabina, e fece il numero di Evelina: era una gentile signora pericolosamente vicino ai cinquanta, che abitava ai Parioli e alla quale, come a Messalina, piaceva mischiarsi alla teppaglia. Aveva anche passione per il whisky, il vino, e possedeva un grado nobiliare che lui però non ricordava bene quale fosse: baronessa, contessa, marchesa, chi sa. «Pronto?» Rispose proprio lei. «Sono Achille.» «Avevo riconosciuto il vocino.» Lei era spiritosa e a quell’ora l’alcool le dava ancora più brio. «Ho letto sui giornali qualche cosa di te», mormorò con tono senza importanza. «Sei disposta a nascondermi?» «E perché non dovrei nascondere un bel birichino come te?» La voce di lei era già languida di ancestrali istinti e, ovviamente, di liquori. «Puoi venire con la tua macchina, a prendermi fra un’oretta?» «Sicuro, bambino mio, dove devo venire?» «Vieni in Lungo Tevere Marzio, fai due passaggi tra i ponti, ti fermerò io, a un certo momento. Che macchina hai adesso?» «Una 124 blu scurona come i tuoi occhi, tesoro.» «Ecco, ti aspetto. Non più tardi delle undici e un quarto. Grazie, amore.» «Non dirmi amore, se no sto male. Vengo alle undici e un quarto.» In casa di Evelina sarebbe stato al sicuro come un pupo tra le braccia di mamma. Chi sarebbe andato a cercarlo nel solitario appartamento ai Parioli in casa di una signora tanto per bene, perfino nobile, vedova di un noto uomo politico, apprezzato da tutti per la sua violenza polemica, ma molto meno dalla moglie che non trovava in lui alcuna violenza? Inoltre Evelina aveva anche la possibilità di nasconderlo in altri posti, di farlo fuggire all’estero. La sua passione per lui aveva un’intensità e una tenerezza sulle quali egli aveva giustamente calcolato. Certo, Achille Mursoli aveva anche degli amici uomini, ma sapeva troppo bene che nel suo mondo un uomo con una valigetta contenente più di centomila franchi, non ha assolutamente amici. Alle undici e cinque, uscì. Camminò per il Lungo Tevere rinfrescandosi un poco dopo il lauto pasto, ma tenendo d’occhio la gente e lo scarso passaggio delle auto. Alla fine del secondo passaggio, vide avanzare lentamente una 124 blu scuro che in quel semibuio sembrava nera. Allora Achille Mursoli avanzò deciso verso l’auto, e agitò un momento la mano per farsi riconoscere. All’alba del giorno dopo, Roma ebbe due cadaveri in più. Uno lo trovarono ai Parioli, era quello di una nota signora sui cinquant’anni, ancora piacente, la baronessa Evelina Clivoli, alla quale avevano sfondato la nuca, dopo averla ferita nelle parti più delicate del corpo con un’arma da taglio: evidentemente una tortura. Il secondo cadavere, ritrovato sul Lungo Tevere Marzio, per qualche momento lasciò perplessa la squadra anticrimine. Chi poteva aver strangolato un clergyman dagli occhi così profondi d’azzurro e nordici? Ma poi trovarono in tasca al religioso, invece del breviario, una mini Colt francese e un passaporto rilasciato dalle autorità italiane a un certo Padre Coletti Antoni che, ad un accurato esame della scientifica, risultò falso. Falso quindi anche il reverendo, che era stato strangolato malamente e finito con un violento colpo in testa. Nello stesso giorno la squadra anticrimine identificò questo secondo cadavere: si trattava di Achille Mursoli, uno dei quattro banditi che avevano fatto il colpo al Crédit Lyonnais, quello che la stampa francese chiamava le terrible italien. Per essere terribile, aveva trovato a Roma qualcuno di più terribile. Per il momento, per la squadra anticrimine della capitale, il cadavere più importante fu quello di Achille Mursoli. Si sapeva dalla confessione fatta dal primo rapinatore arrestato in Francia che i quattro compari si erano spartiti il bottino, oltre centomila franchi per ciascuno, poi si erano divisi. Dove erano andati a finire i centomila franchi di Achille Mursoli? Dove li aveva nascosti, a chi li aveva affidati, o chi glieli aveva presi? Era molto probabile che Padre Achille fosse stato ucciso per quei franchi, ma era anche probabile che, prevedendo un rischio simile, avesse già nascosto i soldi, ma dove, da chi? I nidi della teppaglia romana furono accuratamente battuti, gli informatori della polizia vennero minacciati di ergastolo se non trovavano informazioni buone; tutte le banche e gli uffici di cambio vennero sollecitati alla massima attenzione per chiunque cambiasse franchi francesi, anche in piccole quantità. A parte questo, un alto e robusto poliziotto fiorentino venne incaricato di interessarsi all’altro cadavere, quello della baronessa Evelina Clivoli. Questo poliziotto si chiamava Lungherna, ma i colleghi lo avevano soprannominato affettuosamente Lungarno. Il fiorentino appena ricevuto l’incarico di indagare sulla morte della baronessa, aiutato da un collega e da quelli della scientifica, fece una riflessione non geniale, non leonardesca o galileiana, ma molto di buon senso: sia la baronessa sia il rapinatore come stabilivano le perizie mediche erano stati uccisi la stessa notte, quasi alla stessa ora, nello stesso tempo e nello stesso modo, cioè finiti, come colpo di grazia, con lo sfondamento del cranio alla nuca per mezzo di un pesante corpo contundente. Non poteva essere che vi fosse qualche correlazione tra la baronessa e il rapinatore? domandò ingenuamente il lungo poliziotto fiorentino al capo della squadra anticrimine. Questi lo guardò con odio. Vi erano già tante ipotesi da fare intorno all’assassinio di Achille Mursoli, e quello gliene inventava un’altra. Ma portò pazienza. Disse al volenteroso toscano: «Se riesci a trovare qualche correlazione tra quella morta dei Parioli e questo morto di Lungo Tevere Marzio, me lo scrivi per cartolina, tanto c’è lo sciopero delle poste eterno. Porta un saluto a Firenze...». Ma dette una paterna manata sulla spalla di Lungarno. E Lungarno si mise a cercare il legame tra i due cadaveri. La baronessa Clivoli, per il suo elegante appartamento ai Parioli, aveva solo una cameriera a ore, per il resto usava, come tanti altri, le solite imprese di pulizia. Lungarno e il suo collega Pietro bloccarono questa cameriera che si chiamava Teresa e doveva avere oltre sessant’anni, la convocarono in questura e la interrogarono. «Ci dica le abitudini e le amicizie della baronessa», disse Lungarno. Prevedeva che la risposta sarebbe stata: «Ah, io non so niente, non ho visto niente, cosa volete che sappia io». Invece la vecchia donna rispose nettamente e distintamente, alla romana: «E che abitudini e amicizie volete che fossero? Quelle di una...» e disse il termine, dell’accrescitivo. Lungarno incassò impassibile la dichiarazione. «Come fa a saperlo?» La vecchia Teresa rispose subito: «Nun c’è mica bisogno d’esse er Nero Wolfe della televisione pe’ sapello. Ohé, giovanotti, io andavo a lavorare in casa de questa che dicheno baronessa, alle otto del mattino, e sa che la trovavo quasi sempre sur divano in sala, in mezzo a un sacco di bottiglie, addosso a uno, e ne cambiava uno alla settimana almeno, e appena arrivavo me diceva: “Teresa, preparace gli spaghetti”, e io je dicevo: “Sì, signora”, ma nun je li preparavo, perché erano tutti e due così sbronzi morti che dopo un minuto nun se ne ricordavano più... E avreste dovuto véde, giovanotti, che monnezza de ragazzi che erano... Io ho un fijo che è ’na monnezza come loro e me ne intendo». Scosse il capo, gli occhi senza lacrime. «Me dispiace dillo, perché è sempre mi fijo, ma è in galera da tre anni, e c’è stato già due volte, e appena esce combina qualche altra cosa e ce torna, così figurateve se non distinguevo quelle zozzerie de delinquenti che s’approfittavano della baronessa. Erano tutti ladri, sfruttatori, scippatori e magari rapinatori, quarcuno assassino, se voi della polizia andaste in certe case signorili invece di giracchià così a caso, combinereste quarche cosa de mejo.» Lungarno e Pietro incassarono il rimprovero, poi Lungarno disse: «Non sa dirci altro di questi giovani? Non so, qualche nome, qualche connotato?». «Eh, cari voi, e allora dovrei èsse un’enciclopedia, erano tanti, non pe’ parlà male de quella poveretta perché lei me pagava bene, nessuno avrebbe dato a una vecchia come me lo stipendio che me dava, ma sapeste anche l’insurti che me diceva perch’ era quasi sempre imbriaca...» «Ma non sa dire niente neppure dell’ultimo giovanotto, quello che stava con la baronessa negli ultimi giorni, prima che venisse uccisa?» «Be’, io nun è che stavo a guardà come quadri quelle fogne de roba. Cercavo de nun guardà e de nun sentì, e quando lui se ne annava, e lei se buttava sul letto accoppata dalla bevuta, allora respiravo aria più pulita, ogni tanto sentivo lei che mugolava il nome di lui, uno lo chiamava Ettore, me ricordo, un altro Giovannino, l’ultimo lo abbracciava e lo chiamava Ciriolo mio, Ciriolo mio.» «Ma cos’è, un nome o un soprannome?» «Ma, scusate, volete che sia un nome? Ma che poliziotto séte?» Lungarno incassò anche questo colpo. «E i connotati?» disse. «Sa dire qualche cosa?» «N’armadio, quei tipi de bestia che se vede piacciono a le baronesse.» «Bruno?» «Altro che bruno, era tutto inchiostro, anche la pelle.» Glielo descrisse, e molto bene. «Giovanotti, arrestatela tutta la monnezza, è uno di loro che ha ucciso la baronessa.» Si trattava adesso di trovare, a Roma, un giovanotto bruno, largo come un armadio, soprannominato Ciriolo. «Ma che vuol dire Ciriolo?» chiese Lungarno al suo collega Pietro che era romano. «Vuol dire piccola anguilla, uno che sguscia dalle mani e che non si riesce mai a prendere. Devono avergli dato questo soprannome, perché chi sa le volte che è scappato alla polizia, cioè a noi.» Con buona volontà fiorentina, e con testardaggine romana i due poliziotti si misero alla ricerca di questo Ciriolo o anguilletta. C’era da ridere a pensare di trovarlo. Infatti non lo trovarono. Trovarono solo un ragazzino di quindici anni, già guasto come il pomo del paradiso terrestre se avessero voluto conservarne il torsolo fino ad oggi, che avendo la coda di paglia verde per certi suoi peccatucci, confessò di conoscere un certo Ciriolo, appunto bruno e largo come un armadio, che aveva un’amica alla quale proprio pochi giorni prima aveva quasi sfasciato la testa con un colpo alla nuca, e questa donna sapeva un po’ di più di Ciriolo. «Come si chiama questa ragazza?» disse Lungarno. «Be’, ragazza per modo di dire, erano otto anni che batteva per qualcuno, poi è arrivato Ciriolo.» Disse ancora: «Si chiama Luce». «E a che ospedale è?» «Ho sentito dire al Fatebenefratelli, ma io non ho visto niente, non so niente, sono chiacchiere che ho sentito dire...» La ragazza si chiamava Lucia, ma il suo nome d’arte era Luce. Il colpo che aveva ricevuto alla nuca, teoricamente avrebbe dovuto accopparla, ma in pratica, benché distesa su un letto dell’ospedale Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina, con l’aria del Tevere che entrava dalla finestra aperta, era abbastanza viva, come una gatta caduta dal quinto piano, ma ancora pronta a graffiare. Con l’ago della fleboclisi infilato nel braccio, la testa fasciata come un pacco natalizio, mancavano solo i rametti di pino, una sigaretta in mano, Lucia detta Luce, di professione mondana, raccontò la sua storia ai due poliziotti, il fiorentino Lungarno e il romano Pietro. Non le era mai piaciuto parlare coi poliziotti, ma quella volta grandemente sì, grandemente le piaceva. Fu anche abbastanza breve. «Sì, è stato Ciriolo. Io lavoravo per lui, lui mi prendeva a calci, poi mi prendeva i soldi, e poi andava con la baronessa. Quella sera è dalla baronessa, e sente che lei riceve la telefonata da uno. Siccome sta sempre attento che qualcuno non gli porti via la baronessa, domanda alla poverina: “Chi ti telefona, piccola?”. E lei, ubriaca morta, dice che le ha telefonato Achille, quello della rapina a Lione, e che lei adesso andrà a prenderlo per tenerlo nascosto. Ciriolo non è un genio, ma capisce subito che Achille è arrivato a Roma per rifugiarsi dalla baronessa, col suo gruzzolo prelevato al Crédit Lyonnais. “E dove vai a prenderlo, piccola?” domanda alla baronessa, allora lei, benché ubriaca, capisce la verità e non glielo vuol dire. Così Ciriolo comincia a pizzicarla un po’ qua e un po’ là col coltello finché lei parla: deve andare a prendere Achille con la sua 124 al Lungo Tevere Marzio. Allora lui l’ammazza, con lo stesso colpo che ha dato a me, dietro la testa, è una sua specialità, una specie di karate. Poi con la 124 corre al Lungo Tevere Marzio, trova Achille, lo blocca col solito colpo, dopo averlo mezzo strangolato perché non gridi, gli piglia la valigetta coi soldi e dove va a rifugiarsi? da questa cretina qui, da me. Quando apre la valigia è ubriaco di soldi. Facciamo a metà, te e io, dice, tienimi nascosto e ti do la metà, lo sai quanti milioni di lire sono? Io lo tengo nascosto, in fondo non gli voglio male, anche se mi prende a calci, ma, passati i primi giorni di paura, quando vede che la polizia non ha nessuna traccia su di lui, si pente di avermi detto tutta quella storia, di dovermi dare la metà, di essere nelle mie mani e che io posso denunziarlo sempre, e allora una sera, col suo colpo speciale mi spacca la testa, io però do un urlo che lui si spaventa e fugge via. Così adesso sono viva e dico tutto di Ciriolo, conosco anche il nome dei nonni paterni e materni, e di tutti i suoi amici, maschi e femmine e così così. Lo troverete in mezz’ora, anche se è andato all’inferno, e, appena lo vedete, pigliatelo a calci in bocca. Grazie del favore...» Anche Lungarno la ringraziò. 77 · Il nome mai L’ammanco era quasi di quattro milioni, l’amministratore stava appunto facendo vedere i conti al principale, da una serie di quadernini. Il vecchio cassiere era seduto davanti alla scrivania e si teneva le mani che gli tremavano. «Marchi», gli disse il principale, «non cerchi di fare il furbo, non può aver speso quattro milioni in poco più di un mese.» Ma il vecchio Marchi, come prima, invece di parlare si mise a tremare. «Non può parlare», disse l’amministratore, «io l’ho interrogato ieri sera; dice che ha speso tutto. Dice che è stato per una donna.» L’amministratore torse la bocca, anche il principale torse la bocca. Così si spiegava tutto: un vecchio rimbecillito, che buttava via tutto il suo passato di lavoro onesto, per la sgualdrinella. «Benissimo», disse il principale, «allora voglio sapere il nome di questa donna e ci penso io a riprenderle le pellicce, i gioielli e i soldi che lui le ha dato.» Ma vide che il vecchio Marchi scuoteva il capo, subito, con decisione. «Dice che non lo dirà mai», spiegò l’amministratore e torse ancora la bocca. «Ho passato tutta la sera a cercare di convincerlo perché dica chi è questa donna, ma non vuole, assolutamente non vuole.» E guardò il vecchio Marchi, e il vecchio Marchi scuoteva ancora il capo: non lo avrebbe detto mai, era una donna cattiva, l’ultima delle donne, lo aveva rovinato e abbindolato, ma lui era un gentiluomo, non avrebbe mai fatto il suo nome. «Allora fa’ chiamare la polizia dall’avvocato», disse il principale. E vide il vecchio Marchi che, tremando, col capo accennava sì, sì, lo arrestassero pure, era giusto, ma il nome di lei nessuno l’avrebbe mai saputo. 78 · Non sembrava proprio Il ragazzo aspettava da molto che qualche macchina si fermasse, ma non notavano neppure i suoi segni, le macchine sfrecciavano infocate dal sole. Finalmente, una macchina si fermò. C’era una donna, dentro, ed era giovane. «Salga», disse. Il ragazzo salì. Nella macchina fiutò un profumo acuto. Veniva dalla donna. Era molto abbronzata, in prendisole. «Grazie...» disse lui. Lei scosse la testa, continuò a guidare, guardava davanti. «Vado un poco lontano», disse lui, «ma mi lasci giù dove vuole.» Lei assentì. Il ragazzo non riusciva a stare zitto. «È in vacanza da queste parti?...» disse. Lei era molto bella. «No», disse, e basta. Lui se ne intendeva, quella macchina valeva almeno due milioni. «Sposata?...» disse. Lei sospirò, sprezzante: «E che cosa gliene importa?...». Lui era in maglietta bianca e calzoni corti, con il ginocchio nudo sfiorò il ginocchio nudo di lei. La donna continuò a guidare. Solo dopo un poco parlò, e il disprezzo pareva aumentato: «Scosti il ginocchio lei, per favore, io non posso, perché debbo tenere il piede sull’acceleratore». Lui scostò il ginocchio, ma non subito. «Scusi, sa...» disse languido, «ma noi uomini tentiamo sempre, specialmente d’estate...» Lei era tornata a chiudersi nel silenzio. Andava forte, si occupava esclusivamente della strada che si dissolveva nell’afa. Lui aspettò ancora un minuto o due, poi le baciò la spalla nuda. L’estate gli dava alla testa. Quando la macchina si fermò bruscamente, lui rischiò di sbattere la fronte contro il parabrezza. Lei si era girata verso di lui, si tolse gli occhiali neri, per guardarlo. Aveva gli occhi chiari, peggio che sprezzanti. «Ragazzino», disse, «non li hai, i soldi. A Milano costo trentamila lire. Sta’ quieto, altrimenti scendi. Sono chiara?...» Lui si scostò, deluso. Non l’avrebbe mai immaginato: non sembrava proprio una puttana, sembrava una vera signora. «Allora, ti decidi?» insisté lei. Si sporse per aprire lo sportello dalla parte di lui. Lui non capì bene perché lo facesse, cercò di stringerla, lei si ribellò. Lottarono, affannati. Come il languore si era tramutato in delusione, la delusione si tramutò in lui in irritazione. Lei gli resisteva. Gli arrivò con una mano alla guancia, e lui sentì quelle unghie affondargli nella carne. Allora la colpì, l’irritazione si tramutò in furore. La colpì, sinché lei non smise di resistere. Giaceva di sbieco sul sedile, scomposta, indecente, impudica, la bocca ottusamente spalancata. Per quello che riguardava lui, poteva anche essere morta. Scese dalla macchina, si avviò a piedi. Si tolse il fazzoletto tutto appallottolato da una tasca, se lo passò sulla guancia. Allontanandosi dalla macchina, contemplava le macchie di sangue. «Non sembrava proprio...» si ripeteva, a rendersi conto di quello che probabilmente aveva fatto cominciò solo più tardi. 79 · Il caldo Con un ferretto che gli aveva dato un amico lui lavorò intorno alla serratura finché la porticina della cabina grande, quella che serviva di deposito per le sdraio, gli ombrelloni e dove c’era pure una brandina su cui riposava il bagnino nelle ore della canicola, non si aprì, e lei lo seguì, sedendo poi con lui sulla brandina, nel buio, i piedi nudi punti dalla sabbia, nell’odore della notte di luglio, odore di legno caldo che non riusciva a raffreddarsi e lo sciacquio del mare vicino, caldo anch’esso, tanto. Lei sapeva di fare una cosa brutta, sapeva di stare per fare quel che non doveva, ma aveva tanto caldo, ed erano calde le mani di lui sulle sue spalle e caldo, molto caldo il silenzio, così come erano calde le labbra di lui sulle sue, quando da fuori udirono quelle voci, fuori della cabina, una maschia, l’altra femmina, calde anch’esse. «Ma è aperta...» disse la voce femmina, incerta, di fuori. Era aperta la porta della cabina. «Ho capito», disse la voce maschia, «ce ne sono altri due arrivati prima. Vieni pupa, aspettiamo che escano, andiamo a fare un poco d’altalena...» «...Non è niente, sta’ tranquilla», disse lui. Lei dopo un poco sentì nel caldo silenzio notturno della spiaggia lo stridere della carrucola dell’altalena, sulla quale giocavano i due, fuori, in attesa: voleva fuggire, subito, tutto il suo pudore d’amore ferito, ma faceva tanto, tanto caldo, e non ci riuscì. 80 · Una vera amicizia Dopo aver fatto l’amore, Irma si mise a piangere. «No, non dovevo...» ripeteva. «È un peccato... Sono... sono imperdonabile...» Sussultava tra i ghirigori dei lenzuoli. «Sei imperdonabile per la tua stupidità, mica per altro», disse, brusca, Dora, cercò sul comodino fra le mille cianfrusaglie accumulate il pacchetto delle sigarette, e se ne accese una. «Com’è possibile che quel che hai fatto fino a ieri ora sia diventato un peccato?...» Irma tirò su con il naso, prima di rispondere: «Perché ora c’è Marco... Credimi, è finita... Non insistere più. Questa è l’ultima volta...». Dora sbuffò fuori il fumo. «Perché?» disse. «Sono stata io a insistere, forse? Ho telefonato io a te o hai telefonato tu a me?... Ho l’impressione che tu abbia la memoria corta, troppo corta... Però, non è successo più tardi di stamani. Non più tardi di stamani sei stata tu a telefonarmi che volevi vedermi almeno un’ultima volta...» Irma si puntellò per alzarsi, si girò, aveva tutti i capelli sulla faccia. «Tu non mi vuoi bene», disse. «Non mi hai mai voluto bene. E io che m’illudevo che la nostra fosse una vera amicizia...» Dall’intrico dei capelli vennero fuori gli occhi. Le lacrime si erano già asciugate. «Anch’io m’illudevo che la nostra fosse una vera amicizia», disse Dora. «Quando ci siamo conosciute, credo che tu con la tua memoria corta non riesca a ricordare quando e come ci siamo conosciute... Quel che eri tu al tempo in cui ti ho incontrata...» «Hai l’intenzione di rinfacciarmi il passato?» disse Irma, si mise a sedere in mezzo al letto, indifferente alla nudità. Involontariamente Dora le guardò il seno, e si addolcì. Era inutile che fosse una donna forte, se una sgualdrinella come Irma bastava a intenerirla, ad ammollirla, a sconfiggerla. «Non ho la minima intenzione...» disse, di nuovo tentata. «La minima intenzione... il passato per me è bello, bellissimo, non ho niente da rinfacciarti, ma solo da ringraziarti... È un gran dolore che sia finita. Ma hai diritto a vivere la tua vita...» «Oh, Dora...» si sdilinquì Irma. «Sei sempre troppo buona con me... Scusami per le stupidaggini che ho detto prima, io sono davvero stupida, tu hai ragione... Senti, piuttosto, a proposito di quel prestito... Marco, sai, è in difficoltà, e...» Stava seduta sul bordo del letto, ora, nuda e distratta. Giocherellava con le forbicette prese dal comodino, provò a spuntarsi un’unghia della mano sinistra. Dora tossì per liberarsi la bocca dalla tentazione. «È per questo, allora, che sei venuta a letto con me oggi?» disse. «Per estorcermi degli altri soldi per il tuo... il tuo?...» Non trovava un insulto abbastanza efficace. Tese la mano con il mozzicone della sigaretta ancora accesa, lo premette in mezzo al seno di Irma. Irma urlò, e le ficcò le forbicette in un occhio. 81 · La figlia del giudice I due giovanotti erano piccoli, ma avevano un aspetto temibile e selvatico per le sopracciglia lunghe, quasi attaccate alla radice del naso, la massa lanosa e nera dei capelli in contrasto col pallore femminile del volto, e più di tutto lo erano, temibili e selvatici, per la loro intima somiglianza anche se i tratti del volto erano diversi, così che si capiva che erano fratelli, d’intuito, al solo vederli, per diversi che fossero, forse anche per quel loro camminare e muoversi insieme, nello stesso modo, come due macchine uscite dalla stessa serie. E come due macchine, o arieti, spalancarono, quasi la sfondassero, la porta dello squallido negozio o magazzino di tessuti, in quella squallida traversa di corso Buenos Aires, e uno si fermò, appena entrato, a sbarrare il passo verso l’uscita, mentre, come un ariete, il secondo raggiungeva l’altra uscita, nel cortile, e si fermò anche lui, bloccandola. «Dobbiamo parlarti», disse quello vicino alla porta d’entrata, con voce normale, senza imperio o minaccia, «manda via la tua baldracca.» Ma disse un’altra peggiore parola, nel suo dialetto, che era poi anche il dialetto del giovane dietro il banco, un lungo fragile tavolo travestito da banco, unico mobile del preteso negozio di tessuti oltre alle scaffalature, alte fino al soffitto, e rese più vuote che se fossero state completamente vuote da qualche pezza di stoffa sistemata qua e là come radi denti in una grande bocca vuota. E il giovane rimase fermo come era, al vederli e all’udirli, le mani poggiate sul fragile banco, gli occhi bassi che però vedevano ovunque, subito convinto che non poteva far nulla, anche se quelli non erano armati che della loro decisione e anzi, più, di quella loro espressione, disumanamente calma, che era peggiore di qualunque arma, e così si rivolse subito alla ragazza, in giacchino grigio, biondina, minuta, milanese per quegli occhi lucidi di ribellione all’aggressiva entrata dei due, alle loro calme, insultanti parole, ma lo sguardo di lui le disse di non ribellarsi. «Esci un momento, non aver paura», le disse. E subito l’ariete di guardia all’uscita sul cortile le aprì la porta, con minaccioso invito, e lei uscì incerta, senza volgersi indietro, sapendo che poteva soltanto ubbidire. «Abbassa un poco la saracinesca, non deve entrare nessuno», disse l’altro ariete vicino alla porta principale e il giovane uscì ubbidiente sulla strada, avrebbe potuto fuggire o chiedere aiuto ma non lo fece, perché l’ariete gli era vicino e lo seguiva mentre lui con la lunga asta di ferro agganciava la saracinesca e la tirava giù, a mezza altezza, in modo da poter rientrare nel negozio e i due subito gli andarono addosso, neppure tanto, solo quanto bastava per fargli sentire la loro presenza, più che fisica, nervosa, e uno cominciò a parlare, nel comune dialetto, dicendo cose che l’altro, l’aggredito, sapeva che quello avrebbe detto, perché erano vecchie, ancestrali parole che una volta o l’altra aveva sempre temuto di doversi sentire dire. «E tu non devi credere che, perché siamo qui a Milano, la parola non è la parola», gli diceva con tono sordo l’ariete, fissandolo anche se lui stava con gli occhi bassi, «e che, perché siamo lontani dal paese tu fai le cose che un uomo di parola non deve fare. Tu al paese sei venuto a casa nostra e hai detto: “Vostra sorella Rosa mi piace e la vorrei sposare, col vostro permesso”, e noi ti abbiamo detto che, se tu eri un uomo di parola, noi ti avremmo dato il permesso di sposarla. Poi noi abbiamo trovato lavoro a Milano e allora tu hai detto: “Vengo anch’io a Milano e sposo vostra sorella lassù”. L’hai detto o no?» Lui fece segno di sì, che l’aveva detto. E allora l’ariete disse ancora: «E qui a Milano noi abbiamo capito che tu vedevi nostra sorella anche la notte, e abbiamo portato pazienza perché eri un uomo di parola e l’avresti sposata presto, come continuavi a dire. È vero o no che continuavi a dire questo?». Ancora lui fece segno di sì, perché era proprio così. «Poi tu hai aperto il negozio e noi eravamo contenti perché ti facevi una posizione e nostra sorella sarebbe stata la moglie di un signore, e, quando lei si lamentava che tu non andavi più a trovarla, noi le dicevamo: “Non rompere l’anima, Rosina, lui ha da fare col negozio, quando l’avrà messo a posto vedrai che verrà a perdere tempo con te”. È vero, sì o no, che dicevamo così a nostra sorella?» disse l’ariete al fratello. «È vero», disse il fratello. Allora il primo ariete si volse ancora a lui: «Invece il tempo passava e abbiamo visto che tu avevi aperto il negozio, ma t’eri preso anche una baldracca e te la portavi in negozio di giorno e a casa di notte, e nostra sorella non venivi più a trovarla e poteva sembrare che tu non volessi più mantenere la parola, ma, prima di metterci di mezzo noi che siamo uomini e la storia diventa difficile, abbiamo detto a nostra sorella: “Rosa, noi vogliamo la pace e le cose giuste, anche a costo di un’umiliazione. Adesso tu devi umiliarti e andare da Vincenzo e domandargli perché non ti viene più a trovare e se il fatto che non ti viene più a trovare significa che lui pensa di mancare di parola”. E nostra sorella non voleva umiliarsi, perché una donna onesta non deve correre appresso all’uomo, ma noi vogliamo la pace e le abbiamo detto di ubbidire e lei è venuta da te e tu le hai risposto: “Rosina, è passato tanto tempo e io ti chiedo perdono, ma sono innamorato di un’altra donna e voglio sposarla”. E lei ti ha chiesto, come noi le avevamo ordinato di chiederti, se tu allora avresti mancato di parola, e tu le hai risposto: “Devi perdonarmi ma io non posso più sposarti”. È vero che tu hai detto queste cose a Rosina?». Lui abbassò il capo: sì, le aveva dette. «E allora siamo qui, noi, Vincenzo», disse l’ariete, «noi non volevamo che questa divenisse una questione di uomini, ma tu l’hai voluto, e siamo venuti qui per darti un consiglio: tu da questa sera vieni una volta al giorno a trovare nostra sorella, come facevi una volta. Intanto ti facciamo preparare noi le carte per il matrimonio, non ti devi disturbare tu, tu hai negozio e non devi perdere tempo a girare per queste sciocchezze, e fra venti giorni le carte saranno pronte e ti accompagniamo noi in chiesa insieme con Rosina, così diveniamo parenti e viviamo tutti in pace, tra uomini d’onore.» L’altro ariete parlò anche lui: «Ti consigliamo anche di mandar via subito la tua baldracca». Disse subito con voce bassissima, così sembrò invece che avesse urlato. Lui non batté neppure le palpebre a sentir chiamare baldracca, per la terza volta, la minuta, bionda ragazza che anche la notte prima aveva stretta con tanta furia e tenerezza: sarebbe stato pericoloso. «Noi ti diamo buoni consigli, Vincenzo», disse il primo ariete. E il secondo disse: «Perché siamo amici tuoi e vogliamo la pace». E il primo disse ancora educatamente: «Ti salutiamo, Vincenzo, e ti aspettiamo a casa di nostra sorella». E il secondo disse: «Puoi tirare su la saracinesca». Non dissero altro, solo lo guardarono un poco, prima di uscire, con disumana calma, e solo con lo sguardo lo spinsero e costrinsero ad alzare la saracinesca perché loro potessero uscire senza chinarsi. Perché a Milano è sempre tutto pieno, a tutte le ore, dal tram con cui aveva portato Rosa in centro, in piazza Cavour, alla piazza Cavour, a via Manzoni, e poi piazza della Scala, e voleva portarla al caffè all’angolo con via Verdi, vestiti così bene come erano, come dovevano essere due promessi sposi, doveva portarla in un buon locale, ma il caffè era pieno e subito quella gente del Nord li guardava, Rosa disse a disagio: «C’è troppa gente, Vincenzo». E allora andarono avanti in piazza del Duomo, sotto i portici, che erano pieni, lui le disse: «Vuoi vedere qualche vetrina? Rosa, guardiamo le vetrine». E lei gentile guardava, fingendo interesse, impacciata per tutta quella gente, e fecero tutti i portici di corso Vittorio Emanuele, e lui le disse: «Vuoi bere qualche cosa in un bar? Rosa, se hai sete, entriamo in un bar». Ma lei disse gentile che no, non aveva sete, e a San Babila, sotto i portici, c’era un caffè dove una donna cantava e si erano fermati ad ascoltare, in piedi, perché era tutto pieno, tutti i tavolini fuori erano pieni, perché era sempre pieno, dappertutto, a Milano, ma poi lui vide attraverso le vetrine che nell’interno c’era una saletta vuota e le disse: «Rosa, noi entriamo perché lì non c’è nessuno e ti piacerà». E infatti erano entrati, lei a capo alto, ma con gli occhi bassi e un cameriere con la giacca dalle code lunghe, sudato per il caldo, perché cominciava a far caldo e per questo le sale interne erano vuote, portò subito un secchiello d’argento pieno di ghiaccio, mentre fuori, sotto i portici, la donna cantava e la voce e la musica della piccola orchestra arrivavano dolci fino a lì, a loro, e lui le domandò gentile se voleva un gelato e lei disse di sì, e, quando lo ebbe lentamente mangiato tutto non aveva ancora detto una parola, sembrava che ascoltasse la musica, invece d’improvviso disse: «I miei fratelli sono venuti a dirti che mi devi sposare, se no peggio per te», e lo disse quasi senza tono, con poca voce, come non gliene importasse. Lui la guardò quieto, uno sguardo onesto, sincero. «No», mentì onestamente, sinceramente, sorridendo, «ne avete di fantasie voi donne in testa.» «Loro sono venuti da te, Vincenzo», lei disse, sempre in dialetto, e il più chiuso che poteva perché se qualcuno ascoltava non potesse capire. «È come se li vedessi, Vincenzo: sono venuti da te e ti hanno detto che devi sposarmi, ti hanno fatto paura.» «E adesso tu devi finirla, Rosa», lui disse smettendo di sorridere, in dialetto, reso ancora più scuro dalla voce maschile, «io non voglio sentire queste sciocchezze e non capisco come ti siano venute in mente. Voi donne pensate sempre qualche cosa di inutile.» E la menzogna gli era facile per molti motivi e soprattutto perché i fratelli di lei non avrebbero avuto piacere di sapere che lui aveva raccontato alla sorella di essere stato minacciato, queste sono cose che fra uomini non si fanno, non si mischiano le donne in questioni di uomini. Poi, anche glielo avesse detto, sarebbe stato tutto uguale, ugualmente lui avrebbe dovuto sposare Rosa, e tutti sarebbero stati umiliati: lui di aver subito una minaccia, lei di farsi sposare per forza, e i fratelli perché non trovavano altro modo che la forza per sistemare la sorella compromessa. E così mentiva, non solo per paura, ma perché in fondo sentiva che era giusto, per quanto controvoglia lo facesse, che dovesse sposare Rosa, perché fin dalla prima volta che l’aveva riportata a casa alle tre del mattino e uno dei fratelli era venuto ad aprire la porta dicendo: «Questo orario, Vincenzo, non mi piace», lui aveva saputo che avrebbe dovuto sposarla, lo volesse o no, anche se poi, dopo aver conosciuto la milanese, aveva pensato diversamente. «Vincenzo», lei disse, ora fissandolo un attimo, ora abbassando subito gli occhi, «per quattro mesi tu non sei più venuto a trovarmi, e al principio mi telefonavi, e poi neppure quello. E adesso, da una settimana, tu vieni tutti i giorni, o nel pomeriggio o la sera, e mi porti al cinema, e al caffè, e a farmi guardare le vetrine, e un mese fa tu hai detto, lo hai detto a me, che eri innamorato di un’altra e che non ti sentivi più di sposarmi, e adesso, invece, appena arrivano le carte, mi sposi. Questo vuol dire che i miei fratelli sono venuti da te anche se né tu né loro me lo direte mai, e io lo sento che è così.» Lui mentì ancora, onestamente e repulsivamente, perché era una questione che si doveva accomodare così, con le menzogne: «Un uomo conosce tante donne, prima del matrimonio, qualcuna pensa anche di sposarla, poi gli passa e sposa la fidanzata», tradendo anche quel poco di tenerezza e quel molto di sensualità che l’avevano legato alla milanese, pur di convincere la sua futura, non amata, non voluta sposa. E lei non disse più nulla, ma non perché gli credesse e lui l’avesse convinta. Non sarebbe stata la prima ragazza, del suo paese e di tutta la sua regione, che si sposava così, perché aveva un padre o dei fratelli decisi; accadeva a diverse e sarebbe stata un’altra in più, pensava guardando la televisione seduta vicino al fratello maggiore, infelice anche se ricca, almeno così si sentiva, in quelle tre camerette, dove tutto era stato preso a rate, sia pure, ma spesso pagavano, anche se con fatica, perché i fratelli lavoravano tutti e due e guadagnavano bene. E non era questo che le pesasse, o l’umiliasse, di essere sposata all’ombra dei coltelli, che i fratelli tenevano nascosti non sapeva bene dove – ma c’erano – né che Vincenzo non l’amasse più, perché di questo aveva già patito fin da quando se ne era accorta, dai suoi primi stanchi abbracci e le sembrava di doverne morire e invece non era morta e aveva continuato a vivere, sapendo di dover vivere anche senza l’amore di Vincenzo, come una madre sa di dover vivere anche quando il suo bambino è morto. Tutte queste cose le erano tollerabili, ma un’altra no, era assolutamente intollerabile. E attese che il programma che piaceva a suo fratello finisse, poi spense la televisione e portò per lui il bicchiere di latte che lui beveva sempre prima di andare a letto e porgendoglielo gli disse, calma: «E adesso che hai fatto questa bravata, insieme con tuo fratello, sarai contento». Lui tenne il bicchiere di latte in mano, e aveva capito, e ne bevette un sorso, poi domandò, calmo anche lui, come non capisse: «Che bravata sarebbe?». «Tu lo sai», lei disse subito, e glielo disse con gli occhi, che sapeva, e che lui doveva convincersi che lei sapeva. «Allora Vincenzo ti ha parlato», disse lui, minaccioso. «Vincenzo non mi ha detto nulla. Io gliel’ho chiesto e lui ha detto di no, ha detto che nessuno lo ha minacciato, ma viene qui tutti i giorni, perché voi lo avete obbligato, e mi sposerà perché lo obbligate.» «Ti deve sposare», lui disse. Stava per andarsene a letto: lui aveva finito; ma lei no, non aveva finito, e gli disse ciò che le era intollerabile: «Mi deve sposare, ma non perché lo avete costretto. Deve fare il suo dovere, ma se vuole farlo, non perché ha paura di voi». La voce della sorella sembrava sempre la stessa, quasi come quando parlava di quello che doveva preparare da mangiare, ma lui era il maggiore e la conosceva, gli sembrava la voce del padre, il giudice, perché loro non erano cafoni, anche se avevano dovuto venire su al Nord a lavorare, abbandonando la miseria di laggiù, ma un tempo avevano avuto un padre signore che sedeva in centro, al banco del tribunale, signore anche se la toga nera nascondeva i calzoni lisi dietro e la giacca ai gomiti e la camicia ridotta una ragnatela di rammendi, col solo collo staccabile nuovo e trionfante, e tutto il resto miserabile; gli sembrava la voce scura del padre, mite e inflessibile, quando diceva: «Questo non è giusto», a loro, i maschi violenti, e mai aveva alzato una mano su di loro, ma li faceva tacere e abbassare lo sguardo, dicendo, mite e inflessibile, parole che allora non comprendevano e che avevano compreso solo quando era morto: «O voi sapete distinguere le cose giuste dalle ingiuste, o voi non siete uomini!». Ma nonostante il ricordo del padre, improvviso e accecante per la voce di lei che glielo aveva fatto sorgere nella memoria, nonostante che il padre fosse ancora lì, tra di loro, come vivo, qualche cosa di più forte gli fece fare un gesto di sprezzo. «Questi discorsi non mi piacciono. Va’ a dormire.» Lei sapeva che lui avrebbe risposto così e allora, anche lei mite e inflessibile, tornò a sedere e, quasi voltandogli le spalle, quasi non parlasse a lui, disse: «Ho scritto a Vincenzo. Ho mandato Maria nel suo negozio con una mia lettera». Lui si fermò, guardandole le spalle, notando la sua rigidezza. «Avanti», disse. «Gli ho scritto che ho saputo che voi siete andati a spaventarlo», lei disse senza volgersi, «e che questo non è giusto. Poi gli ho scritto che lui sapeva quale era il suo dovere e che lui era libero di farlo o no. Doveva farlo liberamente, allora voleva dire che era un uomo giusto.» Continuò a stare con le spalle voltate al fratello, rigide, come stava il piccolo uomo che era stato loro padre, sempre: rigido dietro il banco del tribunale, o nella sua misera vita privata a casa. «Tu e tuo fratello potete spaventarlo quanto volete, ma con quella lettera non potete più costringerlo, se non vuole. E se vuole, invece, farà il suo dovere.» Attese le urla del fratello, o di essere picchiata, e non sarebbe stata la prima volta, ma non accadde nulla, lui rimase a guardarla in silenzio, alle spalle, lei sentiva lo sguardo sulle sue spalle, poi uscì dalla stanza. Si svegliò e la milanesina era accanto a lui, già sveglia, la guardò bene, negli occhi, e il petto scoperto, perché gli piaceva tanto, anzi, quel pomeriggio era stato qualche cosa di più che piacergli, la milanesina: era stato come lo scoprire qualche cosa molto di più del piacere, un sentirla vicina come le altre non gli erano state mai, un che di essenziale che fino ad allora nella vita gli era mancato e che lo completava. Ma subito ricordò e uscì dal letto, vestendosi in fretta e mentre si allacciava le scarpe sentì alle spalle il suo piangere, i suoi gemiti trattenuti. Senza neppure volgersi, ma imbrogliando i lacci delle scarpe per l’interna, trattenuta agitazione, disse quieto: «Lo sapevi che era l’ultima volta, eravamo d’accordo, adesso non piangere». Ma lei continuava, e allora, mentre si faceva la cravatta, le disse: «Per te è meglio che non ci vediamo più, tanto voialtre non potete andare mai d’accordo con noi terroni», mentendo anche con lei, proprio con la prima donna con la quale avesse sentito così chiaramente di poter vivere sempre. Anche quando lui si fu messa la giacca, lei piangeva ancora, ora il lenzuolo tirato fino al collo, e forse sarebbe stato meglio non essersi più rivisti: si avvicinò, al letto, rimanendo diritto, senza curvarsi, nella luce grigia di quella stanza, nel lungo pomeriggio. «Io vado», disse, e in quelle poche parole il tono gli diventò un poco solenne. Avrebbe voluto rimanere lì, questo era così chiaro dentro di lui, e lo avrebbe anche potuto, ora, con quella lettera di Rosa in tasca che gli bastava per mandare in aria qualunque matrimonio forzato, ma vi erano cose che non si doveva volere anche se si volevano, e altre che si doveva volere, anche se non si volevano. Lei affondò il viso nel cuscino, per non vederlo, e per non fargli sentire il suo pianto, perché lui gliel’aveva detto, quella mattina, che sarebbe stato così, e lui non si fermò neppure un momento a guardarla, la donna che pure amava come mai le altre, tanto meno Rosa, ma si volse brusco e uscì e per la strada si trovò nel caldo brodoso di quel caldo pomeriggio milanese, i gemiti della milanese nell’orecchio, e benché fosse ancora giorno era in ritardo, Rosa doveva aver già cenato, e non doveva aspettare. Infatti arrivò in ritardo a casa di Rosa, avevano già finito di mangiare e i fratelli e lei erano già davanti alla televisione e il fratello minore venne ad aprirgli e sembrò esitare prima di lasciarlo entrare, come non lo aspettasse, e infatti nessuno lo aspettava. «È Vincenzo», disse alla sorella e al fratello rimasti in sala, e la sorella e il fratello non si mossero. «Buonasera», disse lui entrando in sala. Il fratello maggiore si alzò e accese la luce, e allora lui si accorse che Rosa era ancora con l’abito da casa. «Credevo di essere in ritardo, ma tu non ti sei ancora vestita», e sapeva perché non si era vestita, perché dopo quella lettera non lo aspettava più. Lei volse un poco il capo, cercando di capire, e comprese, e mentì dolcemente: «Non credevo fosse così tardi». «Se vai a prepararti andiamo al cinema», lui disse. Lei si alzò ubbidiente e triste. «Vado subito», disse. I tre uomini restarono nella stanza, in piedi, senza guardare la televisione, senza ascoltare quelle voci estranee, frivole. Lui prese dalla giacca il pacchetto delle sigarette e sentì nella tasca anche la lettera di Rosa, la lasciò lì, tese il pacchetto ai due fratelli: «E il cognac che crea l’atmosfera, non me lo volete dare?» disse. E andò a prenderselo lui stesso, da quella specie di mobile-bar vicino alla televisione mentre i due non parlavano e lasciarono che trovasse anche il bicchiere da sé, anzi i tre bicchieri, e che servisse il cognac anche a loro, e lo bevettero, tutti e tre in silenzio, i due fratelli ancora incerti, finché lui, andando vicino alla finestra, non disse: «Con questo caldo dovremo fare il viaggio di nozze in costume da bagno», non rise lui, e tanto meno i due, rimasero così, in piedi, a fumare, finché lei non comparve nella sala, bella, non amata né voluta. «Torniamo presto», lui disse. I due non gli risposero, lo salutarono con gli occhi, ma il maggiore, d’improvviso, prima di chiudere la porta alle loro spalle gli tese la mano. «Ciao, Peppino», lui gli disse. E prese per un braccio Rosa e cominciarono a scendere le scale dell’alto palazzone dove l’ascensore serviva solo per la salita, e due pianerottoli più in giù egli si fermò, levò la lettera dalla tasca e gliela dette: «Io questa lettera non l’ho neppure ricevuta». Lei non la prese, e allora lui, metodico, la stracciò, regolarmente, prima metà, poi metà della metà, le aprì la borsetta di vernice e vi mise dentro i quadratini lacerati, la richiuse, la tenne ancora per il braccio, e continuarono a discendere gli innumerevoli piani, e lei adesso era certa che era tornato senza amore, ma volontariamente, perché era giusto anche lui, come era stata lei nella giustizia lasciandolo libero, anche se per tanto amore avrebbe voluto tenerlo legato con ogni catena e ogni minaccia e ogni violenza. «Fa troppo caldo per andare al cinema», lui disse, i singhiozzi soffocati della milanesina gli soffiarono ancora nell’orecchio sensibile della memoria, e chi sa per quanto ancora sarebbe stato così, ma continuò a tenere per il braccio, gentilmente, la non amata e non voluta, perché era giusto così, «andiamo al caffè dei giardini, stiamo più al fresco e c’è la musica.» 82 · Il sapore della vendetta Il primo dicembre dell’anno 1962, Remone era stato licenziato. Era il più grosso segretario dell’Invicta Selene Film, aveva sessant’anni, una volta era comparso anche in un film nella parte di un tedesco guardiano a Buchenwald, ma da anni lavorava in ufficio e in autunno era stato incaricato del concorso per trovare la protagonista del film La vera vita di Poppea. Da mesi nuotava in un mare di fotografie di donne aspiranti a divenire Poppea, una peggio dell’altra. Per Natale doveva andarsene, bel regalo di Natale gli avevano fatto quei figli di puzzoni, doveva vendicarsi, su qualcuno o qualche cosa, su quelli dell’Invicta no, perché erano troppo potenti, e dopo varie notti di meditazioni, trovò. Il 10 dicembre sera scelse nell’oceano di foto di racchie e senza seno la peggiore di tutte e con la carta intestata le scrisse una lettera, comunicandole che era stata scelta per la parte di Poppea nell’omonimo film colosso e che il 24 dicembre doveva trovarsi a Roma dove, alla stazione, i dirigenti dell’Invicta, giornalisti e fotografi sarebbero stati ad attenderla. Unì un assegno di ventimila lire e imbucò la lettera, diretta a un piccolo paesino dell’alto Piemonte, a una certa Domenica Tratti. Il 24 dicembre Remone, alto due metri, largo più di uno, rapato a zero, attese alla stazione fin dal mattino e nel pomeriggio vide scendere la fotografata aspirante Poppea, la vide guardarsi intorno, malvestita, racchia, con la sua racchia grossa valigia, la vide vagare per un’ora tra la folla col suo cassone di valigia, finché non la vide piangere, seduta sulla valigiona, e una guardia non le si avvicinò. Allora, soddisfatto, entrò in un bar e bevette piano, piano, pianissimo un caffè, che aveva il sapore forte della vendetta. 83 · Pagherò Sulla scrivania dell’avvocato era accesa una vetusta lampada con un paralume verde. L’avvocato, grassoccio, anziano, controllò il mucchietto delle cambiali, poi gli porse la prima. «Ecco, sono venti cambiali da mezzo milione ciascuna. In questo modo abbiamo evitato la procedura antipatica di versare gli alimenti a sua moglie mese per mese. Una volta firmate le cambiali lei è liberato da qualsiasi impegno economico verso sua moglie, e anche sua moglie non dovrà più avere a che fare con lei...» L’avvocato gorgogliò, ed era il suo modo di ridere: «Naturalmente se le paga...». Anche lui sorrise e cominciò a firmare una dopo l’altra le cambiali, la prima, la seconda, la terza. Oh, certo, le avrebbe pagate. «Per un uomo nella sua posizione», disse l’avvocato, «è molto più fine questa liquidazione degli alimenti.» Sì, naturalmente, più fine. Continuava a firmare, la quarta, la quinta cambiale, illuminato dalla quieta luce antiquata del paralume verde. Alla sesta gli venne in mente quella sera sulla spiaggia con Elisa, quando non erano ancora fidanzati, quella sensazione di amore bruciante che aveva provato per lei, e le parole di lei così appassionate: «Tutta la vita insieme, noi due, vero, Paolo?». Un grande amore, era stato, sì, certo, poi il matrimonio, e poi, ecco la fine con le cambiali. Paolo Valsi, firmò, Paolo Valsi, continuò a firmare Paolo Valsi, pagherò, ed era finito tutto. 84 · Dopo le dieci «Valla a raccontare a un altro...» disse il giovanotto. Sedeva appoggiato al grosso albero che dava una fonda ombra, ma aveva il viso sudato lo stesso per il caldo. Con quel coltello che aveva aperto continuava a raschiare il ramo. «No, la racconto a te, perché è la verità», disse la ragazza, appoggiata anche lei al grosso tronco, i calzoni che le aderivano alle carnose gambe, tutte e due nascosti, sepolti quasi nello sconfinato campo di granturco maturo, anzi bruciato dal sole. «Io sono andata dall’ingegnere per cercare lavoro...» «Ah, ah...» disse il giovanotto giocherellando con il coltello. «Tu fa’ ah ah quanto ti pare ma è così», disse la ragazza, ostinata, «lui mi ha detto che di lavoro vero e proprio non ne aveva.» «Ah, ah...» disse il giovanotto. «Poi mi ha detto che era così solo», tenace la ragazza continuò, «che ogni tanto la sera gli sarebbe piaciuto cenare con una bella ragazza come me.» «Ah, ah...» disse il giovanotto. «Solo cenare», disse incisivamente la ragazza, non guardava neppure il coltello, era staccata da tutto, annoiata, sprezzante. «Io non ci credevo, ma è stato proprio così, stavo in guardia, sai, alla prima mano che allunga gli caccio il tacco della scarpa in un occhio, ma lui niente, due o tre volte alla settimana mi ha portato a cena nei ristoranti di lusso, mi ha comprato anche dei vestiti e tirava fuori i diecimila come niente, e non m’ha toccato mai, neanche per sbaglio.» «Ma come racconti bene...» disse il giovanotto. Ma aveva smesso di giocherellare con il coltello. Stava fermo, ora. «Racconto bene sì, perché è vero», lei disse, più sprezzante che mai, «è un vecchio bacucco, da giovane era pieno di donne e adesso per vanità vuol farsi vedere come una volta con la ragazza dalla gente e dagli amici... Ma poveretto, dopo le dieci mi casca sempre dal sonno.» 85 · Dio vede e provvede La cameriera Emilia, insieme al suo accompagnatore, un giovane magro, piccolo, il naso ossuto e aquilino, uscì dal locale notturno verso le tre, dopo aver studiato i vari numeri di spogliarello eseguiti da una ragazza dopo l’altra, pensando che poteva fare lo stesso anche lei, l’unico dubbio era quella macchia alle reni, molto in basso, una voglia di vino, dicevano, che lei aveva; ma non provava una gran voglia di cambiare attività, a lei andava bene così, col paravento di fare la cameriera e nelle sere libere, il giovedì il sabato e la domenica, aiutata e protetta dal suo sagace giovanotto, guadagnare bene e divertirsi, come quella sera. In macchina, mentre lui l’accompagnava a casa, si struccò con l’alcool, così andava via il fumo e restava un odore di ospedale. «Ciao, ciccino», disse al magro, palpandolo tra le cosce in segno di saluto, quando fu arrivata, e salì svelta in casa, dove la vecchia signora, la sua padrona, in pesante vestaglia, insonne per l’ansia, le chiese subito: «Come sta, come sta?...». «Adesso si è ripresa, ma è stato terribile», disse la cameriera Emilia, alzando la voce. Poi, quando la signora l’ebbe invitata a sedere sul divano, le parlò quasi all’orecchio, ripetendole la storia tutta inventata, perché lei aveva fantasia, della sorellina che era all’ospedale, per questo l’odore d’alcool funzionava, col morbo blu, e ogni tanto dall’ospedale telefonava una suora, ma era un’altra amica del magrolino che telefonava dal bar, per dire che la sorellina stava tanto male e allora la vecchia signora, affezionata a quella bambina inesistente e mai vista, la lasciava andare, anche per tutta la notte. «Fatti coraggio, Emiliuccia, che Dio vede e provvede...» la confortò la padrona. 86 · Le arpe e il commissario Il commissario Ragusa aveva la testa appoggiata sul braccio, e il braccio sulla scrivania. L’altro braccio penzolava inerte. Di lui si vedevano solo i capelli di un biondo, se non chiarissimo, un poco troppo chiaro per un uomo, specialmente se funzionario di polizia. «Dottore, dottore.» Il commissario Ragusa si svegliò subito e alzò il viso. Era giovane, ma aveva il viso duro e scavato e bronzeo di un pellerossa. «Parla», disse all’agente Brosio che lo aveva svegliato. «Abbiamo trovato un cadavere di donna, deve essere morta da quasi due mesi.» «A quest’ora, alle quattro?» «Vede, un cane...» «Andiamo, mi spiegherai in macchina.» Si mise la giacca. «Perché non mi hai chiamato subito?» «Questo è subito», disse Brosio. «Sono andato prima io, per vedere di che cosa si trattasse, certe volte fanno anche degli scherzi, e non volevo svegliarla per uno scherzo.» In macchina, guidando, con dietro altri due agenti, spiegò: un inquilino della casa in cui era stato trovato il cadavere della donna, aveva comprato un cane e il cane gli si fermava sempre al secondo piano davanti all’unica porta del pianerottolo guaendo; non voleva muoversi di lì. Quella sera il cane aveva fatto un inferno, e il suo padrone, andato a letto, ci aveva ripensato. Aveva finito per ricordarsi dell’odore, così si era alzato, era sceso ad annusare pure lui. Aveva risentito il disgustoso odore che veniva da quella porta, dolciastro e insostenibile. Poteva trattarsi anche di un pollo dimenticato dall’inquilino che era partito, ma l’inquilino era ormai inquieto. Aveva svegliato i portinai, insieme avevano deciso di chiamare la polizia. Brosio era accorso con tre agenti. Avevano sfondato la porta, poi col fazzoletto sul naso e la bocca erano corsi ad aprire tutte le finestre; per fortuna era una gelida notte di gennaio e, facendo corrente, almeno una parte dell’insostenibile odore si dissolse. «Ho già chiamato il furgone dell’obitorio, il medico, la scientifica e il fotografo. Forse saranno già arrivati», disse Brosio. Il furgone dell’obitorio era davanti alla porta della palazzina, l’autista dormiva col capo appoggiato sul volante. Di sopra, nell’appartamento erano tutti nella non grande sala, esclusi i due infermieri dell’obitorio che erano in anticamera, con la barella e il grande telo impermeabile. C’era il medico che aveva già fatto una visita sommaria. «Non meno di un mese e mezzo», disse al commissario Ragusa. «Probabilmente di più.» «Lei non potrà dirmelo, dottore, ma propende per un malore o per una morte violenta?» «C’è poco da propendere, commissario. L’hanno strozzata, viene perfino fuori l’osso, guardi il collo», disse il medico. Si tolse i guanti di gomma e andò in bagno a lavarli e disinfettarli. Tutti fumavano, così l’odore del tabacco copriva un poco l’altro, ancora insopportabile. Il commissario Ragusa non aveva l’abitudine di fumare, altrimenti lo avrebbe fatto anche lui. Fece cenno a Brosio di venirgli vicino, intanto notò in fondo alla sala due arpe, una molto grande, l’altra meno. Un altro particolare era che la donna era nuda, ma questo l’aveva visto appena entrato. «Hai i dati di questa donna?» «Sì, abbiamo trovato nella sua borsetta il passaporto.» Il commissario Ragusa lesse coscienziosamente il passaporto: Soletto Matilde, fu Pietro e fu Vicenzi Carla, nata a Torino il 7 luglio 1930, professione insegnante, ecc. Lo restituì a Brosio. Non è che i passaporti dicano molto su una persona. «Manca qualche cosa?» «Non si trova una lira. Anche nella borsetta non c’erano neppure gli spiccioli.» La sala lampeggiava ogni tanto per i flash del fotografo ufficiale che ritraeva la donna da ogni angolo, e ogni tanto si spostava per eseguire le foto che i tre agenti della scientifica gli indicavano di fare. C’era molto disordine nella sala, una poltrona rovesciata, un vaso rotto, i cassetti tutti aperti, e il fotografo fotografò tutto. «Fa’ chiamare i portinai», disse il commissario Ragusa. «Li ho fatti già chiamare, ma non entrano, dicono che loro sono vecchi e non vogliono vedere. Sono qui sul pianerottolo.» «Hanno ragione», disse il commissario Ragusa. Si passò una mano sui folti capelli biondi. Uscì sul pianerottolo e guardò i due: sì, erano abbastanza vecchi. «Da quanto tempo la signorina Soletto abitava questa casa?» «Da quasi dieci anni», disse il vecchio. «Che lavoro faceva? Sul passaporto c’è scritto insegnante. Insegnante di che?» «Insegnava arpa.» «Arpa?» Ah sì, quei nobili strumenti che erano in fondo alla sala. «Aveva molti allievi?» domandò curioso. Non avrebbe mai creduto che vi fossero ancora in giro appassionati di arpa. «Sì, moltissime.» «Anche uomini?» «No, solo donne.» Peccato. Lì invece bisognava cercare l’uomo, perché era un uomo che aveva ammazzato quella donna. «Sa se aveva dei parenti?» «No, non ne aveva nessuno.» «Come fa a saperlo?» Rispose la portinaia. «Io ogni tanto venivo qui nel suo appartamento per farle un po’ di pulizie, e lei mi confidava certe volte le sue tristezze. “Sono sola”, mi diceva, “non ho più nessun parente. L’anno scorso mi è morta anche la mia vecchia cugina, e a questa età chi vuole che mi sposi? Non mi guardano neppure, gli uomini.” Io cercavo di consolarla, ma lei era sempre molto triste.» «Quindi non aveva neppure un uomo. Lei sa se qualche volta portava un uomo in casa?» «Mai. Anche se avesse avuto un uomo, non lo avrebbe certo portato qui in casa sua.» «Ma poteva portarlo di sera tardi, quando lei dormiva.» «Certo, ma non lo credo, non era il tipo da fare certe cose.» Il commissario Ragusa guardò i due vecchi. «C’è una cosa che non capisco. Voi siete certamente dei bravi custodi, come mai non vi siete accorti che una vostra inquilina non si faceva più viva da quasi due mesi? Come mai non vi siete insospettiti di questa lunga assenza?» «Ma noi credevamo che fosse al mare, in Liguria, l’abbiamo vista partire.» «Come l’avete vista partire?» «Ecco, un giorno dei primi di dicembre lei mi disse che sarebbe andata al mare, o a Nervi o a Rapallo, e che sarebbe stata via quasi due mesi. E il giorno dopo, nel pomeriggio, l’ho vista scendere con due valige, c’era fuori un taxi ad attendere, mi ha salutata, e ho sentito che diceva al taxista: “Alla stazione di Porta Nuova”.» Dunque, era partita, e poi non era partita, visto che da oltre un mese e mezzo era lì, morta, e oltre un mese e mezzo voleva dire che era morta ai primi di dicembre, cioè quando aveva detto che andava a Nervi o a Rapallo. Il commissario Ragusa si passò una mano sul biondo dei capelli. Matilde Soletto aveva detto ai portinai che sarebbe stata via due mesi. Partendo ai primi di dicembre, i due mesi implicano Natale e Capodanno. Ora il commissario Ragusa era pronto a scommettere diecimila lire contro dieci lire che l’insegnante d’arpa aveva avuto intenzione di partire con un uomo. Una donna sola non se ne va a passare il Natale e il Capodanno in una pensione di Nervi o di Rapallo. Obiettò a sé stesso: potrebbe essere andata con un’amica. Ma controbiettò: era stata uccisa da un uomo, col quale lei si doveva trovare abbastanza in confidenza, visto che si era spogliata. Le sue obiezioni e controbiezioni vennero interrotte dall’arrivo del magistrato che doveva rilasciare il permesso di rimozione del cadavere. «Ammazzano sempre di notte», disse al commissario Ragusa, «si vede che vogliono fare l’orario notturno per farsi pagare di più.» Si tappò bocca e naso col fazzoletto. «Che odore.» Guardò la misera spoglia, si rivolse al medico: «Il suo parere?». «Evidente, guardi il collo, dottore, non occorre essere medici per capire che l’hanno strangolata.» «Già, non occorre. Da quanto tempo è morta?» «Non meno di un mese e mezzo fa.» «Adesso c’è un posto per scrivere l’ordine di rimozione della salma? Io qui non ci sto», disse il magistrato. «In cucina, dottore», disse il commissario Ragusa. In due minuti, nella cucina, nella corrente gelida per le finestre aperte dell’appartamento, il povero magistrato firmò l’ordine di rimozione della salma. «Me ne vado. Se stanotte ne ammazzano qualcun altro, chiamatemi pure senza avere paura di svegliarmi. Dopo aver visto questo non credo che riuscirò a riprendere sonno.» Allora gli infermieri dell’obitorio portarono giù la spoglia e la misero nel furgone. Poi tornarono su con due bombole di sterilizzante e due corte spatole. In meno di un minuto avevano pulito e disinfettato tutto. «Sentite un po’, voi.» Il commissario Ragusa chiamò i ragazzi della scientifica in anticamera, dove c’era meno corrente. Erano tre, e vennero subito. «Volevo dirvi una cosa. In questa storia c’è un uomo, probabilmente quello che ha strangolato la donna. E c’è anche una storia di soldi. Voi avete visto, anche meglio di me, che quest’uomo ha rovistato da per tutto per cercare qualche cosa. Cosa volete che cercasse? Soldi. Se li cercava, doveva aver fondati motivi per pensare che ci fossero. Lui, forse per l’orgasmo, non li ha trovati, e forse per questo ha ucciso la donna. Ma noi, che non abbiamo tanta fretta, possiamo cercarli meglio, con più calma. Cominciamo a guardare le arpe.» Lui stesso girò intorno alle arpe come intorno a curiose bestie, poi cominciò a passare le mani sul legno a cui erano attaccate le corde, poi batté su questo legno con le nocche, nella speranza che ci fosse qualche vuoto. Non c’era nessun vuoto. Questi legni erano decorati da foglie dorate scavate a sbalzo. Ora il commissario Ragusa trovò strano che una di queste foglie gli tremasse nella mano quando la sfiorava, una foglia intagliata non può dondolare. Allora tirò la foglia, con forza: gli rimase tra le dita e sotto la foglia c’era una minuscola cavità. Vi frugò dentro, trovò una piccola chiave. «Ehi, bella gente», disse ai tre giovanotti della scientifica, che accorsero subito. «Questa è la chiavetta di una piccola cassaforte a muro, o di una cassetta metallica. Se c’è la chiave ci deve essere anche la cassaforte o la cassetta. Cerchiamola.» Verso le sei e mezzo, delusi, fecero una pausa. Avevano bussato a tutti i muri dell’appartamento, dal pavimento al soffitto, avevano spostato tutti i mobili, perché la cassaforte a muro poteva essere celata dietro un mobile, nulla. Avevano ispezionato perfino il bagno: nulla. Il commissario Ragusa guardò ancora le due arpe, pensieroso. Non poggiavano direttamente sul pavimento di legno, ma su uno spesso tappetino marrone. «Spostate le arpe e sollevate il tappetino», disse ai giovani della scientifica. Voleva vedere che cosa c’era sotto. Lo vide subito: c’era un altro tappetino. «Sollevate anche quello.» E sotto il secondo tappetino, in una piccola fossa scavata nel parquet, c’era una piatta cassettina di metallo. «Ecco fatto», disse il commissario Ragusa prendendo la cassettina. «M’arrangio io con questa roba, voi continuate il vostro lavoro.» Insieme con Brosio andò in cucina. «Chiudi le finestre se no prendiamo la polmonite.» Sedette e mise la cassettina sul tavolo di fòrmica, l’aprì facilmente con la chiave trovata nell’arpa. Per prima cosa vide un grosso quaderno con scritto in bellissima grafia Nota spese. Giorno per giorno, con una minuzia incredibile, erano registrate le cifre complessive delle spese fatte, molte volte era specificato anche il genere di spesa fatta, per esempio: Scarpe o Lenzuola. Il commissario Ragusa lo dette a Brosio. «Dagli una occhiata, intanto io guardo qui.» Oltre il quaderno c’erano nella cassetta due libretti d’assegni, di due diverse banche torinesi. Su uno vi erano circa nove milioni, e sull’altro poco più di quattro. Inoltre c’erano duecentomila lire liquide. Il commissario Ragusa guardò le matrici, tenute in ordine scrupoloso. L’ultimo assegno era stato staccato il 3 dicembre dell’anno appena finito. La motivazione era: intestato a me stessa per liquidi. La cifra era di un milione. Cioè il giorno in cui era partita – ma poi non era partita – Matilde Soletto aveva riscosso un milione per avere dei liquidi, probabilmente per il viaggio a Nervi o a Rapallo. Il viaggio non lo aveva più fatto, e del milione non vi era più traccia, la sua borsetta era stata trovata vuota di soldi, neppure un dieci lire. Qualcuno doveva averle preso quei soldi, e c’era solo un qualcuno: quello che l’aveva strangolata. «Guardi qui, dottore», disse Brosio che intanto continuava a sfogliare il quaderno della «nota spese». Con minuta scrittura il commissario Ragusa lesse la minuziosa notizia: 19 settembre 1969 Regalato orologio Vacheron et Constantin a Carlo - Lire 175.000. «Un orologio centosettantacinquemila lire?» domandò. Il suo che andava benissimo, lo aveva pagato sedicimila lire. «Ce ne sono anche da mezzo milione», disse Brosio con sufficienza. «Forse quello del campanile di Venezia», disse il commissario Ragusa. Continuò a sfogliare lui il grosso quaderno. Dal diciannove settembre in avanti, la signorina Soletto aveva regalato a questo misterioso Carlo: un accendino, trentamila lire. Un impermeabile, settantamila lire. E infine una 124, un milione e mezzo. Questo era l’ultimo regalo fatto, verso la fine di novembre, perché dopo, ai primi di dicembre, la generosa donatrice era stata assassinata da colui stesso che beneficiava di quei doni. Ma chi era questo Carlo? E dove era? Non poteva arrestare tutti i Carli d’Italia. Guardò il quaderno della nota spese come a chiedergli aiuto. Lo sfogliò, lo risfogliò e scoprì che in fondo vi era una rubrica in cui i nomi erano messi in ordine alfabetico. Sfogliò la rubrica dell’A alla Z, erano tutti nomi di donna, probabilmente le allieve della professoressa d’arpa. Tranne uno: alla lettera T c’era: Carlo Tonnara , seguiva l’indirizzo e il numero del telefono. C’era una probabilità su un milione che Carlo Tonnara si trovasse ancora a quell’indirizzo, comunque bisognava andare anche per avere altre indicazioni. «Corriamo», disse il commissario. Lo sfacciatello invece era rimasto al suo normale indirizzo, evidentemente sicuro che nessuno sapesse niente di lui, ma ignorando che la signorina Matilde Soletto, la sua vittima, aveva l’abitudine di scrivere tutto, anche il colore dell’impermeabile che gli aveva regalato. Alle sette e un quarto il commissario Ragusa e Brosio gli piombarono addosso, lo svegliarono, lo trascinarono al commissariato col paltò sopra il pigiama senza dargli tempo di vestirsi, e al commissariato, scrollandolo e sbattendolo di qui e di là, e urlandogli orrende minacce, lo fecero confessare. «Basta, basta, sono stato io...» Era oltre tutto un vile. Sì, conosceva Matilde da settembre, l’aveva conosciuta al mare. Si vedevano sempre di nascosto, perché lei teneva molto all’opinione della gente. Poi lui le aveva chiesto di fare una lunga vacanza al mare, a Nervi, dove si erano conosciuti. Lei romanticamente aveva accettato, sarebbero andati con la 124, ma per ingannare la portinaia, lei aveva finto di andare col taxi a Porta Nuova. Erano andati un po’ fuori Torino, avevano pranzato, lui l’aveva fatta bere molto, poi le aveva chiesto di andare un momento a casa sua, prima di partire. Il portone era chiuso, nessuno li avrebbe visti. Lei al principio aveva detto no, inorridita, poi aveva ceduto. In casa di lei, ad un certo punto le aveva chiesto minacciosamente dove avesse i soldi. Lei aveva continuato a dire che non aveva più soldi, che tutto quello che aveva era nella borsetta. Ma lui non si accontentava di un milione, voleva tutto. L’aveva picchiata, aveva minacciato di strozzarla e alla fine l’aveva strozzata davvero. Poi aveva cercato i soldi da per tutto, ma non aveva trovato niente. «Invece c’erano, cretino», disse il commissario Ragusa. «Quasi una ventina di milioni tra assegni e gioielli.» «E dove erano?» disse con spudorata curiosità l’assassino. Il commissario Ragusa gli dette uno schiaffo da rivoltargli la testa. «Levamelo dagli occhi», disse a Brosio, «se no lo rompo.» 87 · Le solite rogne Una voce nervosa di donna gli disse al telefono: «Cosaaa?». Lui ripeté, intimidito: «Ho veduto sull’ultimo numero della vostra rivista una pagina di pubblicità, con un bambino in carrozzina, di un anno o poco più, e vicino c’è la madre...». «E allora?» disse acre la voce. «Ecco, vorrei sapere, per piacere, i nomi del bambino e della madre, se è possibile.» Aveva davanti a sé, telefonando, la pagina della rivista, la fotografia a colori del bambino seduto in carrozzina era chiara, brillante, ma la madre si vedeva molto di scorcio, eppure gli sembrava proprio Carla, lo zigomo e il taglio dell’occhio, e i capelli erano gli stessi, e il bambino, ma doveva essere suggestione, rassomigliava a lui. «Mi scusi», disse la voce, accesa d’impazienza, «ma questa è la redazione, non ne sappiamo niente di pubblicità.» L’ufficio pubblicità, una voce ugualmente nervosa, gli rispose che loro non sapevano niente, doveva rivolgersi alla ditta che aveva fatto la pagina di pubblicità sulla carrozzina. Ma anche dallo studio pubblicitario, la voce scattante di un giovanotto gli disse: «Ah, noi non sappiamo niente, ci sono i fotografi che ci procurano le fotografie, noi facciamo soltanto il bozzetto della pagina», e disse che non sapeva il nome del fotografo. «Caro, mi lasci telefonare un poco anche a me?» disse lei entrando. Allora lui rivoltò subito la rivista, col viso del bambino che aveva la sua stessa fronte quadrata e l’occhio infossato, e lo scorcio del viso di Carla, ormai era sicuro che era lei, e allora il bambino era suo, ma adesso non erano forse ricerche inutili? «Le solite rogne d’ufficio», disse alla moglie. 88 · Carabiniere con febbre Sua sorella aveva il fidanzato. Il fidanzato aveva l’auto e al sabato e alla domenica passava a prendere sua sorella per un giro nei dintorni. Lei accompagnava i fidanzati e faceva da guardia. Aveva otto anni e conosceva benissimo i motivi di questo ordine che le aveva dato la mamma. I fidanzati andavano o in una piccola osteria sul fiume appena alle porte della città, oppure in una piccola osteria sul lago vicino alla città, e lei li seguiva sempre, minuto per minuto, metro per metro, conosceva il suo compito e lo eseguiva. Era inutile che il fidanzato avesse l’aria molto seccata ogni volta che la vedeva. «Ciao, carabiniere», le diceva. Ed era inutile che sua sorella la tentasse: «Va’ un po’ a spasso sulla riva del fiume e lasciaci in pace, ti do i soldi per gli stivaletti nuovi». Lei restava incollata a loro due, eseguiva il suo compito di sorveglianza con discrezione ma inflessibilmente. Li lasciava soli quel minimo di tempo sufficiente per darsi un bacio, non molto di più, poi riappariva con ingenua impudenza e diceva alla sorella: «Cati, è tardi, torniamo a casa». Quel sabato, come tutti gli altri sabati, il fidanzato di sua sorella venne con l’auto, e lei scese subito in strada con sua sorella. Il fidanzato non era al volante, era fuori dell’auto, appoggiato all’auto e le guardò. Si vedeva che era nervoso. «Adesso basta con questo scherzo della sorellina che ti accompagna», disse, con voce cattiva ed incattivita sempre più. «Io voglio andare a spasso con te da sola, senza guardiani e sorveglianti. O rimandi su a casa questo microbo, o se no te ne cerchi un altro.» Sua sorella taceva, si vedeva che era molto impaurita perché aveva capito che lui parlava sul serio. Poi sua sorella si volse verso di lei, la guardò, disperata, ma che poteva dire a una bambina così piccola? Cercò disperatamente, poi le disse: «Titti, adesso torniamo su dalla mamma, e le dici che ti senti male, che hai i brividi di febbre e che non puoi accompagnarci... Hai capito?». Sperò che la bambina capisse. E lei guardò i due, il fidanzato, torvo, appoggiato all’auto, e la sorella, vicina alle lacrime. Capì benissimo: se lei non li lasciava soli, il fidanzato si stufava e piantava sua sorella. Aveva sentito tante storie di fidanzati, nel grande casamento in cui abitava, che era edotta. Esitò solo un attimo, poi disse: «Sì». Rientrò in casa accompagnata da sua sorella. La mamma aprì la porta e chiese: «Che cosa è successo?». Lei disse: «Mamma, ho freddo, ho i brividi...». Sotto le coperte, col termometro all’ascella, a misurare una febbre inesistente, lei ascoltò felice il rombo dell’auto del fidanzato di sua sorella. Adesso sarebbero stati soli, e lui non sarebbe stato più tanto arrabbiato, forse così avrebbe sposato sua sorella. 89 · Le boutique fantastiche «Io direi che questo non è il suo posto», disse il grosso uomo, la grossa zampa, più che mano, tesa verso di lei che andava come disboscandola, potandola, pigramente, perché era l’ultimo cliente della serata, venuto lì più per parlare con lei che per farsi curare le mani, e con le sue mance, grosse anche quelle come le sue zampe, doveva aver convinto i lavoranti a starsene lontani, come se ne stavano infatti lontani da loro due. «Gliel’ho già detto, la direttrice di quella mia boutique è andata via, sa, per una settimana o due si può tirare avanti, ma io ci vedrei lei, a dirigerla, è un tipo fine, elegante, si vede che di moda se ne intende, solo che dovrebbe darmi una risposta al massimo domani, ci pensi bene, prima di decidere.» Lei affrontò l’anulare di quella rosea bistecca a forma di mano, non aveva proprio nulla da pensare, oltre tutto la mano che stava pigramente lavorando era perfettamente uguale all’altra mano che tre anni prima accudiva, una volta alla settimana, e il cui proprietario, quasi con la stessa voce, le aveva fatto la stessa proposta, aveva anche quello una boutique – che poi non esisteva, però – e lei dopo tre anni di spinose avventure, fermata una volta anche dalla polizia, e ammonita, era riuscita a tornare al suo vecchio posto di manicure, e lo stomaco per riprendere la strada delle boutique, esistenti o meno, non se lo sentiva più. «La ringrazio molto, dottore, ma le ho detto che il mio fidanzato non vuole», tubò gentile per non perdere la mancia con uno sgarbo, anche se il fidanzato non l’aveva più, dopo le boutique, ma solo tipi come quello. 90 · Il rastrellamento La banda entrò nella pineta, erano cinque giovani, ciascuno aveva una grossa torcia elettrica in mano, spenta, indossavano camiciole a rigoni da materasso, un paio erano a torso nudo. Il mare era così vicino che si sentiva lo sciacquio molle delle molli onde; la luna era soltanto metà, ma era così luminosa che sembrava una grossa lampada in cielo. «Viva la virtù», disse un biondino, uno dei due biondini della banda, «il rastrellamento incomincia.» Il gioco del rastrellamento era il più divertente per i cinque ragazzi. La sterminata pineta lungo la riva del mare era asilo di coppie di innamorati di ogni genere. In punta di piedi, in silenzio, disposti a ventaglio come la formazione di un commando di marine, i cinque giovani abbastanza bene del paese rastrellavano la pineta e appena scoprivano qualche coppia in amorosa solitudine irrompevano contro i due innamorati, li accecavano accendendo contemporaneamente le loro torce elettriche e li irridevano gridando: «Viva la virtù! Abbasso il peccato!» e li costringevano a uscire fuori dalla pineta inseguendoli con lunghe urla. Quella sera il rastrellamento sembrava promettere bene. Prima trovarono la padrona di una pensione vicino al lungomare, che tutti conoscevano, non più giovanissima e sposata, che s’intratteneva con un alto, grosso tedesco, poi una giovane coppia di fidanzati austriaci, poi una signora milanese con un ragazzo del luogo, il Federichino Fellinino, come l’avevano soprannominato perché era piccolo e aveva la cinepresa, che accecato dalle cinque grosse torce disse in dialetto: «Ma piantatela, cretini». E lo lasciarono in pace, perché era uno dei loro. Il rastrellamento proseguì nel folto della pineta, punteggiato dalle grida delle ragazze che sotto le implacabili torce accese si ricoprivano frettolosamente e le urla: «Viva la virtù, abbasso il peccato!» del commando di rastrellatori. Quasi in fondo alla pineta, nel punto più lontano dal mare, la banda sentì il sussurrio di una coppia e irruppe, accendendo le torce e urlando: «Fuori, vergognatevi, non avete pudore!» e grosse risate romagnole. «Ma è la Teodolinda...» disse uno dei ragazzi della banda, e le risate si spensero subito. Teodolinda era il soprannome di una ragazza del paese, una delle più belle, fidanzata a uno dei cinque rastrellatori con la torcia accesa in mano, che si chiamava Guidarello, era lì e la guardava. Guidarello alla luce spietata delle torce guardava la sua ragazza, la sua Teodolinda che si ricopriva affannosamente, vicino a un tipo biondo, non molto giovane, che doveva essere un bavarese. «Ciao», disse Guidarello a Teodolinda, «mi avevi detto che stavi a casa perché tua madre stava male.» «Spacchiamo la faccia a quel crauto», disse rabbioso uno dei rastrellatori, «e dopo Guidarello le suona a lei fino a che diventa nera.» Guidarello li fermò. «Spegnete la luce», disse spegnendo la sua torcia, la voce greve di furore e di dolore, «la pineta è di tutti», e un secondo dopo urlò: «Ho detto di spegnere la luce!». Allora anche le altre quattro torce si spensero, i cinque giovani si allontanarono. Il rastrellamento era finito. 91 · Doppio gioco “Adieu, adieu, douce France”, pensò il bretone Jacques Ledouc, imboccando al volante della sua Citroën blu scuro il traforo del Monte Bianco. Jacques Ledouc percorse senza fretta i dodici chilometri del traforo, la sigaretta tra le labbra, neppure accesa, i medici gli avevano proibito di fumare e lui ubbidiva, perché gli premeva vivere, ma, duro bretone qual era, non aveva ceduto del tutto, la sigaretta in bocca la teneva anche se non l’accendeva. Il giovane carabiniere italiano guardò attentamente il passaporto del bretone. «Jacques Ledouc, di professione rappresentante». In realtà la vera professione di Jacques Ledouc era quella di assassino. In Francia, quando un poliziotto isolato lo incontrava e lo riconosceva, invece di andargli incontro e tentare di arrestarlo, faceva finta di non averlo visto, si nascondeva nella prima via traversa, perché se avesse tentato, ci avrebbe probabilmente rimesso la pelle. Ma il giovane carabiniere italiano non poteva sapere tutte queste cose. Esaminò scrupolosamente il passaporto di Jacques Ledouc – passaporto scrupolosamente falso – e lasciò entrare nella «douce Italie» uno dei più pericolosi assassini che la materna Francia avesse mai dato alla luce. A Courmayeur, il bretone Jacques Ledouc si fece un caffè, poi, sigaretta non accesa in bocca, via per la Val d’Aosta, verso Torino. Il suo mestiere gli piaceva perché gli permetteva di viaggiare. L’anno prima era stato in Spagna ad ammazzare uno che aveva voluto fare il furbo, e si era fermato a Pamplona, dove aveva veramente vissuto i giorni più felici della sua vita. Ogni tanto, guidando, si toccava il taschino a sinistra della giacca: sotto vi era una robusta Mirage Quatrième calibro 9. Anche in fatto di armi Jacques Ledouc preferiva i prodotti nazionali. Torino. La Citroën si fermò in via Cernaia, davanti all’ingresso di un albergo. Jacques Ledouc scese, chiese una camera – parlava solo il francese ma sapeva che lì a Torino quasi tutti lo comprendevano – salì in stanza, e, appena solo, controllò l’arma: la Mirage Quatrième era perfettamente in ordine. Poi sollevò il ricevitore del telefono e chiese un numero al centralino. Aspettando che gli dessero la comunicazione, si mise in bocca una sigaretta, senza accenderla. Il telefono squillò. «Allò. Mr. Harara?» disse. «Sono io.» «Bien, alors tu viens tout de suite à mon hôtel, pour rencontrer ton vieux compagnon, Jacques le breton.» «Tout de suite, Jacques.» Dopo un quarto d’ora bussarono alla porta; sistemandosi meglio la Mirage sotto la giacca, Jacques andò ad aprire, con cautela. Era Marquise Harara, nigeriano purosangue, studente di lingue, ufficialmente in Italia, a Torino, per perfezionarsi in italiano, ma che arrotondava le sue entrate facendo la spia e la «filiale» italiana della banda di Jacques. Jacques abbracciò Marquise con passionalità bretone. «Ciao, negrone, ti sei abbronzato ancora un po’ di più, vecchia scimmia.» «Abbracciami poco, Jacques, perché ho una cattiva notizia da darti», disse Marquise. Jacques gli dette un buffetto sulle guance: «Parla, bell’orango». «Ho perso Isabella», disse Marquise. Jacques si oscurò subito: «Cosa vuol dire: perso Isabella?». «Vuol dire che mi ha seminato. Fino a due giorni fa era qui a Torino. Adesso è scomparsa, non va neppure al lavoro, in banca, non è a casa, e sua sorella non sa dove sia. Insomma è scomparsa.» «Allora sei orango e anche cretino.» «Può darsi», disse il negro, rassegnato al duro linguaggio del bretone. «E perché sarebbe scomparsa?» disse Jacques. Marquise alzò una spalla. «Sai, aveva la coscienza sporca. Il meglio che poteva immaginare era che venisse qualcuno dalla Francia ad accopparla.» «E tu cosa ci sei stato a fare, scimpanzé?» «Non posso seguire Isabella ventiquattro ore su ventiquattro.» Il bretone si sfilò la Mirage dal sottoascella, la fece saltare in aria, la riprese in mano – gesto insulso, grottesco in quel bonario e pacifico albergo torinese – e se la rimise nel sottoascella: «Adesso, però, negretto, tu mi ritrovi Isabella, se no sono guai. Quella baraccona deve tacere, per sempre, e sono venuto qui in Italia per questo, non per una scampagnata». «Certo che la ritroviamo», disse Marquise Harara, con apparente gentilezza, ma con sotterraneo fastidio. Era un nigeriano intellettuale, vissuto quasi sempre in Europa, la volgarità di quel bianco gli dava pena e noia. Tre giorni prima, Isabella Fioretto usciva dalla banca in cui lavorava. Fuori c’era una Mini Morris che si mosse e la seguì. Al volante c’era un alto e grosso negro, Marquise Harara. Era uno splendido esemplare di nigeriano. Seguì la ragazza fino alla fermata del filobus, lì aprì la portiera. «Sali», disse. Isabella Fioretto salì nell’auto. Il negro avviò la macchina, guidando per le strade più solitarie e più buie di Torino Nord. «Ti hanno scoperto, Isabella», disse, fermando in uno dei più bui vialoni della periferia. «E fra un paio di giorni arriva qui uno dalla Francia per farti fuori.» Rassegnata, Isabella annuì, lo immaginava. Aveva passato i trenta, ma era molto bella, era bellissima, non le sarebbero mancate le occasioni di sposarsi, in compenso aveva un carattere molto estroso e non si legava mai a fondo con nessun uomo. Cambiava. Spesso. Ma aveva un’ottima posizione nella banca in cui lavorava. Era la migliore public relation tra la banca in cui lavorava e le altre banche, il miglior servizio informazioni bancario che si potesse desiderare. Un giorno era arrivato dalla Francia un bellissimo giovanotto, tipo Alain Delon, diciamo, l’aveva abbordata e, senza troppa difficoltà, l’aveva, come dire?, sedotta, e intanto che la seduceva, in una specie di luna di miele attraverso il Canavese, l’aveva fatta parlare del suo lavoro. Isabella sapeva tutto, su tutte le banche del Piemonte, era una forte lavoratrice piemontese e le piaceva parlare del suo lavoro. Il tipo Alain Delon le aveva fatto conoscere anche il negro, Marquise Harara. A un certo punto, siccome le informazioni che lei dava spontaneamente sulle banche non erano sufficienti, l’Alain Delon l’aveva picchiata e torturata per sapere il resto, e lei aveva dovuto dirlo. Da quel momento, in tutto il Piemonte, erano cominciate le rapine alle banche, anche dei paesi più piccoli. Conoscendo matematicamente – Isabella aveva dovuto dirglielo – i giorni e le ore in cui le banche erano più «gravide» di soldi, e sapendo per ogni banca la consistenza del numero degli impiegati, del servizio di sorveglianza, i rapinatori agivano a colpo sicuro, banca dopo banca, entravano in Italia, facevano la rapina e tornavano in Francia. Perfino troppo facile. Ma la rigida impiegata di banca piemontese – seppure morbida, sotto certi aspetti, come dire?, galanti – si ribellò a quella serie di rapine di cui, per puntigliosità morale, si riteneva responsabile, e vi pose fine. Come? Con una telefonata anonima alla polizia, dette tutti i dati dell’uomo che, seducendola, aveva ottenuto tutte le sue confidenze bancarie, specificò che si trattava di rapinatori che venivano dalla Francia. Alla polizia italiana, insieme con quella francese, fu facile bloccare il flusso delle rapine. In un’ultima incursione in territorio italiano per fare rapine nelle banche del Piemonte, la banda venne arrestata quasi al completo. Duramente interrogati, i rapinatori finirono per fare il nome dei loro capi, che vennero arrestati a loro volta. Fu veramente una disfatta per la malavita francese, della banda si salvarono soltanto un paio di grossi capi, e una mezza dozzina di scherani, tra cui il bretone Jacques Ledouc. Marquise Harara era andato quella sera a prendere Isabella all’uscita dalla banca. La seguì, fino alla fermata del filobus. Lì, aprì la portiera; e le disse che stava arrivando dalla Francia un uomo per ammazzarla. Nella Mini Morris lei sudò tutta la sua angoscia, perché si rendeva conto del pericolo. «Perché mi dici queste cose? Fai parte anche tu della banda. È un inghippo?» «No, non è un inghippo», disse Marquise Harara. «Voglio solo salvarti.» «E perché vuoi salvarmi?» lei aveva domandato. Marquise Harara aveva posato la sua nera mano sul bianco ginocchio di Isabella. «Perché ti voglio bene. Penso sempre a te. Molte volte non dormo. Ti vedo. Ti abbraccio, nella mia mente.» «Leva quella mano.» «Sì, la levo, ma io ti desidero, da impazzire.» «Mi dispiace, Marquise.» Marquise ansava, nello sforzo di controllare il suo desiderio. «Sì, lo so, sei una razzista, non ti piacciono i negri, vai con l’ultimo farabutto bianco, ma con un negro no.» «Scusami, Marquise», lei disse. Era così. I negri le ripugnavano. «No, non ti scuso», lui ansava sempre. «Potrei violentarti, qui in auto, e vorrei proprio farlo, ma non mi piace violentare le donne, voglio il loro consenso. So che non l’avrò mai, sporca razzista che non sei altro, ma voglio salvarti lo stesso. Te l’ho già detto, scompari da Torino, prima che arrivi l’assassino. Non occorre che tu vada lontano, basta che vada in un posto che nessuno sappia, che non lo sappiano né in banca, né tua sorella.» Le mise ancora una mano sul ginocchio, non resistendo all’impulso che gli fiammeggiava dentro. «Leva la mano.» «Sì, la levo», disse lui amaro e umiliato. «Va’ dove vuoi, ma va’ via. Ogni tanto telefonami, di notte, così potrò darti le ultime notizie.» «Grazie», lei disse. «Leva quella mano.» «Sì, la levo.» Il negro, Marquise Harara, guidava la Mini Morris, a fianco c’era Jacques Ledouc, il bretone. Dopo un poco, l’auto si fermo in una corta via della periferia. «Ecco, è qui che abita la sorella di Isabella», disse Marquise. «Credi che capisca il francese?» disse Jacques. «Penso di sì. Ti aspetto qui.» «Bravo negretto, torno subito.» «Terzo piano», precisò il negro. Jacques Ledouc entrò nel portone, salì al terzo piano, una giovane donna venne ad aprirgli. Era la sorella di Isabella, era una giovane dolcissima piemontese, timida di fronte agli uomini belli, e il bretone, oltre che assassino, era anche bello. Si chiamava Anna. «Scusi, signorina», le disse nel suo duro francese. «Vorrei parlare con la signorina Isabella Fioretto.» «Mia sorella non c’è», disse la giovane Anna, facendolo entrare e, ignara, richiudendo la porta. «Oh, mi spiace, avevo proprio bisogno di parlarle.» «È andata fuori Torino, mi ha detto, ma non mi ha detto dove.» «Che peccato, era una cosa urgente.» Il bretone studiava la dolce, timida piemontese. Capì che era sincera: non sapeva davvero dove era la sorella. Poi gli venne da ridere. Rise dentro di sé, senza suono. Aveva scoperto il modo di trovare Isabella Fioretto, la sorella di quella gentile, timida, sensibile torinese che gli era davanti. Le mise d’improvviso le mani al collo, strinse con tutta la sua forza, con tutta la sua forza premette il pollice della sinistra e quello della destra, contro la carotide, fino a spezzare l’osso, e, solo quando fu sicuro che era morta, allentò la bestiale stretta, e lei cadde a terra. Poi lui uscì, scese in strada, saltò nell’auto, vicino a Marquise che era al volante. Ridacchiava, adesso apertamente, si mise in bocca la sigaretta non accesa. «Va’ negro, fermati al primo posto con un telefono pubblico.» Continuava a ridacchiare. «Ho trovato il modo di sapere dove è la nostra Isabella.» Rideva piano, ma di gusto. «Sai, le ho fatto fuori la sorella. Allora che cosa succede? Sai, gli italiani hanno il senso della famiglia, appena Isabella legge sul giornale che sua sorella è stata strangolata, corre qui, a Torino, per i funerali, le corone, e le altre storie di questo genere. E io la stendo.» Disse: «Moi je la descend» con vero gusto da intenditore, pregustando golosamente l’assassinio. «E adesso tu fa’ una telefonata anonima alla polizia, avvertendo che nella via tale, al numero tale, c’è una morta strangolata. Voglio che si sappia subito che la sorella di Isabella è morta, che la notizia sia sui giornali di domattina.» Marquise dovette ubbidire. Al primo bar telefonò alla polizia, avvertendola che Anna Fioretto, la sorella di Isabella, era stata assassinata. Poi il bretone lo lasciò libero. Lui andò subito a casa e sedette vicino al telefono. Ogni tanto Isabella, specialmente la notte, gli telefonava, per sapere se ci fosse qualche cosa di nuovo. Gli aveva telefonato la sera prima e lui l’aveva informata che era arrivato l’assassino Jacques Ledouc. Aspettò tutto quel giorno e tutta quella notte la telefonata. Ma invano. Lui non poteva telefonarle perché non sapeva dove era. Non aveva voluto sapere dove si fosse nascosta, e le aveva spiegato il perché: «Vedi, potrebbero accorgersi che io faccio il doppio gioco con te, e allora mi torturerebbero per sapere dove sei nascosta e io dovrei dirlo. Non dirmelo dove sei e cambia domicilio ogni due o tre giorni. Se resisti tre o quattro settimane, forse si stancano, e ti lasciano vivere». Ma quella notte Isabella Fioretto non gli telefonò, e lui non poté avvertirla di non venire a Torino anche se leggeva sui giornali che sua sorella era stata assassinata, perché altrimenti sarebbe stata uccisa anche lei. È vero, gli italiani hanno il senso della famiglia. Al mattino Isabella Fioretto lesse sul giornale che sua sorella era stata strangolata. Capì benissimo perché: perché non aveva saputo dire dove lei si era nascosta. Inorridita, sconvolta, uscì dal suo nascondiglio, si precipitò a Torino, andò all’obitorio e vide sua sorella Anna, morta, nella squallida cella frigorifero, passò in un ufficio di pompe funebri, e poi in chiesa, per ordinare i funerali, seguendo meccanicamente, senza saperlo, un itinerario che l’avrebbe condotta alla morte e che Jacques Ledouc aveva precalcolato. L’ultima tappa dell’itinerario: Isabella andò a casa, cioè dove lei abitava con Anna quando era a Torino, e dove Anna era stata uccisa. Voleva rimettere in ordine tutte le cose che erano appartenute a sua sorella morta. Il senso della famiglia. Cioè, tentò di andare a casa sua. Non vi riuscì perché vicino al portone c’era Jacques Ledouc a fare la guardia, da parecchie ore. Lui non la conosceva. Ma Isabella era talmente rassomigliante a sua sorella Anna, che lui non ebbe dubbi. La bloccò mentre stava entrando nel portone. «Salta su quella Citroën, vicino al negro che guida, se no ti faccio scoppiare come un palloncino.» Lei non ebbe scelta, capì di essere caduta in trappola, ma ormai non poteva farci niente. Salì vicino a Marquise che era alla guida, fingendo di non averlo mai visto. Il bretone salì dietro, la Mirage Quatrième calibro 9 impugnata. «Scimpanzé, portaci in un posto tranquillo, devo fare due chiacchiere con la signorina.» Il negro accennò di sì. Sapeva che cosa voleva il bretone, andare in un posto abbastanza deserto per potere sparare a Isabella. Solo questo. «Andiamo verso la collina», disse. «Andiamo al monte del cavolo che vuoi, ma andiamoci subito.» La Citroën attraversò Torino, attraversò il Po, salì sulla collina. «Ecco, qui va bene», disse il bretone, quando furono quasi in cima, in un tratto di strada vuoto anche di case. Brandeggiò la sua Mirage Quatrième, e la puntò contro la nuca di Isabella. «Signorina spiona, stai ferma, così soffrirai di meno.» Non fece in tempo a premere il grilletto della Mirage. Il negro Marquise Harara si volse di colpo e gli sparò in piena faccia i sei colpi della sua modesta Beretta calibro 7,65. E la faccia dell’assassino Jacques Ledouc esplose, divenne, come la faccia visibile della Luna, piena di crateri, ma sanguinosi. Il bretone era morto. Isabella scoppiò a piangere per il terrore. Aveva sentito sulla nuca il duro della canna della Mirage, ed era stata una sensazione che non avrebbe dimenticato mai più. «Non piangere, Isabella», istintivamente Marquise le mise una mano sul ginocchio, istintivamente la mano tendeva a salire, ma si fermò. «Ormai è finita per te.» «Ma ti faranno fuori, appena sapranno che hai ucciso Jacques», disse lei singhiozzando. «Certo, che mi faranno fuori, ma l’importante è che sia salva tu.» La mano salì e lui non aveva più la forza di trattenerla. Singhiozzando, aspramente lei disse: «Leva la mano, leva la mano, per favore». Sì, sì, sì, maledetta razzista che non sei altro, pensò, lo sporco negro leva la mano dal candido giglio bianco, sì, sì, sì. Ma non disse queste cose, levò la mano e disse pacato, da buon africano intellettuale: «Scendi, disperditi, scompari. Penso io a sistemare il morticino che abbiamo alle spalle». La guardò, dalla Citroën, allontanarsi per la strada deserta, e scomparire alla prima curva, con la sensazione, nel cavo della mano, del suo ginocchio, sporca razzista. 92 · L’innamorato che non si ferma La piccola auto gialla del circo equestre girava da quasi mezz’ora per tutte le strade del paese, e l’inserviente seduto vicino a quello che guidava, ripeteva nel microfono il suo appello che saliva per le piccole strade, le poche piazze, che di colpo divenivano deserte anche se era sabato sera, illuminate più dalla luce della luna che dai lampioni, e finito il giro del paese l’auto imboccò le strade intorno perché anche quelli delle fattorie vicine fossero avvisati e l’altoparlante sgranava le parole, in fondo quiete per il tono pacioso dell’inserviente in giacca con alamari, le echeggiava per i sentieri biancheggianti di luna, sopra i campi geometrici gonfi di grano, finché quelle parole non arrivarono anche a loro, metalliche e un poco distorte per l’auto che prima si avvicinava e poi si allontanava; a loro distesi, lontani da ogni casa e sguardo, sull’erba folta che faceva da tappeto ai gelsi lungo il fossatello, e abbracciati e lontani da tutto che non fosse loro stessi, ma, benché tanto lontani, non così lontani da non udire alla fine quelle parole. È fuggito il leone dal circo, rientrate subito in casa e non uscite finché non vi avviseremo. L’altoparlante le sgranò vicinissimo a loro, rombando, e poi più e più volte, sempre meno udibili, sparse nel polverio nitido della luna. Lui si sciolse bruscamente dalla ragazza, bruscamente fu in piedi, ansante, guardando intorno, nel chiarore quasi diurno della notte, ma la prima casa era sempre molto lontana. «Corri!» le gridò malamente, e già lui correva, verso quella casa rifugio, frenetico. «Aspettami!» lei gridò. Nonostante il terrore doveva pur ricoprirsi e non avrebbe potuto mai correre come lui, ma lui si volse appena, gridando strozzato, senza fermarsi. 93 · Il più bel ragazzo del mondo Dopo aver corso come zanzare impazzite, i due rapinatori rallentarono solo alle prime case della città, era andata bene, ma quello con tanti capelli neri aveva dovuto sparare, non erano preparati, e la vista dell’uomo che aveva fatto subito sangue dalla bocca li faceva ancora sudare gelido. «Fermiamoci un momento a bere, se no svengo», disse il Tanticapelli, e si fermò. «Una grappa doppia», ordinò alla ragazza che era alla cassa. Era un bar tabaccheria appena aperto, in quella zona quasi in campagna, il palazzo più vicino era a duecento metri, non c’era nessuno, esclusa una biondina seduta vicino al juke-box muto, e un ragazzotto che faceva da barista. «Un’acqua minerale, gelata», disse l’amico di Tanticapelli. Adesso bruciavano, dopo il gelo di prima, con quel morto sullo stomaco e la polizia che si sarebbe scatenata. Tanticapelli mise un cinquantalire nel juke-box, sorrise gentile, galante, alla ragazzina bionda che abbassò gli occhi: «Signorina, scelga lei un disco». Lei era la figlia del portinaio del palazzo, il bar con la televisione e il jukebox era la sua ora mondana, al bar venivano molti ragazzi, ma nessuno l’aveva così travolta come quello, con quegli occhi, quella voce vibrante. Schiacciò i bottoni del juke-box, aveva sedici anni e aveva sempre pensato a un uomo come lui. «Metto F-5», disse, la voce era ancora infantile. «È Cuore, cantata da Rita Pavone.» Forse lui abitava lì vicino e lo avrebbe rivisto; arrossì, per le parole della canzone, forse lui avrebbe intuito che aveva messo quel disco apposta, per fargli capire, come diceva la canzone, che il suo cuore cominciava a soffrire d’amore: era il più bel ragazzo del mondo. 94 · Il rossetto sommerso La gente del luogo lo sapeva che nel lago, a una ventina di metri di profondità, c’era ancora l’auto, una sciagura di molti anni prima, e il giovane sub appena glielo dissero volle andare a vedere, non era facile, anche per il buio, ma era un esperto e incastrata tra due rocce, per questo non avevano potuto riportarla in superficie, c’era la vecchia auto, lucida, come fosse da poco sommersa, quasi da poche ore, per le correnti che continuamente la sciacquavano e ripulivano, qualche erba che fluttuava nell’interno, una portiera spalancata, come se qualcuno stesse per salirvi e il giovane sub mise dentro il capo, curioso, per il senso di avventura e di tragico di quell’auto sommersa, quando vide rilucere qualche cosa sul pavimento della vettura, vicino al posto di guida, lo prese, non distingueva bene cos’era e risalì in superficie, così vide che era un astuccio di rossetto, c’era ancora un po’ d’impasto, dentro, quando riuscì a svitarlo, di un rosso cocomero, la ragazza qualche attimo prima dell’incidente doveva averlo levato dalla borsetta per usarlo, l’uomo che le era a fianco e che guidava, l’aveva baciata molto, prima, quando si erano fermati, adesso lei doveva ricomporsi, il sub la vide con l’astuccio del rossetto in mano, pronta per dipingersi le labbra nonostante le lievi scosse dell’auto. Forse aveva detto al suo compagno: «Va’ piano, se no non riesco a mettermi il rossetto», forse non aveva neppure finito la frase e l’auto, uscita di strada, piombava nel lago, forse stava per svitarlo quando si era trovata nel fondo del lago, ancora viva, il rossetto in mano, e ormai non importava più, né dipingersi, né nessun’altra cosa. Il sub, seduto sul grosso sasso dal quale dominava il lago, riavvitò l’astuccio, e con un gesto subitaneo lo ributtò nel lago. Era un ragazzo sensibile e immaginoso, ogni volta che avesse visto una donna dipingersi le labbra avrebbe immaginato quella sommersa, ancora nel gesto di darsi il rossetto. 95 · Una vedova giovane Stavano portando fuori dal negozio, anzi dalla boutique come diceva l’insegna, sotto i portici della piazza, come le boutique delle grandi città, l’ultimo baule con dentro i pochi abiti che nessuno del paese, né dei paesi vicini, era mai venuto a comprare e lo misero sul camion, accanto agli arredi: le due poltroncine di velluto oliva, il tavolo ovale, svedese, le specchiere, il lampadario a gocce e la caterva di appendiabiti, come nuovi, anzi nuovi, e la pioggia grandinava sul telone del vecchio camion, e sotto i portici, quasi nascosti vigliaccamente dietro le colonne c’erano diversi vermi del paese, e altri, oltre che vermi anche sadici, che guardavano soddisfatti la giovane vedova fradicia di pioggia affannarsi col vecchio autista a caricare la roba e sloggiare dal paese; e c’era anche il Verme Supremo, il giovane elegante in impermeabile bianco e scarponi inglesi da pioggia, il figlio del maggior notabile della zona, il gangster che non stava dietro le colonne, ma stava vicino al negozio, alla boutique. «Tortorella, se davi retta a me non ti capitava questa cosa», disse il gangster alla giovane vedova che usciva dalla boutique con l’aspirapolvere che caricò da sola sul camion, rabbiosa. Se dava retta a lui: non lo guardò neppure. Coi due soldi che le aveva lasciato il marito morendo aveva aperto la boutique, l’unica nei paesi intorno, ma siccome aveva rifiutato di andare a letto col Giovane Potente del paese, nessuno era mai venuto a comprare niente, perché nessuno voleva dispiacere al pericoloso individuo, comprando da lei. E ora, dopo aver resistito un anno, lei doveva chiudere. Ma, prima di salire sul camion, gli gridò forte, perché sentissero anche gli altri: «Però con me non ci sei riuscito, come con tutte le altre». Era il suo trionfo. 96 · Lolite si muore «Due bustine di aghi», disse la ragazza. Aveva una lunga treccia che le arrivava quasi fino alle reni e, bruna, sul paltoncino chiaro, spiccava vistosamente. «Un momento», disse nervosa la merciaia, stava servendo una vecchia cliente puntigliosa. Fuori c’era molto sole, anche se in quella stretta via milanese non ne arrivava che una sottile striscia in alto, all’ultimo piano delle case, e ogni tanto un colombo volava dalla piazzetta vicina dove c’era la chiesa romanica, e tutta questa sensazione di primavera rendeva nervosa l’anziana merciaia, che poi era nervosa anche perché lei aveva detto alla ragazzina alle quattro, e le quattro, a Milano, erano le quattro, non le quattro e tre quarti, così c’era quel signore che aspettava da quasi un’ora ed era venuto fuori due volte dal salottino, anziano, tutto calvo, gli occhiali grandi grandi, poi così alto che le clienti lo avevano notato subito e così le cose divenivano sempre più pericolose, per questo era nervosa, e il senso di nervoso, quel pomeriggio, era ancor più forte perché per due volte aveva visto passare l’Alfa della polizia e a lei la polizia non piaceva, non le piaceva neppure pensarci, aveva come la sensazione di fare il tiro alla fune coi poliziotti, ed era molto facile che vincessero loro, quelli della questura, data anche la stupidità di quelle ragazzine e servotte e mogli col marito disoccupato da mantenere che circolavano nel suo negozio e che credevano che lei quel lavoro lo facesse per hobby e che fosse un lavoro facile. «Grazie, signora», disse alla cliente puntigliosa dandole il resto del cinquemila lire e guardandola mentre usciva con un risolino interno che le alleviava un poco il nervoso, per quel pagliazzone di cappello che la vecchia aveva in testa, una specie di turbante rosa con avvolta intorno una striscia di visone giallino, così quella sembrava un assiro babilonese, e quando furono sole nel negozio vuoto, guardò la ragazzina, e con odio. «Ti avevo detto alle quattro. Sono quasi le cinque.» Sorrise sprezzante, le minorenni non le piacevano, erano merce esplosiva, saltava tutto in aria, se andava male, ma disgraziatamente rendevano il decuplo di una domestica o di una delle solite spostate che si rivolgevano a lei, aveva già in tasca lei quattro Cristofori Colombi, e altri quattro se ne sarebbe beccati la ragazzina, e un Michelangelo quell’alto vecchio signore con quegli occhiali così grandi avrebbe dovuto darglielo all’uscita per, diciamo, l’ospitalità. «Più aspettano, più si scaldano...» mormorò la ragazzina. Stava rigida, senza espressione, il viso non era per nulla infantile, come il suo corpo, che sembrava urgere, ai fianchi, al dietro, al petto sotto il paltò, eppure vi era qualche cosa di puerile in tutta lei, che aleggiava intorno a lei, qualche cosa, era difficile da spiegare, qualche cosa che sembrava tagliare, tagliare affilatissimamente, un coltello, ma era un coltello di plastica, per i bambini che non mangiano più sul seggiolone e che debbono tagliare il loro formaggino. Lei aveva qualche cosa di superficiale della donnaccia, per quello sguardo fisso impudente, per quelle labbra grosse, provocanti, anche se non dipinte, per quello stare rigida e sprezzante, per quella volgarissima risposta che aveva dato: più aspettano più si scaldano, eppure una persona sensibile avrebbe dovuto sentire che era una bambina. Ma la merciaia non era una persona sensibile. Le disse: «Qualche volta si stancano di aspettare e tu perdi la giornata». Le indicò la porta del retro: «Cerca di sbrigarti, alle cinque e mezzo al massimo ho bisogno della stanza». La ragazzina la fissò, il viso immobile, era, ecco, come una fotografia ferma, una foto in un album, e l’espressione era la sua solita: di sprezzo. Poi rigidamente, con qualche cosa che rammentava il meccanico muoversi di un soldato alla grande parata, aprì la porta in fondo al negozio ed entrò nel retro. Era uno stanzino con due scaffalature alte fino al soffitto piene di scatole di varie dimensioni, e altre scatole giacevano in terra, in disordine. Lei scavalcò il disseminio di scatole con la treccia che le ondeggiava sulle spalle e aprì la seconda porta. L’alto uomo, completamente calvo, i grandi occhiali, sembravano fari di auto, si volse, un bicchiere di vermut in mano, agitandolo per far sciogliere il cubetto di ghiaccio. «Bellissima...» disse. Aveva un grosso foruncolo sulla tempia, vicino all’orecchio destro, violaceo. «Bellissima. Chiudi la porta.» La voce era grave, da vecchio, ma da vecchio forte, virile. Lei chiuse la porta. Era acceso il grosso paralume giallo di falsa pergamena, con delle false stampe inglesi che rappresentavano falsi costumi del primo Ottocento, perché la stanza non aveva finestre, era sempre stato un ripostiglio, dove decenni prima avevano tenuto perfino il carbone per il riscaldamento con le stufe, ma che la nervosa merciaia aveva trasformato da alcuni anni in sua privata camera da letto, per lo meno così diceva. C’era infatti un divano dall’aria innocua ma che rapidamente diventava un grande letto, comodo, propizievole. Poi c’era un frigorifero che non sembrava un frigorifero, aveva l’aria di una vecchia madia, color legno scuro, e dentro un modesto bar, se si poteva chiamare bar: una bottiglia di vermut e una di coca cola. La coca cola era per le ragazze, e poi c’era un mangiadischi, le donne bevevano la coca cola e intanto buttavano il disco nel mangiadischi, e poi c’era anche un vaso di fiori, ma erano degli spaventosi fiori finti, spaventosi per la loro somiglianza coi fiori veri, bisognava proprio toccarli con le mani e sentirne la gommosa ributtevole consistenza per capire che erano fiori cadaveri. «Bellissima. Bellissima», l’uomo alto, quasi completamente calvo, e quei pochi capelli che aveva, rasi col rasoio, i grandi occhiali, molto, molto grandi dalla sottilissima montatura di metallo bianco, tenendo il bicchiere di vermut nella sinistra le fece una carezza sul capo mentre lei chiudeva a chiave la porta. «Bellissima.» Rigida, meccanica, lei sfuggì alla carezza, andò, pratica dell’ambiente, al tavolino dove c’era il mangiadischi, doveva essere straniero, pensava, rigida, in quella sua rigidissima espressione, diceva bellissima con le esse un poco fasulle, e prese dalla manciatina di dischi, rigidamente, un disco, il primo di quelli sparpagliati intorno al rosso mangiadischi e lo introdusse nella feritoia dell’apparecchio che l’ingoiò e subito sputò con la voce di Françoise Hardy: «Io capirti vorrei, farti felice vorrei...». «Bellissima», disse ancora la voce grave, vecchia, ma virile, alle sue spalle, e doveva essere proprio uno straniero, forse un americano, anche se parlava bene l’italiano. «Come ti chiami?» «Michela.» Gli voltava le spalle, ascoltando, molto vagamente, Françoise Hardy: «Io capirti vorrei, farti felice vorrei...». Levandosi il paltò sotto il quale aveva un abitino di color rosellino che aveva l’aria di un grembiule dell’asilo infantile, con quella lunga coda a treccia che le arrivava fino alle reni, copiata da Romina Power in quel film, e che cominciò a staccarsi, se no gliela sciupavano tutta. «Quanti anni hai?» La voce grave dell’uomo la raggiunse alle spalle, nonostante la sfrontatezza e l’impudenza, lei ne sentì come l’imperio. «Quindici.» La voce del vecchio alle sue spalle disse: «La signora ha detto ventimila per te». Le si era avvicinato, era proprio alle sue spalle, lei ne sentiva più che la vicinanza fisica il peso fisico, insieme con le parole di Françoise Hardy che «io capirti vorrei» e che «farti felice vorrei», ma se quello era straniero, lei per farlo felice voleva di più. «No», disse, meccanica, come una voce che uscisse da un microfono difettoso, «sono quarantamila», buttò la cifra proprio perché nella sua puerilità credeva che fosse straniero, «quarantamila», ripeté sempre voltandogli le spalle. E cambiando il disco, mise su il primo del mucchio di quelle vecchie schitarrate, ed era Cuore, e Rita Pavone cominciò a cantare: «Mio cuore, tu stai soffrendo», pianissimo, quasi bisbigliando, poi si mise a urlare con tutta la sua voce «sto vivendo così, sto vivendo così, i miei...». Non poté sentire il resto della frase perché l’uomo alto e vecchio e calvo e sempre col bicchiere in mano, aveva spento la musica. «È un poco caro, Michela», disse il vecchio, mettendole una mano sulla spalla, trafiggendola, attraverso gli enormi occhiali dal pur così sottile filamento di sostegno, «e poi non hai quindici anni», con la mano libera dal bicchiere raccolse la treccia finta che lei si era staccata dalla nuca, «al massimo ne hai quattordici, ma io penso che non ne hai molto più di tredici...» giocherellava con la treccia, doveva essere un pezzo di valore, erano capelli veri, morbidi, non plastica. «E poi sei sfortunata, bambina cara, o forse fortunata, io non sono un cliente, sono della squadra del Buon Costume, non aver paura, bambina cara, non ho niente contro di te, non ti farò niente.» Alzava, parlando, paternamente, tutte e due le mani proprio come un padre che si rivolge commosso ai suoi figli, perché infatti lui, il brigadiere quasi in pensione Giovanni Soltani, in quel momento, vedendo quella ragazza, che si doveva invece chiamare bambina, provava davvero, nonostante il suo duro mestiere, il suo ingrato, rasposo mestiere, verso quella infelice bambina, un senso paterno, e paternamente le ripeté: «Non ti farò niente, non è con te che l’abbiamo, ma con le persone che ti sfruttano», si accorse di essere un po’ ridicolo con quella lunga treccia in mano e la mise sul tavolino, sopra i dischi quarantacinque giri con le voci di Françoise Hardy, di Rita Pavone, di Dalida, di Nancy Sinatra, tutta robetta un po’ passata, e si tolse gli occhiali di cui non aveva bisogno ma che si era messo per recitare la sua parte di vecchio bavosetto alla ricerca di lolite. «Non ti facciamo niente, non ti mandiamo neppure dalle suore, ti lasciamo libera, solo se ci dici chi è che ti fa fare questo lavoro. Non diremo niente neppure ai giornalisti, non ci sarà nessuno scandalo, nessuno saprà il tuo nome, la tua famiglia non sarà immischiata, sei una ragazza intelligente, aiutaci e sarai liberata anche tu da quei disgraziati sfruttatori...». Lei lo guardava fissamente negli occhi, senza nessun timore, dal momento in cui lui le aveva rivelato di essere uno del Buon Costume. Poi abbassò lo sguardo e appoggiò la mano sul mangiadischi, in un gesto, così, come se stesse pensando, e spinse di nuovo il disco di Rita Pavone che lui, il falso cliente, un attimo prima aveva spento, nella feritoia, così che Rita Pavone riprese a cantare «a ogni lacrima, a ogni palpito», come, appunto, volesse ascoltare, quasi le piacesse molto, quella canzone, ma in realtà, mentre Rita cantava «Le mie prime felicità», e «per me, per me più pace non c’è», afferrò la maniglia del rosso mangiadischi. Tutti sanno che cosa è un mangiadischi, è una valigetta giradischi, ha una maniglia e macina dischi in qualunque posizione vogliate metterla, potete farlo suonare mentre andate a passeggio sul lungomare, o in ascensore, su un tavolo o appeso a un ramo di pioppo, e una volta impugnata la maniglia del mangiadischi, lei, Michela, ma era da vedersi se quello era proprio il suo nome, scagliò l’apparecchio con tutte le sue forze contro la grossa testa calva lucida del brigadiere Soltani, che ricevette il colpo in pieno e che vacillò, poi cadde in ginocchio mentre Rita Pavone, implacabile, dall’implacabile macchina, continuava a cantare «Sto vivendo così, i miei primi sorrisi», e ebbe un attimo di cecità, il brigadiere, in ginocchio, o al tappeto, come un pugile, e quando riaprì gli occhi vide la ragazzina che stava aprendo la porta per fuggire senza paltò, senza treccia. Allora si trascinò ancora stordito, carponi, per un metro, e riuscì ad afferrarla per una gamba. «No, ciccina, fa’ la brava...» aveva ripreso le forze e si levò in piedi prima che il calcio della ragazza lo raggiungesse sul viso già sanguinante, proprio dalla parte dove aveva il foruncolo. La ragazza adesso era distesa in terra perché aveva perso l’equilibrio nel dargli quel calcio, ma il vecchio brigadiere l’aiutò gentilmente ad alzarsi prendendole una mano. «Fa’ la brava, ti prego», le disse, «c’è una nostra macchina che passa per la via da tutta la mattina», era l’Alfa col lampeggiante azzurro che la merciaia aveva veduto, «non puoi fare niente per salvare il tuo amico, solo una cosa: dirci chi è e dove si trova.» Col fazzoletto, il vecchio, alto, calvo poliziotto, così diverso dai poliziotti che si vedevano nei film, si asciugò un poco il sangue che gli colava dalla ferita allo zigomo, perché in fondo un mangiadischi pesa almeno due chili e due chili in faccia tirati con tutta forza, anche se da una bambina, fanno male. Ma lei non disse come si chiamava il suo amico, né tanto meno dov’era, non disse neppure chi era lei, e non aveva nessun documento addosso, e nelle prime undici ore di interrogatorio, spezzate in tre tempi per non affaticarla troppo, non rispose a una delle diecine di domande che una serie di gentili poliziotti le fece: non a una. Non ascoltò neppure l’ausiliaria che cercava di convincerla a parlare, con suasive, sincere parole, fissò sfrontata il brigadiere Soltani e il suo foruncolo e i suoi cerotti sul colpo di mangiadischi che gli aveva inferto, mentre lui la minacciava di mandarla nel peggiore riformatorio esistente in Italia, una specie di Buchenwald per minorenni, se lei non avesse parlato, resistette perfino alle lusinghe del dottor Carfone, che le offrì da bere, dall’acqua minerale al whisky, che le mise davanti un pacchetto di Mercedes con l’accendino e che con quella sua bonaria parlata catanese le spiegava che, se il suo protettore non era proprio un criminale che avesse ammazzato della gente, se la sarebbe cavata con pochi mesi. «Se è un incensurato e se vi volete bene, guarda cosa ti dico, Michela...» spiegava bonario e catanese il dottor Carfone. «Non lo denuncio neppure alla magistratura, gli do una lavata di testa qui, perché, anche se non avete i soldi per sposarvi, non è un modo di farli quello di mandarti in giro per quel lavoro. Dimmi il nome del tuo fidanzato, sono sicuro che è come te: un po’ sbandato, ma non cattivo, e noi non ce l’abbiamo coi ragazzacci come voi, noi l’abbiamo coi veri delinquenti. Fuma, Michela.» Ma lei non fumò, e non parlò. Non rispose a una domanda, non bevette né acqua minerale, né whisky, resistette, il viso fermo, come quando cento anni fa si stava fermi davanti al fotografo, alle lusinghe della voce dolce del dottor Carfone e resisté anche alla violenza, più recitata che altro, del brigadiere Soltani, che alla nona ora di interrogatorio senza aver ricevuto una sola risposta, l’afferrò per i corti capelli alla nuca – la treccia era stata sequestrata, – la sollevò dalla sedia e le disse: «Parla, se no ti spezzo il collo». La lasciò subito, e lei comunque non parlò, non disse nulla, guardava sfrontata tutti, sfrontata e puerile, ma in due giorni di interrogatorio non una parola. Ah, no, ne disse quattro, cioè ripeté, durante i due giorni, per quattro volte, la stessa parola. Disse: «Gabinetto». Allora l’ausiliaria che le stava vicino la portava al gabinetto. Lo disse due volte il primo giorno d’interrogatorio, e due volte il secondo, quasi sempre alle stesse ore, era regolare. All’infuori di questa parola, oltre tutto ironicamente sprezzante verso i suoi inquisitori, non disse altro, né lì in Questura, né all’istituto dove la portavano a dormire. La merciaia invece sì, parlò, parlò per tre ore quasi di seguito, spiegò tutto: «...Perché, vede, non crederà mica che oggi si possa vivere con un negozio di merceria, con gli affitti e le tasse che si pagano, a vendere qualche etto di lana alla settimana, una sigaretta di filo bianco, il foulardino, mio marito è morto da tre anni, ho fatto più cambiali io che fischiate un merlo in primavera, e stavo per chiudere il negozio, quando un giorno viene un vecchio signore a comprare della lana verde per sua moglie, me lo ricordo ancora, voleva verde pastello, io avevo verde un po’ più scuro, e un momento dopo arriva una servetta che era stata già lì altre volte a fare delle piccole spese, che si capiva che era una di quelle, anche se serviva in una casa signorile, e questa volta dice che vuole un pullover celeste, i colori me li ricordo, e intanto che io cerco la lana verde pastello per il signore tiro fuori anche il pulloverino celeste per la ragazza, ma intanto il signore si era messo a fare lo spiritoso con la servetta, le diceva di prenderlo due o tre misure più stretto, così si vedeva la grazia della vita», la merciaia scuoteva il capo, la voce dolente, «... non lo so neppure io come è successo quella prima volta: è che quella svergognata andò nel retro a provarsi il pullover e il vecchio le andò dietro e io avevo diecimila lire in mano e quando uscirono dal retro era passato un mucchio di tempo ma la ragazza disse che il pullover andava benissimo e che lo teneva, e il signore lo pagò, e così è cominciato perché quella servaccia passò la voce alle sue colleghe, venivano a fare spesucce di continuo e quando c’era qualche uomo cominciavano a strusciarglisi intorno. Poi anche il signore della prima volta tornò a dirmi, chiaramente, se avevo qualche giovane, ne avrebbe voluta una rossa, i colori io li ricordo benissimo, e con tutte quelle serve che circolavano nel mio negozio da quella volta, le avevo anche verdi e lilla, e potevo dirgli di no?, da quella prima volta entravano ogni giorno in cassa tanti soldi che prima non li guadagnavo neppure in un anno. E dopo le serve vennero anche le loro padrone, sa, dottore, ci sono delle mogli che hanno il marito disoccupato, o che sono state piantate, devono vivere anche loro, qualche colpetto, se possono, ogni tanto lo fanno, poi ci sono le studentesse, sa, certe studentesse hanno i genitori poveri, in casa hanno solo da mangiare e da dormire, e allora, cosa vuole, in pochi mesi mi si è riempito il negozio, perché oltre tutto, tutta questa gente comprava, donne e uomini, e io alzavo anche i prezzi, tanto quelli non badavano, mille più, mille meno, io non sono fatta per questo mestiere, mia madre era professoressa di disegno, si figuri, ma sono una povera vedova, non ho nessun parente, ci sono cascata dentro così, per caso, anche perché ci sono troppe donnacce che fanno questo lavoro e troppi uomini sporcaccioni disposti a pagare qualsiasi cifra, la colpa non l’ho tutta io. Certe volte mi capitavano le ragazze in negozio quando c’era qualche cliente come si deve che veniva a fare spesa sul serio, allora ho dovuto avvertirle che, se arrivavano che c’era qualcuna di queste clienti, dovevano fingere di voler comprare qualche cosa, e chiedermi: “Bottoni di madreperla piccoli”, per esempio...» Parlò per quasi tre ore, dolente, quasi lacrimante, certo colpevole e sfruttatrice, ma non disgustosa; furba, perché capace di organizzare un abile commercio come quello, la ragazza entra in una merceria e chiede due bustine di aghi: non c’è nulla di sospetto; il vecchio è entrato un poco prima nella merceria, è andato a comprare la lana verde pastello per sua moglie: niente di sospetto. E poi c’è il retro, un’anticamera ingombra di scatole e di scaffali che fanno tanto onesto retro, ma al di là di una seconda porta c’è l’alcova. Se una serie di telefonate anonime non avesse avvisato la polizia, era difficile scoprire un giro simile. «Bene», disse il brigadiere Soltani, quasi alla fine della terza ora di confessione della disfatta merciaia, «adesso mi dica quello che sa di Michela.» Abbassò il capo. «Si ricordi che è minorenne e che lei lo sapeva. Sia buona e mi dica tutta la verità, perché quando sono in ballo minorenni non scherziamo.» Non sapeva niente. Nonostante lo schiaffone che si prese alla quinta volta che rispose che non sapeva niente, ripeté, lacrimando, che non sapeva nulla, nulla, proprio nulla, e doveva essere la verità. «...è venuta un giorno a comprare un paio di guanti di lana», disse piangendo dopo il violento schiaffone, «rossi, li voleva rossi, io ricordo i colori, ho sempre in mente i colori, e le ho detto che i guanti di lana non li tenevo, già fatti, ma che potevo farglieli fare e lei allora mi disse che l’aveva mandata un’amica, ma non mi disse il nome di questa amica, e che lei aveva bisogno di soldi e se io potevo aiutarla. Cosa dovevo fare? L’ho visto che era minorenne, altro che minorenne, avrei voluto buttarla fuori per la pena che mi faceva, ma se le trattavo male, quelle mi facevano le telefonate anonime in polizia, come hanno fatto, se no non sarei qui, e allora dissi che andava bene.» «Quanto tempo fa?» disse il brigadiere Soltani, con la mano sulla guancia per nascondere i cerotti e il foruncolo. «Ha cominciato a ottobre, faceva già freddo», disse la merciaia. «Non sai chi è, come si chiama, dove abita, niente, vero?» E di nuovo la mano, pronto a sbatterla contro il muro se avesse avuto la sensazione che lei mentiva, perché è vero che la legge dice di no, ma lui le ruffiane che vivono sulle povere disgraziate, sciagurate, pazze, come quella bambina lì, non le sopportava. «Non so niente, davvero», disse la donna ritraendo istintivamente il viso. E il brigadiere Soltani sentì che era sincera. Abbassò la mano che aveva minacciato di colpire, si rivolse all’agente in divisa che era sulla porta e gli disse: «Buttala nel cesso, e non farmela vedere più». Il dottor Carfone, dietro la scrivania, sorrise, quando l’agente ebbe portato via la vecchia sfruttatrice. Sorrisero anche i due agenti scelti che da due giorni interrogavano la ragazza e la merciaia. «Così non sappiamo niente di lei, neppure il nome, perché dice che si chiama Michela, ma potrebbe invece chiamarsi anche Vercingetorige, eroe, come tutti sanno, degli Alverni, nella ribellione della Gallia contro i Romani. E adesso, allora, come facciamo? Di solito è di un morto che non si sa chi è, ma di un vivo non era mai capitato. Insomma non siete riusciti a farla parlare, a sapere chi è, finora i giornalisti non sanno niente, ma a un certo punto dovrò raccontare la storia. Cosa racconto, che non so neppure chi è la ragazza?» Il brigadiere Soltani si coprì ancora la guancia incerottata con la mano. «Ci sono diversi mezzi per sapere chi è la ragazza e per farla parlare e per sapere chi è che l’ha spinta sulla strada.» Parlava con tono lieve, pur con quella voce grave che l’aveva fatto scambiare, alla ragazza, per un americano. «Una ragazza deve avere dei genitori, se non è un’orfana o trovatella, noi la teniamo sotto chiave e a un certo punto questi genitori che non la vedono più, la cercano e vengono in polizia e dicono: “Da diversi giorni nostra figlia non è tornata a casa!”, e allora noi sappiamo chi è!» «Può darsi che i genitori non ci siano, che sia orfana, trovatella», disse Carfone. «Certo. Allora si cercano tutti i minori che negli ultimi tempi sono fuggiti dagli orfanotrofi o dagli istituti dell’infanzia abbandonata. Cosa che ho già fatto fare, ma ci vorrà una settimana.» Il dottor Carfone fece una smorfia. «Mi dispiace, ma non posso tenere in cassetto questa storia per una settimana, i giornalisti non sono cretini, stanno già fuori della porta annusando qualche cosa. Occorre sbrigarsi, un sistema rapido, voglio sapere subito chi è la ragazza e chi è che l’ha messa in pista.» «C’è un sistema per saperlo in cinque minuti», disse il brigadiere Soltani, con la mano sulla guancia. Il dottor Carfone capì che scherzava e lo stuzzicò: «Tu in cinque minuti non sei capace di far parlare neppure un telegiornale». Ma il brigadiere Soltani smise di scherzare. «Nei film fanno le torture, le sigarette spente sulle ginocchia della giovane interrogata», parlava seriamente, quasi rabbioso, «queste sono scemenze da soggettisti, io non sono un soggettista, sono un vecchio disgraziato funzionario di polizia, ma entro una mezz’ora, se mi date ascolto, riusciamo a sapere chi è, da dove viene, chi la sfrutta e tutta la sua ascendenza e collateranza.» «Non ti arrabbiare, vecchio martire della polizia. Cosa dovremmo fare?» Il brigadiere Soltani si alzò, ed era davvero un poco troppo alto, un poco troppo vecchio, un poco troppo calvo e incerottato per essere un poliziotto, cioè era troppo vistoso. «Dovete aprire la gabbia, lasciarla andare, lasciarla fuggire», batté tutte e due le palme sulla scrivania, così vistoso con quei cerotti e quel foruncolo, «ascoltami, dottor Carfone, io la faccio fuggire, e lei fugge e ci porta diritta diritta al suo mascalzone o ai suoi mascalzoni», alzò la voce, benché parlasse a un suo superiore: «È una bambina, una bambina, l’hanno mascherata così, ma è una bambina, una bambina». Il dottor Carfone agitò un poco la mano destra per dirgli di calmarsi. Erano tutti e due molto vecchi di quel lavoro. Erano divenuti tutti seri, nel piccolo ufficio. Erano seri ed esperti, tecnici del Buon Costume da anni e anni e sentivano che quello che aveva detto il brigadiere Soltani poteva essere giusto. «Allora avanti», disse lentamente il dottor Carfone, «lasciala fuggire, ma, se ti scappa, fai una bella figura, chiudi proprio bene la tua carriera.» Neppure lui avrebbe fatto una bella figura, se quell’operazione falliva. «Ti porto a casa il mascalzone o i mascalzoni che hanno buttato quella bambina sulla strada, vivi o morti, anche senza la taglia di centomila.» L’agente Foscaro, un pisano, lavorava in questura solo da due anni, ma forse, oltre che la vocazione per il poliziotto, aveva anche quella per la recitazione. Fece la sua parte, usiamo le espressioni esatte: la interpretò, come un grande attore avrebbe potuto interpretare l’Amleto. L’agente Foscaro era quello incaricato, più autista che agente, di riportare la ragazza – Michela – dalla questura, dove diuturnamente veniva interrogata, all’ospizio di suore dove lei trascorreva la notte, e dove la prelevava al mattino per riportarla in questura, e disse la sua battuta come se l’avesse studiata sotto il più esigente dei registi: «Aspettami qui, torno subito». In fondo era una battuta breve, come «Essere o non essere», anzi, era anche di quattro parole come l’immortale battuta scespiriana, e lei, Michela, ammesso che si chiamasse così e non Vercingetorige, si fermò accanto a quello che ufficialmente era il suo secondino. Erano nel cortile della questura di Milano ed erano le ore dodici e venti di un solare venerdì, così raro a Milano un giorno solare, e l’agente Foscaro lasciò la ragazza sotto il porticato del cortile, la lasciò sola, libera, ed entrò, aprendo una porta sulla quale era un piccolo cartello con scritto: Provinciale I e Provinciale II (escluso Sardegna), mentre la ragazza restò lì, ad attenderlo. L’idea di fuggire, in lei, non era ancora nata, anzi, non vi aveva mai pensato, ma dopo un minuto, due di attesa, cominciò a sbocciare. Il cortile della questura di Milano è un cortile così tranquillo, specialmente se c’è il sole, escluso quando c’è qualche grossa retata e allora è pieno di furgoni, pieni a loro volta di gente di malaffare. E quando l’idea di fuggire fu sbocciata, lei capì che dal punto in cui era, dall’ufficio Provinciale I e Provinciale II (escluso Sardegna), all’uscita, sulla strada, alla libertà, non vi erano neppure dieci metri, e nessuna sorveglianza, escluso un agente che non poteva sapere che lei era una che fuggiva e che l’avrebbe scambiata per una delle tante che vanno a rinnovare il passaporto, e allora si allontanò dal colonnato in ombra, entrò nel sole del cortile, rientrò nel colonnato davanti all’uscita, e uscì sulla strada, guardando verso il semaforo all’incrocio. Nessuno la fermò, tutti gli agenti la videro, e ce n’erano parecchi, ma erano stati avvisati e la lasciarono andare, e appena fuori, appena s’incamminò, lentamente, verso il semaforo, anche due auto, molto normali, una Seicento e una Flaminia, s’incamminarono con lei, e anche due agenti a piedi, da una parte e dall’altra della bonaria strada milanese, s’incamminarono con lei, e dentro la Flaminia c’era il tenace, vecchio, calvo, incerottato e foruncoloso brigadiere Soltani. Ma lei non lo sapeva, lei credeva di essere fuggita, lei era una bambina, come aveva detto il brigadiere Soltani, lei pensava che adesso doveva correre da «lui». Se fosse stata veramente una donnaccia forse avrebbe sospettato il tranello, ma non lo era, era stata insozzata, ma non avvelenata di dentro, e così camminò piano, per non dare sospetto, fino a piazza Cavour, seguita, senza saperlo, da due auto e da due uomini, e arrivò al posteggio dei tassì, dove, come d’uso, non vi era un tassì, e attese, con la sua faccia ferma, di pietra, perché così le aveva insegnato «lui», di stare ferma col viso («devi sembrare una statua di cera, così piaci di più»), attese che arrivasse il tassì, spiata a pochi metri da un branco di poliziotti appostati nelle auto o vicino all’edicola dei giornali. E quando il tassì arrivò, salì, e disse: «Via Teodosio». L’autista mise in moto. «Che numero?» chiese. «Centotrentadue», lei disse. Anche se aveva il viso così statuario, aveva anche tanta paura, aveva resistito tutti quei giorni ai poliziotti, ma adesso era alla fine, respirava affannosamente e ciò che voleva era soltanto questo: che «lui» le dicesse di non aver paura, e che la stringesse forte. Proprio come aveva pensato il brigadiere Soltani. «Lui» aprì la porta, ma dopo molto tempo che lei ebbe suonato, la guardò, inquietamente, lei entrò subito e lui subito richiuse la porta e subito disse: «Dove sei stata?». Era piccolo e biondo, anche se aveva ventisei anni aveva l’aria di ragazzino, se non per lo sguardo, che facilmente s’incattiviva, e allora diveniva lupesco, minaccioso. E mentre faceva la domanda aveva già capito dove potesse essere stata. «Mi hanno pescata in merceria», lei disse, «il vecchio era un poliziotto che faceva finta di volere una ragazza.» Era così felice di rivederlo: da quando era nata, da quando era fuggita dall’orfanotrofio e lo aveva incontrato – lei riteneva, nella sua puerilità, che fosse stata una fortuna – era l’unico essere che – lei credeva – le avesse dato affetto, avesse sostituito la madre e il padre mai conosciuti, la famiglia mai avuta, le avesse dato la prima e sconvolgente sensazione di essere una donna, non più una bambina, e ricordava sempre quella mattinata di pioggia quando era fuggita dall’orfanotrofio e a cento metri dal colossale portone dell’edificio in cui aveva vissuto da un anno di età, il respiro strozzato dalla paura che la riprendessero, lui si era fermato con la sua piccola Bianchina nera davanti a lei e le aveva detto sporgendosi dal finestrino: «Signorina, non sta bene? Posso offrirle un passaggio?». Era la prima volta che la chiamavano «signorina», così era salita sulla Bianchina e lui l’aveva salvata, così almeno lei credeva. «Vieni qui, racconta bene», disse lui. Si sedette davanti al tavolo da disegno, perché studiava architettura, da qualche anno era sempre all’ultimo anno, però la laurea la voleva prendere, se quella ragazzina lavorava bene e non combinava guai, e fino ad allora era stata proprio brava. Un figlio di genitori separati come lui, che se n’erano sempre fregati di lui, non aveva molta scelta, no?, nei sistemi per laurearsi e farsi uno studio. «Ho fatto proprio come mi hai detto tu», lei disse buttandosi sulla poltroncina vicino a lui. «Non ho detto una parola, non sanno niente di noi, continuavano a fare domande e io non rispondevo.» Lui assentì, e quell’assenso lei lo prese per un elogio: era stato lui che le aveva insegnato, nel caso la polizia l’avesse presa, a non dire nulla, assolutamente nulla. «Va’ avanti», lui disse, così biondino, così ragazzino, ma con lo sguardo che gli stava divenendo, d’istante in istante, lucidamente lupesco e minaccioso. Lei andò avanti e raccontò, tutto, dal momento in cui, nel retro della merceria, quello schifoso vecchio le aveva detto che era un poliziotto, al momento in cui era fuggita. «Come, fuggita?...» disse lui, cominciò ad avere paura, molta paura e la paura incattiviva il suo sguardo. «Ero lì, nel cortile della questura», lei spiegò ingenua, «l’agente doveva riportarmi all’istituto delle suore e mi ha detto: “Aspettami qui, torno subito”, e io sono stata lì un po’, poi, siccome l’agente non tornava, sono uscita...» Sorrise, felice della sua fortuna, «...sono uscita tranquilla tranquilla, nessuno mi ha fermata...» Sorrideva come una bambina che gioca, ed era una bambina. Allora lui si alzò e la guardò con odio: sapeva che doveva accadere, non si può lavorare sulle donne senza che possa accadere, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe accaduto così stupidamente. E adesso era rovinato. Con voce torbida di furore disse: «Non sei fuggita, deficiente: ti hanno lasciata fuggire, ti hanno seguita e fra qualche minuto sono qui, per prendere me». Non occorsero minuti: aveva appena finito di dire quelle parole che il campanello suonò, era il brigadiere Soltani che lo suonava, coi suoi cerotti e il suo foruncolo. E due agenti erano ai lati della porta, per rinforzo. Il biondino andò alla porta. «Chi è?» «Polizia», disse il brigadiere Soltani. «Apri subito.» «Subito», disse il biondino. Andò al tavolo da disegno e nel cassetto cercò il compasso Kretcher. Il compasso Kretcher è il più grande e il più semplice, il braccio a punta ha la lunghezza di sedici centimetri e il suo arco di cerchio così grande serve in determinati lavori di planimetria. «Michela, vieni qui», le disse, ora quasi con dolcezza, l’afferrò alla vita, ma lievemente, e la condusse verso la porta. «Se vuoi salvarmi, lasciati tenere così. E adesso apri la porta.» Quando la porta si aprì, il brigadiere Soltani vide la ragazzina, e dietro quel biondino che la stringeva alla vita, e immaginò che lui avesse una rivoltella, ma il biondino disse invece rauco: «Ho in mano un compasso, se non mi lasci uscire l’infilo nella nuca di questa scema». Il brigadiere Soltani studiò un attimo lo sguardo lupesco, da vera bestia della giungla, del biondino, e disse subito: «Esci, ma non fare del male alla ragazza, se no ti massacro», e guardava gli occhi atterriti di quella bambina, punta alla nuca dalla punta di acciaio del compasso, e forse lei cominciava a intravedere la verità sull’uomo che lei amava. «Esci, bidone di spazzatura, esci!» urlò. Il biondino disse rauco: «Appena mi toccate, la ragazza parte». «Esci, schifezza», urlò il brigadiere Soltani. E il biondino uscì, cauto. Aveva previsto di essere pescato, e in questo caso sarebbe fuggito in Svizzera, e, se non poteva fuggire, piuttosto avrebbe fatto una strage. Uscì al riparo di quella bambina che sembrava una donna, un braccio intorno alla vita di lei e la micidiale punta del compasso Kretcher alla nuca di lei, tra i castani capelli di lei. Uscì cauto sul pianerottolo, sapendo che non vi erano molte speranze di fuga. Purtroppo uno degli altri due agenti lo toccò: aveva calcolato che avrebbe fatto in tempo ad afferrare la mano dell’uomo che teneva il compasso, e a strapparlo via dalla ragazza, ma il biondino era una bestia selvaggia, dai riflessi istantanei e, appena si sentì toccato, il biondino spinse la punta del compasso con tutta la sua forza, e la punta penetrò tra l’epistrofeo e l’atlante, nel vivo del cervello, e lei scivolò in terra fulminata: questa fu la sua sola fortuna, che non soffrì e non seppe neppure di morire. Morì semplicemente. Mentre i due agenti sistemavano il biondino, il brigadiere Soltani prese tra le braccia la ragazzina. «Non chiamare l’ambulanza», disse a un agente, «chiama il furgone dell’obitorio.» Cominciò a scendere le scale con quel corpo di bambina sulle braccia, pensando perché mai, perché mai, lui avesse scelto una volta, tanti anni prima, quel brutto mestiere di poliziotto. Perché mai. 97 · Troppo biondo Lei passeggiava su e giù per la stanza d’albergo, un su e in giù molto breve perché la stanza era poco più lunga del letto. «Vieni ad aiutarmi, se no non finiamo più», disse lui, davanti al piccolo tavolo coperto di lettere. Lei si mise la sigaretta tra le labbra e sedette al tavolo. C’erano più di un centinaio di lettere e ne prese una dal mucchio, l’aprì e cominciò a leggerla senza togliersi la sigaretta dalle labbra. «Lì ci sono i tre mucchietti», disse lui. Lei prese un’altra lettera e l’aprì, guardandolo un momento, perché una macchia di sole gli era arrivata sulla massa di capelli biondi e per un attimo sembrava averglieli incendiati. «Quello vicino al muro sono i sì, quello in mezzo i forse, e quello per ultimo i no», disse lui. «Lo so», disse lei. Buttò la sigaretta nel lavabo vicino al tavolo e aprì un’altra lettera: ...ho letto il vostro annunzio sul giornale. Ho 29 anni, vivo sola con la mamma, ho un buon impiego, unisco la fotografia..., guardò la foto, poveretta, non era poi brutta, ma sembrava avesse il gozzo, mise la lettera nel mucchietto dei no, e guardò ancora il suo biondone; non era un vero delinquente: metteva solo un annunzio «scopo matrimonio» sul giornale, poi si faceva prestare piccole somme dalle promesse spose e spariva; andava avanti da anni, non sapeva fare proprio niente altro; anche con lei aveva fatto così, poi l’aveva sposata, chi sa perché, e lei, seguendolo innamorata in quella miseranda vita d’albergo in albergo, di fuga in fuga, non riusciva a fargli fare altro, né a lasciarlo, era troppo biondo. 98 · Non gli serviva Vennero in quattro che era appena l’alba, facendo alzare prima il portinaio, poi lei, con quella suonata lunga che lei capì subito chi erano e certo non corse per andare a aprire e i quattro entrarono, non dissero neppure polizia, e uno rimase vicino alla porta, gli altri scoccarono per le tre stanzette. «Sorveglia il terrazzo, siamo solo al secondo piano», disse uno. Cercarono sotto il letto e il divano, dentro gli armadi, perfino fuori delle finestre, che lui non stesse attaccato a qualche cosa fuori, e, quando furono stanchi, le si misero davanti, a guardarla. «Cerchi di aiutarci, sposina», disse uno, «suo marito viene qui ogni tanto e quando non è qui lei sa dove è.» «Ma sono cinque anni», lei disse, «cinque anni che non lo vedo, e voi ogni tanto venite qui.» Sedette, rassegnata. «Guardi che non siamo stupidi», disse, sempre quello, «meglio che ci aiuti a trovarlo, se no finisce male.» «Ma con tutte le donne che ha, non viene certo da me, non si ricorderà neppure che esisto», lei disse, scuotendo il capo. «Non ci faccia perdere la pazienza, signora. Le altre stanno alla larga da suo marito, lei è la moglie.» «Lasciala stare, questa non parla», disse un altro. E se ne andarono, come le altre volte, torvi, senza crederle eppure aveva detto la verità, non lo vedeva da cinque anni; lo aveva aspettato, che venisse a chiederle aiuto, a nascondersi da lei, ne sarebbe stata tanto felice, servirgli a qualche cosa, ma lui non aveva mai bisogno di lei, la moglie, non gli serviva a niente, solo i poliziotti s’illudevano. 99 · Arancio sotto la pioggia Attraverso il tergivetro lui guardò: pioveva a barile sfondato, la ragazza, in prendisole arancio, stava sotto la pioggia e agitava disperatamente la mano. A lui non piaceva dare passaggi ma, a parte il fatto che gli sembrò che quella doveva essere una ragazza molto bella, lasciare una persona sulla strada di campagna non asfaltata, sotto tutta quella pioggia, chiunque fosse, donna o uomo, non gli sembrava accettabile. Fermò l’auto proprio davanti a lei, aprì la portiera, lei saltò dentro, fradicia, schizzando acqua da per tutto, colando acqua da tutte le parti, i lunghi capelli castano rossicci, spioventi fino a oltre il busto e gocciolanti anch’essi, sembrava proprio la gatta pescata nel fosso, e saltata dentro e richiusa la portiera sorrise, un poco nevroticamente. «Merci, monsieur», disse, «merci beaucoup.» E poi si mise a ridere, per un momento, forte. Ah, pensò lui, francese, e anche sbronza. Quella zona vicino al mare era piena di straniere che bevevano i vini dolci a canna e poi giravano come falene intorno agli uomini. Le disse in francese: «Dove posso accompagnarla, signorina?». Lei rispose: «Dove vuole, io non vado da nessuna parte. Lei parla molto bene il francese, signore». «Oh, è un complimento», lui disse. Non era un latin lover. Era un giovane maestro che passava le vacanze estive facendo l’assistente in una colonia marina per i figli dei dipendenti di una grande società milanese, così, senza spendere una lira, anzi, guadagnando qualche cosa, passava l’estate. Ma anche senza essere un latin lover, nessuno che meritasse il nome di uomo poteva lasciar perdere un’occasione simile. «Sta piovendo troppo forte, signorina, è meglio che ci fermiamo un momento sotto quegli alberi.» «Oui, monsieur, oui», e lei rise, nevroticamente, come prima. Appena fermata la macchina, lui la baciò. Doveva essere terribilmente sbronza perché ricambiò subito, e lo abbracciò forte, ma, d’improvviso, mentre la pioggia tambureggiava sul tetto dell’auto, lo allontanò da sé e cominciò ad ansare: «Non voglio morire, non voglio morire». E lui si allontanò un poco, senza comprendere bene, ma comprendendo che la ragazza stava parlando seriamente. «Perché dici che non vuoi morire?» le chiese. «Parce que», lei disse, e aveva già gli occhi chiusi e parlava faticosamente, «perché sto morendo. Ho preso sessanta pastiglie di valeriana, due tubetti interi, là, sotto la pioggia, non avevo acqua, bicchieri», parlava ormai come stesse delirando, e infatti delirava, «tenevo le pastiglie nel cavo delle mani, la pioggia riempiva subito il cavo delle mani, e mandavo giù, sai, è stato facile, sono pastiglie piccole ...comprends moi, mon petit... Il mio amico di Marsiglia mi ha lasciato, per andarsene con un’altra, mi ha portato via perfino tutti i soldi, e io volevo morire, anche perché l’estate è finita, piove, piove, piove, e io adoro il sole, il sole, ma adesso non voglio più morire, non voglio, mon petit, sauve moi, salvami, non voglio più morire...» L’ultima parola fu solo un sussurro, poi lei cadde nell’abisso dell’incoscienza. Lui riaccese subito il motore e schizzò via sotto il diluvio. C’era un ospedale a pochi chilometri da lì. «Mi dispiace», disse la direttrice della colonia, «ma sono costretta a fare a meno della sua collaborazione, subito, da questo momento. I dipendenti della nostra industria ci affidano i loro figli in questa colonia, perché sono sicuri della moralità di tutto il personale. Lei è stato su tutti i giornali, è stato interrogato per tre giorni dai carabinieri, non è ancora chiaro perché lei si trovasse in auto con quella francese, e quali legami vi fossero fra voi due.» Va bene, era licenziato, lui pensò, ma Monique era salva, l’ultima turista del litorale era viva, questo importava. Lui, comunque, non avrebbe più dato nessun passaggio, tanto meno a belle ragazze. 100 · La speranza La bambina aveva una vestina blu e un corpettino di lana bianco, aveva i capelli neri, corti, quasi un maschietto, la mamma la teneva per una mano, benché avesse già due grossi pacchi in braccio, perché la via era piena di gente, un carro armato passava in fondo, dov’era la piazza, finendo di rompere l’asfalto già rotto, squartato, anche dalle bombe degli ultimi mesi, e il rombo di ferraglia arrivava fin lì e allora le voci che gridavano: «Americane, a stecche, a pacchetti, sciolte», divenivano più acute, e la bambina seguiva la mamma, sbattendo contro lunghe ossute gambe di soldati inglesi in calzoni corti, contro nude gambe di ragazze e di donne, vedendo del mondo solo quel muoversi di calzoni e di gambe e di sottane o i pericolosi spigoli dei carretti, colmi di un coacervo di merci, dalle scatole di prosciutto, americane, alle giacche di ufficiali tedeschi, ai sacchi di fagioli, alle lunghe rivoltelle che forse avevano ancora un proiettile in canna, nel frastuono e nella polvere della rovente mattina di maggio più calda di un giorno d’agosto, mentre passava anche qualche auto coi partigiani dai colorati fazzoletti al collo distesi sul tetto della macchina, il mitra davanti a loro, finché la mamma non entrò in un negozio, sempre tenendo la bambina per mano, e, tenendola per mano, non attraversò la folla che cercava di comprare, e arrivò in un angolo meno ingombro facendola sedere su una cassetta vuota. «Sta’ buona qui», e le fece una carezza. Uno dei due giovanotti che servivano dietro il banco la vide, la conosceva, le sorrise: «Venga qui che la servo subito». E, quando lei ebbe un altro grosso pacco in mano, ed ebbe pagato, si volse verso l’angolo dove aveva lasciato la bambina e sembrò che tutto d’improvviso si fermasse, e il frastuono fosse spento di colpo, divenuto un silenzio vibrante e insopportabile, perché la bambina non c’era più, la cassetta era lì, ma la bambina non era più seduta sopra, come se non fosse mai stata seduta su quella cassetta, come fosse stata un’immaginazione di lei, la madre, che la bambina fosse stata lì, sulla cassetta. Coi suoi tre pacchi in braccio, lei non ebbe subito paura, anzi provò dispetto per l’ansia che la bambina le dava, ma erano trascorsi pochi istanti e doveva essere ancora lì; nel negozio, nascosta tra le tante persone: ma non c’era, e anche chiamandola, non rispondeva, e allora lei uscì per la strada, dove vi era ancora più gente, certa di avvistare subito il blu della vestina della piccola e il bianco del suo corpino di maglia, ma passavano invece dei soldati indiani dalle lunghe trecce nere e anzac dal cappellone con la tesa sinistra tutta all’in su, e ragazze vestite di abitini di stoffa autarchica dai colori stinti alla prima lavatura, e vecchie avide in slembi paltò da uomo, o vecchie stanche che si guardavano in giro inquiete, e anche se la bambina fosse stata lì vicino non avrebbe potuto vederla, né udirla per le urla di quelli dei carretti, e per il rombo delle jeep guidate da negri dalle lunghe mani, al disopra del quale lei inutilmente lanciava il suo richiamo, il nome della bambina. E ancora senza paura, ma già la paura stava nascendole dentro, gentile e come intimidita guardò una vecchia che stringeva in mano, avidamente, un lungo biglietto da cinquecento lire dell’AMG e le chiese se avesse visto una bambina dalla vestina blu e dal corpino di maglia bianco, e, mentre attendeva la riposta di quella che la fissava incomprensiva, la paura, il terrore, le esplosero dentro, aprì la bocca, aspirò forte, il cuore le forzò in gola, sentì appena la vecchia che diceva: «Io no», e cominciò, coi suoi tre grossi pacchi in mano, a risalire la corrente della folla gridando il nome della sua bambina, e poi urlando, e poi fermandosi impazzita, una leggera schiuma alle labbra, e poi riprendendo a correre, urtando ciecamente tutti, finché qualche persona non cominciò a cercare con lei, a dirle che non facesse così, dove poteva essere andata una bambina di pochi anni?, e la misero su una jeep della Military Police, coi suoi tre grossi pacchi e i tre alti poliziotti le sorridevano, che non piangesse, le avrebbero ritrovato la bambina e le fecero fare il giro di tutti gli isolati intorno, frugarono nei cortili, nelle botteghe, ma verso l’una, stordita dal whisky che le avevano dato da bere e dal suo pazzo terrore, tenuta da uno dei tre alti uomini, la portarono a casa, i grossi pacchi nelle braccia di un altro degli alti, e lui, il marito, il padre della piccola, le venne ad aprire ma non capì subito. «È stato dieci giorni fa», disse il tenente Anna, «la madre era andata a fare spese in quel mercatino vicino alla stazione», il giovane generale continuava a leggere i fogli che aveva davanti, ma lei sapeva che ascoltava ugualmente, «portava la bambina per mano perché non poteva lasciarla a casa sola, è entrata con lei in un negozio e dopo un attimo non l’ha vista più. La bambina deve essere uscita e si è perduta la tra gente. L’ha cercata, ma sono passati dieci giorni e non l’hanno trovata.» «Posso fare qualche cosa?» disse il giovane generale voltando uno dei fogli, senza smettere di leggere. «Sì, signor generale», disse il tenente Anna. «La Military Police alleata ha fatto delle ricerche, e anche la polizia e i carabinieri italiani, ma non c’è nessuna traccia della bambina. Il padre però ha saputo che la bambina è stata fatta salire su un camion militare americano, proprio quel giorno in cui è scomparsa.» Il giovane generale alzò il capo. «Allora devono seguire questa traccia.» «Non abbiamo più automezzi in questa città», disse il tenente Anna, «sono partiti già tutti, gli ultimi proprio il giorno in cui è scomparsa la bambina. Erano circa ottomila nella punta massima, adesso si sono dispersi nei vari reparti dell’Italia Settentrionale, alcuni sono andati anche in Austria.» In piedi davanti al modesto tavolino a cui lavorava il generale, il tenente Anna continuò: «Il padre della bambina dice che capisce che il Governo Militare Alleato non può interessarsi di queste cose, in tempi come questi, e anche la polizia italiana ha tanto da fare, ma che lui è sicuro che, se avesse l’elenco di tutti gli autisti degli automezzi americani, finirebbe per trovare quello che ha caricato la bambina sulla sua macchina». Il generale smise di leggere e si alzò. «Non capisco», disse. «Se un militare trova una bambina sperduta, la consegna al Comando, non credo che se la tenga a balia.» «Il padre», disse il tenente Anna, «dice che forse il GI non l’ha portata al Comando, che forse il militare spera di ritrovare da sé i genitori della bambina. O forse, ma questo non l’ha detto, ho solo capito che lo pensava, se la vuole portare in America.» Il generale alzò una spalla. «Anna, lei lo sa quante cose possono essere accadute a una bambina sperduta, di questi giorni.» «Io lo so», disse il tenente Anna, lo sapeva, pensava alla città in cui dilagavano truppe di ogni razza, tedeschi in fuga e disperati, vinti capaci di tutto dal terrore, in alcune città li rubavano i bambini e mai più venivano ritrovati. «Io lo so, ma il padre no. Lui vuole solo l’elenco degli autisti dei nostri mezzi, dice che poi le ricerche le fa lui, lui dice che la bambina non è morta, non è stata seviziata, se no avrebbe ritrovato il corpo. Lui dice che è viva, e vuole solo l’elenco. È là fuori che mi aspetta, non avrò mai il coraggio di dirgli che non possiamo fare niente.» «Ma io non ho questi elenchi», disse il giovane generale guardando in terra, «non abbiamo l’elenco di niente, lei lo sa meglio di me, dalla Piana di Catania a quassù non abbiamo avuto tempo di fare elenchi, non so neppure quanti carri armati abbiamo, so che ne abbiamo, ma non quanti e non so neppure precisamente dove sono, la guerra è finita, si smonta tutto e non si trova più niente.» «Gli elenchi sono a Washington», disse il tenente Anna. «Se lei li chiedesse gliene manderebbero una copia.» «L’elenco di tutti gli automezzi sbarcati in Italia?» disse il generale. «Sono decine e decine di migliaia, metà degli autisti è morta o è stata dislocata altrove, metà dell’altra metà non è mai passata per questa città: è una ricerca assurda, non gli basterebbe tutta la vita e infine non troverebbe nulla.» Con gli occhi, il tenente disse di sì, che lo sapeva, che era effettivamente così. «È l’unica cosa che gli rimane per vivere», disse però. «Crede di poter ritrovare la bambina e l’unica cosa che possiamo fare per lui è di dargli questi elenchi.» Il generale tornò a sedersi. «Mi scriva la lettera a Washington, richiedendo gli elenchi», disse riprendendo a leggere. «Grazie, signor generale», il tenente Anna salutò e uscì dalla stanza. In una delle piccole camere in fondo al corridoio c’era l’uomo, era giovane, molto, molto alto, stava in piedi vicino alla porta, gli occhi chiari, ingenui, la guardavano ingenuamente, la barba non era rasa da due o tre giorni ed era di un biondo più chiaro dei suoi capelli, ma non gli dava un aspetto triste o povero, anzi lo ringiovaniva ancora, così che anche i suoi occhi già così giovani sembravano ancora più giovani, e lei disse nel dolce, facile italiano che aveva imparato a Napoli: «Il generale ha concesso di darle la lista che desidera. Occorrerà del tempo, perché deve arrivare da Washington, ma la informerò appena arriverà». Non avrebbe mai creduto, l’uomo che la guardava con quegli occhi, che la sua bambina poteva essere morta, assolutamente mai. Fu la padrona della pensione che gli disse che quel signore seduto in fondo alla sala, nel posto più lontano dalla veranda, quasi non volesse vedere né il mare né la spiaggia, magro, piccolo, il viso rossastro non di sole, ma come intossicato da qualche bruciante malattia, era un ex colonnello della Wehrmacht, e ora celebre avvocato a Bonn, e che in tempo di guerra aveva combattuto in Italia, e allora lui guardò sua moglie, così giovane ancora, nel suo costume bianco sotto l’accappatoio celeste che metteva per venire a tavola, e i capelli grigi non le toglievano giovinezza, aggiungevano solo un altro fascino, e, guardandola coi suoi occhi chiari, senza parole, le disse di stare buona, perché sapeva lui quello che doveva fare. Ma vedeva dalle rughine che le si formavano intorno alla bocca che lei non credeva, non sperava, aveva terrore anzi di sperare, ma lui invincibile continuò a fissarla, per trasmetterle invece la sua forza, e qualche volta vi riusciva, ma non questa e fino a più tardi, quando la portò sulla spiaggia e fecero il bagno, le piccole rughe rimasero, ogni tanto vibranti per il disperato ricordo, così la sera dovette farle prendere il sonnifero e la lasciò solo quando la vide addormentata, davanti alla finestra e la finestra era davanti al mare, acceso, incandescente dalla luna piena e rossastra, poi discese nella sala da pranzo della pensione, davanti al mare, ma il colonnello Grote era a un tavolo in angolo, voltando le spalle alle grandi vetrate aperte della veranda e al mare oltre lo stradone, solo nella solitaria sala perché tutti erano usciti dopo il vorace pasto di cui erano rimasti gli aromi nell’aria e lui stava lì, davanti al fiaschetto di vino rosso e guardò l’alto, alto uomo dagli occhi chiari che gli si avvicinava accompagnato dalla padrona della pensione. Si alzò, quando la padrona della pensione glielo presentò, e chinò il capo coperto, appena appena, da grigi capelli tagliati a spazzola e disse, molto freddo, che aveva piacere di conoscerlo e che sarebbe stato felice, molto freddamente lo disse, di potergli essere utile, come gli aveva accennato la padrona della pensione. Lo invitò a sedere e lo guardò senza interesse, quell’uomo che, nonostante i capelli così grigi, sembrava tanto giovane, non s’interessava di uomini lui, ma di donne, erano la sua segreta malattia, veniva ogni estate su quelle spiagge latine non certo per rivedere i luoghi della guerra dove era stato, ma perché vi erano donne giovani, donne sapide, molto più sapide delle valkirie a cui si dedicava il resto dell’anno. Parlava l’italiano benissimo, come un italiano, lo comprendeva chiaramente, anche le sfumature dialettali e ascoltava senza fatica, solo senza interesse ciò che gli diceva quel giovane vecchio uomo dagli occhi chiari. Dunque, quell’uomo, quindici anni prima, così raccontava, aveva perduto una bambina, alla fine della guerra, la madre era andata a far spese e teneva la bambina per la mano, l’aveva lasciata solo un momento e non l’aveva più ritrovata. Il colonnello Grote accennò di sì, che seguiva il discorso, lo seguiva relativamente, aveva tempo fino a mezzanotte di seguirlo con tepido interesse, poi aveva una visita da fare, in un villino nella pineta, dove era atteso a quell’ora, ma erano appena passate le dieci e aveva tempo. L’uomo che gli parlava era il padre della bambina e gli disse che aveva fatto molte ricerche da allora. Aveva saputo che la bambina era stata presa a bordo di un automezzo americano e aveva scritto migliaia di lettere, così diceva, a tutti i guidatori di mezzi americani che erano passati per la sua città, ed era stato un lavoro durato anni e sembrava che tutti gli avessero risposto, anche i morti, attraverso le loro mogli, le sorelle, le madri, per dirgli che nessun John, o Fred o Bill, aveva preso una bambina in Italia, e tutti gli rispondevano così, ma lui aveva continuato a scrivere a quei Fred, a quei Jack, a quei Bob, aveva un grosso volume pieno di nomi che gli aveva dato il Governo Militare Alleato, c’era da scrivere lettere per tutta la vita. E l’uomo che gli parlava aveva davvero l’aspetto di uno che ha fatto una cosa simile e il colonnello Grote accennò ancora di sì, che seguiva il discorso, che era molto interessato, per un principio di compassione che provava verso di lui. E l’uomo gli disse, incidentalmente, un poco chiedendo scusa con lo sguardo, che sua moglie aveva tentato due volte di uccidersi per il dolore della bambina perduta e che ora, benché fossero passati tanti anni, sembrava volesse tentarlo ancora, di morire, e doveva continuamente sorvegliarla, perché non voleva mandarla in una clinica, ma lei era convinta che la bambina fosse morta e che la colpa fosse sua. Il colonnello Grote pensò che la moglie di quell’uomo aveva ragione di pensare che la bambina fosse morta, ma intanto oscure reminiscenze cominciarono a turbarlo, gli sembrava come avesse già udito una storia come quella, naturalmente c’era stato il caso del piccolo Lindbergh, ma non poteva essere quello a renderlo inquieto. E l’uomo che gli parlava gli disse allora che un giorno, uno di quei Fred, di quei Dick, di quei Joe, gli aveva risposto che lui certo non aveva mai preso una bambina in Italia, ma che aveva sentito dire che proprio in quella città c’era stato un ufficiale tedesco che era riuscito a fuggire con sua moglie mettendosi una divisa americana e con un camion sul quale aveva messo la bandiera americana, e grazie alla bambina che la donna teneva ostentatamente sulle ginocchia, il tedesco aveva attraversato il Nord Italia in festa per la Liberazione, le colonne dei partigiani che scendevano dalla montagna e i posti di blocco per arrivare in Svizzera. Questo, uno di quei Joe, aveva sentito dire da un suo compagno e gliel’aveva scritto. «Capisce?» disse l’uomo. Il colonnello Grote, che non aveva nessun aspetto marziale neppure in divisa, e ancora meno in quella camiciola gialla e coi calzoni corti neri, disse di no, che non capiva. «Io ero convinto che la mia bambina fosse stata presa da un americano», disse l’uomo che gli parlava, paziente, invincibile, «perché la donna che aveva veduto, da una finestra, la mia bambina, aveva veduto uno in divisa americana e una bandiera americana, ma in realtà si trattava di un soldato tedesco che fuggiva.» Il colonnello Grote non capiva ancora, ma disse che tutto era chiaro perché forse era chiara soltanto una cosa, che quell’uomo e sua moglie avevano perduto la ragione per la figlia scomparsa; la moglie in modo più naturale e umano, schiantata dal dolore, tentava soltanto di uccidersi, ogni tanto e una volta o l’altra sarebbe riuscita a morire. Lui no, il padre no, il padre viveva, in una ostinata invincibile speranza, che si appigliava a dei fili d’erba, a niente, per sostenersi. Quindici anni di ricerche, quindici anni di speranza inflessibile, la bambina se fosse stata viva avrebbe avuto quasi venti anni, ma quello credeva ancora. «Ora sento che è la strada giusta», disse l’uomo che gli parlava, invecchiato, ma infinitamente giovane per quella speranza che gli dava giovinezza. «Dalla nostra città, in quei giorni, non devono essere stati molti i tedeschi che sono riusciti a fuggire. Basterebbe sapere quali erano i tedeschi che si trovavano nella mia città in quei giorni in cui è scomparsa la mia bambina e poterli interrogare, se sono ancora vivi. Vede, colonnello, io credo di sapere come è successo», gli occhi chiari lo fissavano con dolcezza, con pazienza, e inflessibili nella loro speranza. «Le truppe tedesche sono rimaste accerchiate alla fine della guerra, nella mia città. Molti tentarono di scappare, inutilmente. Un ufficiale, con sua moglie, si mise un’uniforme americana, trovò un camion, una bandiera e tentò anche lui. Non sarebbe riuscito lo stesso, forse, ma trovò una bambina sperduta e pensò che con quella bambina bene in vista e salutando tutti avrebbe attraversato gli sbarramenti. E infatti deve esserci riuscito, colonnello Grote, deve essere arrivato in Svizzera e di lì in Germania, a casa, perché non è stato trovato nessun resto di bambina, nella mia città, in tanti anni, hanno dissepolto uomini e donne, ma erano tutti adulti. La mia bambina non è morta. Quella donna alla finestra, nella via dove la mia bambina è scomparsa, ha visto bene, un uomo in uniforme americana ha fatto salire la mia bambina sul camion, e quest’uomo una volta arrivato in Germania si sarà affezionato alla mia bambina e l’avrà tenuta. Capisce?» Oh, sì, adesso il colonnello Grote capiva, finalmente: si trattava di allucinazione. Quell’uomo si creava tutto un suo mondo di possibilità, s’inventava tutte le speranze per poter sopravvivere al suo dolore. Farlo ragionare, risvegliarlo, sarebbe stato impossibile. Una bambina perduta alla fine della guerra in un paese in cui dilagano gli eserciti vincitori e si dissolvono quelli dei vinti, marocchini e indiani abituati al diritto di preda, assetati di vendetta e disperati di terrore o fradici di alcool, e proiettili ancora vaganti e tutto il resto: la bambina era morta, ma non per lui. «Non vedo in quale modo possa esserle utile», disse il colonnello Grote, ormai erano le undici passate, poteva anche avviarsi verso il villino nella pineta, una sapida ragazza latina lo attendeva, la chiusura lampo del suo busto scorreva con un fruscio ardente che riudiva ogni tanto alle orecchie. «La padrona della pensione mi ha molto parlato di lei», spiegò l’invincibile, «lei è uno dei migliori avvocati della Germania Federale e risiede proprio a Bonn, nella capitale. Io desidero il suo aiuto, il suo patrocinio: lei potrà riuscire a sapere dagli archivi della Repubblica Federale, quali erano i militari tedeschi in Italia, nella mia città, in quei giorni. Sarà un lavoro lungo cercarli tutti, ma qualche cosa sapremo e alla fine troveremo quello che ha preso la mia bambina.» Il colonnello Grote si voltò finalmente verso il mare, oltre la vetrata della veranda e oltre lo stradone, ma solo perché si preparava ad andarsene, non per vedere il mare, la luna; non veniva lì su quelle spiagge per questo. «Avrei bisogno di riflettere un poco», disse vago, per vincere la compassione che, nonostante il fruscio della chiusura lampo che gli riecheggiava alle orecchie, aumentava dolcemente in lui. «Domani ne parleremo meglio, se potrò fare qualche cosa lo farò volentieri», disse. Non si alzò, per congedarlo, ma l’invincibile si alzò da solo, discreto e ragionevole nella sua allucinazione, lo ringraziò e se ne uscì dalla sala ancora odorosa di cibi, un poco meno diritto che quindici anni prima, ma sempre inflessibile. Fu in quello stesso istante, mentre lo guardava andarsene, che il colonnello sentì, non all’orecchio, ma come alla memoria, quel fruscio, che non era il fruscio della chiusura lampo del busto della morbida latina, ma un altro, molto uguale eppure ben diverso, oh, sì, il fruscio della chiusura lampo della borsa d’affari del giovane avvocato Wilhelm Hagger: molti, molti anni erano passati da quel fruscio, ecco perché prima aveva avuto quel senso di reminiscenza, senza però riuscire a ricordare, come ricordava ora. Il giovane avvocato Wilhelm aveva aperto la sua borsa di affari, ricordava, e la chiusura lampo aveva fatto un fruscio che ora aveva ricordato solo perché gli rammentava la chiusura lampo del busto di una ragazza, e ne aveva levato alcuni fogli e gli aveva detto che era venuto, rispettosamente, a chiedere consiglio al grande avvocato Grote, a lui, per un suo cliente, o meglio un suo caro amico. «Siediti bambino», gli aveva detto lui, Wilhelm era troppo giovane per fare l’avvocato, specialmente in quel periodo, a Norimberga gli alleati impiccavano alacremente, ma senza nessun risultato, i capi nazisti, e a Berlino una ragazza tedesca valeva meno di un pacchetto di sigarette, non era epoca per gli avvocati giovani e idealisti. Il bambino avvocato si era seduto e aveva raccontato. Aveva detto che alla fine della guerra un ufficiale della Wehrmacht, il suo cliente, si trovava in Italia con sua moglie e aveva tentato di fuggire. Era in una piccola città italiana invasa dalle truppe alleate, sommersa, e non aveva molte speranze di riuscire. Ma sua moglie gli aveva trovata una divisa americana e una mattina gli disse di attenderla vicino a un certo mercatino, dove lei sarebbe arrivata con un camion. L’ufficiale aveva atteso, in quella calda mattina di maggio, nella divisa americana, la mano nella tasca dei calzoni con la Luger carica e senza sicura, pronto a sparare al primo anzac o al primo MP che avesse capito la mascherata, e coi nervi che gli bruciavano in quell’attendere senza speranza tra indiani barbuti e marocchini dagli occhi incandescenti che gli sorridevano, aveva visto una bambina che gli si era appesa ai calzoni e che diceva mamma, mamma, che in italiano voleva dire Mutter, e allora l’aveva presa istintivamente in braccio, solo poi pensando che con quella bambina sarebbe stato meno in pericolo, non potevano sospettare di un soldato americano con una piccola in braccio: o forse lo era di più? Poteva arrivare da un momento all’altro la madre, e, tenendola in braccio, teneva ancora la mano sulla Luger nella tasca dei calzoni, non si sarebbe fatto prendere vivo, ed ecco che un momento dopo era arrivato un Dodge guidato da un negro e vicino c’era sua moglie che gli faceva cenno di saltare su e lui aveva visto che si avvicinavano due MP inglesi e allora era saltato su con la bambina in braccio: se l’avesse lasciata a terra, gli MP si sarebbero insospettiti e avrebbero inseguito il camion, ottenuto dal soldato negro a un prezzo facilmente immaginabile e pagato da sua moglie, era ovvio. E poi non l’avevano lasciata più giù, la bambina, perché serviva molto: le facce dei partigiani col mitra, lungo il viaggio fino in Svizzera – il negro li aveva abbandonati all’uscita della città – si schiarivano a vedere la bambina, salutavano con le due dita a V e toglievano gli sbarramenti, e la bambina, e la bandiera americana e le stecche di sigarette che sua moglie tirava fuori, omaggio galante del suo negro, gli avevano fatto raggiungere la Svizzera, dove aveva detto che la bambina era sua, e poi la Germania, dove aveva continuato a dire che la bambina era sua, e adesso, dopo due anni, per lui era divenuta sua, di lui e di sua moglie, parlava tedesco e l’unico terrore che avevano, lui e sua moglie, era che i genitori veri venissero a prendersela. Per questo avevano chiesto l’aiuto del loro amico, l’avvocato bambino Wilhelm Hagger, per sapere che cosa potevano fare per nascondere per sempre la bambina che li aveva salvati e che era divenuta la loro figlia, perché nessuno sapesse mai che non era la loro vera figlia. Ma l’avvocato bambino non era specializzato in tali questioni ed era venuto a chiedere consiglio a lui, il grande avvocato Grote, colonnello della Wehrmacht. E lui, il colonnello, l’ex colonnello, cioè, della ex Wehrmacht, aveva sorriso guardando i potenti, telescopici occhiali del giovane avvocato Wilhelm. «Niente», gli aveva detto, scuotendo il capo di fronte a quell’ingenuità. «Niente, devi fare, e niente devono fare i tuoi amici che hanno la bambina. Assolutamente niente. Ci sono migliaia di bambini sperduti, oggi, e milioni di adulti, sperduti, tutti abbiamo perso qualcuno, io ho perso mia sorella, dov’è mia sorella?, boh, se fosse stata giovane, potrei pensare che è stata delibata da qualche cosacco, ma era brutta e vecchia, boh. Di’ ai tuoi amici di stare tranquilli, dopo una guerra simile non si ritrova niente e nessuno.» Così aveva detto quel giorno all’avvocato bambino, e poi aveva dimenticato la storia, e se non ci fosse stato il fruscio della chiusura lampo di un busto di donna, che rassomigliava tanto al fruscio della chiusura lampo di una borsa, non avrebbe ricordato, mai, più niente. E invece si era ricordato, pensò alzandosi per andare – era lì vicino – nel villino verso la pineta dove una ragazza si stava preparando per lui. Uscì, attraversò lo stradone, la luna non era più rossastra ma bianca, tutto era bianco, il mare, la spiaggia, la pineta alle sue spalle. Guardò un momento; senza vedere, perché non gli era mai interessato nulla di quelle cose, il mare, la luna, i bambini, gli piaceva la guerra, quando c’era, quello sfondare col ferro e col fuoco tutte le resistenze del nemico; e gli piacevano le donne, la morbidezza di tutto il loro essere, del loro vestire; il resto dell’esistenza non lo attraeva, era una falsità o un’inutilità. Ma attraversato lo stradone, arrivato dove cominciava la sabbia e più in là il mare si fermò, irrigidito da un pensiero. L’uomo dagli occhi chiari aveva ragione. Sua figlia era viva, come lui aveva creduto e credeva ancora per anni e anni: era quella bambina presa dall’ufficiale tedesco e divenuta ora donna. Quell’uomo non era certo un allucinato, non delirava: quell’uomo sperava, sapeva sperare, e aveva ragione di sperare. E ora lui, il colonnello Grote, doveva correre a dirgli che sua figlia era viva e che lui sapeva dove era, bastava domandarlo a Wilhelm. Ma c’era anche quell’altro, quel tedesco che da quindici anni se l’era tenuta come figlia, che aveva vissuto nell’ansia che gliela venissero a riprendere i veri genitori. Era un problema troppo difficile per lui, e che non lo interessava troppo. Aveva la sensazione abbastanza precisa di commettere un delitto, ma voltò le spalle al mare, riattraversò lo stradone e si diresse verso la pineta. Non avrebbe detto niente a quell’uomo, né a nessuno, avrebbe fatto come se non avesse ricordato, né saputo mai nulla. Ormai a che serviva? Ma gli occhi chiari di quell’uomo, mentre s’inoltrava nella pineta, lo turbavano. Forse non serviva a nulla, la bambina era divenuta donna, credeva di essere figlia di quei due che l’avevano cresciuta, ma quell’uomo, la sua invincibile speranza, avevano avuto ragione, aveva ragione. Lui, il colonnello Grote, non gli avrebbe mai detto la verità, gli avrebbe detto gentilmente, freddamente, di non potersi interessare del suo caso, avrebbe tentato di convincerlo che non doveva più sperare che sua figlia fosse ancora viva – e non lo avrebbe mai convinto – ma quell’uomo aveva ragione, e lui, il colonnello Grote, tacendo, commetteva un delitto. Era arrivato davanti alla villetta e suonò il campanello, due volte, come aveva detto alla ragazza. Non gli interessava, se era un delitto, erano poche le cose della vita che lo interessavano e quando la ragazza dischiuse la porta, già nella vestaglia trasparente, dimenticò subito tutto, e per sempre, anche se sapeva che l’altro avrebbe continuato a sperare – e non inutilmente – per sempre. I COMMENTI DEGLI SCRITTORI «Con i libri è come con le persone, ne incontri una in un momento particolare e la tua vita cambia, e anche se poi ne incontri di più belle, di quella, di quella persona lì, te ne ricordi sempre. A me è successo con un libro di Giorgio Scerbanenco.» Carlo Lucarelli «I libri di Scerbanenco per noi giallisti, pulp, cannibali, noiristi e vattelapesca, sono vivi vividi e lividi come certe mattinate cittadine… E, a proposito, Giorgio, se ho la fortuna di scrivere, grazie di tutto. Anche se non ci siamo mai visti ci siamo conosciuti.» Andrea G. Pinketts «Il realismo di Scerbanenco che anatomizza la vecchia Italia ormai morta è prezioso per noi, tanto più che è un realismo, come dire, involontario.» Carmen Covito «Scerbanenco fa di tutto per impedire al suo pubblico di distrarsi, costi quel che costi. Tanto che i suoi romanzi possono essere a pieno titolo considerati come uno dei primi esempi italiani di scrittura televisiva.» Gianni Canova «Scerbanenco sapeva ricostruire, con poche, luminose pennellate, gli animi torbidi... i meccanismi imperfetti che portano una persona a compiere, un atto dopo l’altro, quasi senza pensarci, un crimine.» Piero Colaprico Document Outline Presentazione Introduzione 1 · L’agonizzatoio 2 · L’Uomo Forte 3 · Grazie, professore 4 · Solo da ieri 5 · Sapendo di mentire 6 · Nudo, no 7 · Il delitto non rende 8 · Meglio non licenziarle 9 · La cartella di Longadà 10 · Fine del viaggio 11 · Safari a Milano 12 · Non ti spaventare 13 · Il ricatto 14 · Non si sarebbe sentito 15 · La prova indiziaria 16 · Scuola serale 17 · Domani, forse 18 · Sempre la stessa storia 19 · La prima e l’ultima 20 · Le chiacchiere 21 · Di professione farabutto 22 · Qualcuno non si diverte 23 · Intanto va’ dentro 24 · La strega 25 · Zampa di Giaguaro e Nuvola Rosa 26 · Come i gatti 27 · La moglie innocentista 28 · La rabbia e la vita 29 · Peccato normale 30 · La schiava 31 · L’ultimo regalo 32 · Trecento milioni 33 · Verso mezzanotte 34 · Un alibi d’acciaio 35 · Quei manifesti, e basta 36 · Un poliziotto, una bambina, un capretto 37 · È evidente 38 · La vittoria 39 · Nessuno deve ridere 40 · Notte di distruzione 41 · Troppo tardi 42 · Un attimo di nostalgia 43 · Sulla riva del fiume 44 · Quando si ha un cane 45 · Il bambino che non dormiva 46 · Quasi due metri 47 · Villa della disperazione 48 · Come in un balletto 49 · L’indomabile 50 · Rififi per promessi sposi 51 · Pericolo di vita 52 · La fuga inutile 53 · Redimere un tigre 54 · Aspettando il Supremo 55 · L’ostaggio 56 · La spirale 57 · La confessione 58 · Poi il silenzio 59 · Appena gliel’ho detto 60 · L’infermiera inamovibile 61 · L’uomo che non voleva morire 62 · Un cappello di paglia rosso 63 · Infatti nessuno lo credette 64 · L’angelo 65 · Non per cattiveria 66 · La ragazza calibro 22 67 · Gliela lasciarono baciare 68 · Il marito dell’amazzone 69 · Con la musica è bello 70 · Oltre la morte 71 · La signora ha freddo 72 · Il vecchio c’è riuscito 73 · Una notte di luna 74 · In ricordo di Ulisse 75 · Le donne non sanno aspettare 76 · Pesca alle anguille 77 · Il nome mai 78 · Non sembrava proprio 79 · Il caldo 80 · Una vera amicizia 81 · La figlia del giudice 82 · Il sapore della vendetta 83 · Pagherò 84 · Dopo le dieci 85 · Dio vede e provvede 86 · Le arpe e il commissario 87 · Le solite rogne 88 · Carabiniere con febbre 89 · Le boutique fantastiche 90 · Il rastrellamento 91 · Doppio gioco 92 · L’innamorato che non si ferma 93 · Il più bel ragazzo del mondo 94 · Il rossetto sommerso 95 · Una vedova giovane 96 · Lolite si muore 97 · Troppo biondo 98 · Non gli serviva 99 · Arancio sotto la pioggia 100 · La speranza Sommario