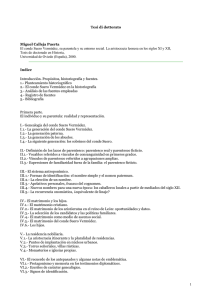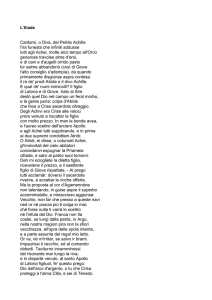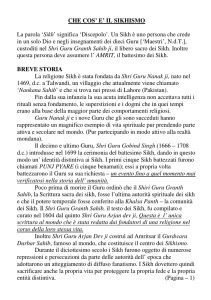La religione dei Romani
Anuncio

Domenico Chillemi • Maria Chiarello LINGUA COMMUNIS Lingua e civiltà latine La religione dei Romani percorso di civiltà 2 Indice LA RELIGIONE DEI ROMANI La religione delle origini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La nascita del pantheon romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Triade capitolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I culti stranieri e la crisi della religione romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 6 LEGGIAMO I TESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Le istituzioni religiose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Il collegio dei flamini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Il flamen Dialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 LEGGIAMO I TESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Il collegio dei pontefici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Il collegio delle vestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Il collegio degli auguri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gli aruspici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Il sodalizio dei salii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Il sodalizio degli arvali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Le festività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 I saturnalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 LEGGIAMO I TESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 I lupercalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 LEGGIAMO I TESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 I lemuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani LA RELIGIONE DEI ROMANI La religione delle origini I Romani consideravano la religione una sorta di dovere morale e civile di ogni cittadino e non intraprendevano nulla di importante per sé e per lo stato, se non dopo aver ottenuto l’approvazione degli dei, nella convinzione che qualunque azione umana, senza il loro favore, fosse destinata al fallimento. Il sentimento religioso, però, non si basava su un rapporto spirituale con la divinità, ma piuttosto sull’adempimento di una serie di atti di culto (alcuni di carattere privato, gestiti dal pater familias, altri pubblici) ai quali ogni cittadino era tenuto a partecipare per il bene della città. I Romani si definivano “homines religiosissimi”, e “homo pius” era colui che aveva rispetto per il sacro e adempiva con scrupolo tutte le prescrizioni rituali. La pratica religiosa costituiva dunque un aspetto inscindibile dalla vita dei Romani sia nella vita privata sia in quella politica e sociale. In origine la religione dei Romani era quella di un popolo semplice di pastori e di agricoltori: ciascuno desiderava sicurezza e protezione per sé, per la famiglia, per gli animali e per i campi. Questa religiosità era dunque legata principalmente all’ambito agreste ed era caratterizzata da un sentimento di timore: i Romani, cioè, avvertivano intorno a sé, nella quotidianità della vita, la presenza di forze misteriose (numĭna,“volontà”), che condizionavano ogni aspetto dell’agire dell’individuo e della comunità. Di fronte alle molteplici manifestazioni di queste forze insite nella natura, si sentivano fragili, impotenti: temevano per sé, per le loro famiglie, per i raccolti, per il bestiame. Come rimedio a questo sentimento di angoscia e per esorcizzare e rendere benigne quelle presenze, ricorrevano a cerimonie agricole e pastorali intese ad allontanare gli spiriti avversi e a propiziare quelli benevoli. Questi e altri riti della più antica religione romana, raccolti poi, secondo la tradizione, dal re Numa Pompilio e conservati negli archivi dei pontefici, costituirono un rituale che prese il nome di indigitamenta (da indigitare, “invocare”). In essi sono contenuti i nomi e gli attributi delle divinità, le formule, le preghiere, le litanie e le indicazioni per le offerte di sacrifici. Nelle formule rientravano lunghi elenchi di numi che presiedevano a ogni fase della vita umana (nascita, infanzia, adolescenza, matrimonio, morte) e alle varie attività umane. Dai riti praticati secondo le prescrizioni contenute negli indigitamenta ricaviamo che la religione dei Romani nel periodo più antico ebbe un’impronta decisamente animistica e contrattualistica, basata, cioè, sul do ut des: si credeva che tutte le cose fossero animate da principi vitali benefici e malefici e che fosse necessario propiziarseli con atti di culto. Solo in questo modo si potevano ottenere il loro favore e la loro protezione. Così i Lari e i Penati proteggevano la famiglia e i campi, specifici numi vegliavano sulla famiglia, sulla città, sulle varie attività. Bassorilievo con scena di vita agreste: la religione romana delle origini era quella di un popolo di pastori e agricoltori. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 3 4 la religione dei romani Questi esseri divini non erano ancora concepiti con aspetto antropomorfico, non venivano rappresentati in sculture o pitture, non avevano templi, ma tutto ciò avvenne solo in seguito. La tradizione attribuisce al re Numa Pompilio (come si accennava sopra) le prime istituzioni religiose, l’organizzazione di culti e cerimonie, l’istituzione dei primi collegi sacerdotali (tra cui il più importante, quello dei pontefici) e le prime costruzioni di edifici dedicati al culto degli dei. Bassorilievo che ritrae un sacrificio in onore di Marte. La nascita del pantheon romano Intorno al VI secolo a.C., in seguito ai contatti con il mondo etrusco prima e con i Greci delle colonie dell’Italia meridionale poi, i Romani cominciarono ad aggiungere alle divinità patrie quelle dei popoli conquistati, indotti forse da scrupoli religiosi o più probabilmente consigliati da opportunità politiche. Lo storico Tito Livio racconta che, quando i Romani ponevano l’assedio a una città, il comandante ordinava al feziale (araldo sacro) di invitare (evocatio) gli dei a uscire e a passare dalla parte di Roma, dove avrebbero avuto templi, culti e onori maggiori. Essi ritenevano, infatti, che sarebbe stato atto di empietà far prigionieri anche gli dei. Così la religione primitiva si avviò verso una lenta trasformazione, che portò all’assorbimento di nuove divinità e all’elaborazione di un calendario per le festività. Le nuove divinità del mondo etrusco e greco vennero identificate con quelle romane e rappresentate con aspetto antropomorfico. In questa trasformazione del culto e della religione, un ruolo importante ebbero i libri Sibillini di origine greco-etrusca, legati al culto di Apollo, che contenevano gli oracoli della Sibilla cumana. Acquistati dal re Tarquinio Prisco, i libri Sibillini erano venerati e consultati in occasione di decisioni importanti o di grandi calamità. Intorno alla metà del III secolo a.C., con l’espansione in Oriente, quasi tutto l’apparato mitologico greco venne assorbito e identificato con le divinità romane. Nella religione romana, comunque, le divinità rimasero distinte in due grandi categorie: di indigĕtes, le divinità più antiche, gli dei originari dello stato romano, venerati con feste speciali. La tradizione ne ricorda circa settecento: Cerere, Fauno, Giano, Saturno, Silvano, Pomona, Conso, Egeria, Carmenta, Copia, Opi, Fama, Muta e così via; di novensĭdes, divinità straniere, i cui culti vennero introdotti nella città in periodi storici successivi. Divinità di origine italica sono Giove, Marte, Quirino; quelle di origine etrusca Minerva, Venere (Turan). Numerose furono, poi, le divinità di origine greca identificate con nome romano: Zeus / Giove, Cronos / Saturno, Apollo-Febo / Apollo, Poseidone / Nettuno, Ares / Marte, Ermes / Mercurio, Efesto / Vulcano, Ade / Plutone, Era / Giunone, Atena / Minerva, Afrodite / Venere, Estia / Vesta, Artemide / Diana, Demetra / Cerere, Persefone / Proserpina. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani La Triade capitolina L’espressione è stata coniata dalla storiografia del XIX secolo per indicare le tre divinità più importanti del pantheon romano: Giove, Giunone, Minerva. A loro, già in epoca arcaica, i Romani innalzarono un tempio sul Campidoglio, luogo un tempo ricoperto di querce, pianta sacra a Giove, come racconta Virgilio. Il tempio era fornito di tre celle, nelle quali erano poste le statue delle divinità: al centro Giove, assiso sul trono e con i temibili fulmini, alla sua destra Minerva, alla sua sinistra Giunone. Scultura in marmo che raffigura la Triade capitolina. Giove, divinità suprema, “padre degli dei e degli uomini”, identificato con il greco Zeus, in origine era la divinità che presiedeva ai fenomeni atmosferici, perciò era detto “Pluvius” o “Fulgurator”. In seguito gli furono attribuiti altri appellativi, come quello di “Feretrius” (colui che abbatte i nemici) e di “Stator” (colui che trattiene dalla fuga). Con quest’ultimo appellativo i Romani gli dedicarono un tempio ai piedi del Palatino, dove più tardi sorgerà l’arco di Tito. Ma tra i tanti appellativi che qualificano la sua figura, il più importante è quello di “Optimus Maximus”: così era invocato durante i riti che si svolgevano sul Campidoglio. Qui, prima di partire per la guerra, andavano i consoli per pregare e offrire sacrifici; qui ritornavano vittoriosi, tra due fila di popolo in festa, per deporre la corona trionfale. Il culto di Giove era affidato esclusivamente al flamen Dialis (vedi infra), un sacerdote che godeva di particolari privilegi, creato, secondo la tradizione, da Numa Pompilio. In onore di Giove Optimus Maximus, nume tutelare dello stato romano e garante dei patti e dei giuramenti, i Romani istituirono i Ludi Magni (o Romani), che si svolgevano con grande parTesta di Giove in marmo. tecipazione e solennità dal 4 al 19 settembre. Giunone, sposa e sorella di Giove (entrambi erano stati generati da Saturno e Rea), in origine era la dea del cielo notturno e della luna che lo illumina. Identificata con la greca Era, al pari dello sposo godeva del titolo di “regina” degli dei; compare, infatti, nel suo nome Iu-no, la stessa radice di Iu-piter. La tradizione mitologica la presenta come divinità bella, fedele, ma gelosa, vendicativa e spesso aggressiva nei confronti di Giove, che era infedele e sempre alla ricerca di nuove avventure amorose. A Roma era onorata come protettrice delle matrone e della vita coniugale. In suo onore si celebravano le feriae Matronales (o semplicemente Matronales), festività che ricorreva il primo marzo (considerato, in antico, il primo mese dell’anno). In quel giorno le donne romane si recavano nel tempio di Giunone situato sull’Esquilino, dove portavano incenso e fiori che deponevano sul suo altare, pregavano e facevano voti. La festa era celebrata con eccezionale solennità: gli uomini facevano doni alle mogli e alle madri; piena libertà era concessa alle persone di condizione servile, per le quali le matrone stesse preparavano e servivano il banchetto. In quell’occasione Giunone era invocata con l’appellativo di “Lucina”: era lei, infatti, che presiedeva ai parti e sotto la sua protezione le partorienti mettevano i figlioletti appena dati alla luce. Vi erano ancora altri appellativi con i quali Giunone era venerata, come quello di “Pronuba” e di “Moneta”. Giunone Pronuba era invocata come divinità protettrice e di buon augurio per le spose e pronuba era detta la matrona che assisteva e accompagnava la sposa alle nozze. Giunone Moneta (da moneo, “ammo- D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 5 6 la religione dei romani nisco, avverto”) era la protettrice dello stato romano ed era chiamata così in ricordo dei buoni consigli che la dea aveva dato ai Romani in molteplici circostanze. Era stata lei, infatti, a salvare Roma al tempo dell’invasione dei Galli di Brenno (390 a.C.), allorché le oche sacre alla dea, che venivano allevate nel recinto del tempio in Campidoglio, con il loro starnazzare avevano dato l’allarme. Nel 375 a.C. le fu innalzato un tempio dove oggi sorge la chiesa dell’Aracoeli. Minerva è senza dubbio una delle divinità più popolari e importanti del pantheon romano. In origine divinità dell’Etruria protettrice delle attività artigianali, poi accolta a Roma e quindi assimilata alla greca Atena, divenne ben presto oggetto di culto in tutti i maggiori centri dell’area mediterranea. Minerva era la potente divinità delle battaglie, bella, saggia, forte più dello stesso Marte. Lei, infatti, invocavano i soldati nelle cruente battaglie; a lei si rivolgevano i comandanti per chiedere consiglio, perché era esperta nelle strategie di guerra. I Romani la onorarono innalzandole a Roma splendidi templi, come quello ai piedi del Celio, quello sull’Aventino, quello sull’Esquilino. Altri templi a lei dedicati sorgevano nell’Italia meridionale e in Sicilia. Tra i più famosi ricordiamo il tempio sul promontorium Minervae, in Campania, a sud di Sorrento (oggi Punta delle Campanelle), edificato, secondo la tradizione, dallo stesso Ulisse, e il Minervium a sud di Idrunto, in Calabria. In suo onore i Romani istituirono le festività chiamate Quinquatrus, perché si svolgevano cinque giorni dopo le Idi di marzo (dal 19 al 23), celebrate in particolare dai medici, dagli artigiani e dai maestri, di cui era la protettrice. Minerva veniva ancora festeggiata quale dea inventrice degli strumenti musicali il 13 giugno. Protagonisti della festa erano questa volta i flautisti ufficiali, quelli, cioè, che erano autorizzati a suonare durante i riti religiosi, la cui presenza era necessaria perché la cerimonia si svolgesse perfettamente secondo le prescrizioni rituali. Statua di Minerva in terracotta. I culti stranieri e la crisi della religione romana I culti stranieri cominciarono a penetrare a Roma verso la fine della seconda guerra Punica (218-201 a.C.). L’occasione si presentò nel 205 a.C., quando giunse a Roma una lettera del console Publio Licinio con la notizia che egli stesso e il suo esercito, stanziato in Calabria, erano stati colpiti da una grave pestilenza. La notizia suscitò paura e sgomento, perché, se il terribile morbo non si fosse diffuso anche nell’esercito di Annibale, Roma avrebbe corso un pericolo gravissimo. Consultati i libri Sibillini, i Decemviri (sacerdoti addetti alla lettura e all’interpretazioni dei Libri Sibillini) trovarono un vaticinio secondo il quale il nemico venuto da fuori sarebbe stato cacciato dall’Italia se da Pessinunte (città della Frigia) si fosse portata a Roma la Gran Madre Idea1, la dea venerata nell’Anatolia e nella Frigia come colei che ha dato vita a tutto l’universo senza bisogno dell’intervento maschile, vergine inviolata e allo stesso tempo madre di tutti gli dei, personificazione della potenza generatrice della Natura. Per accoglierla i Romani le prepararono un tempio sul Palatino, a cui seguirono quello sull’Aventino e quello sul Colle Vaticano. Il suo culto venne ufficializzato dal senato il 4 aprile del 204 a.C., quando venne trasferita da Pessinunte a Roma la cosiddetta “pietra nera”, simbolo della dea. Raffigurata generalmente seduta sul trono con at- 1. L’Ida è un monte della Frigia, dedicato, appunto, al culto della Dea Madre (Cibele). D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani torno due leoni e una corona turrita sul capo, la dea conquistò subito il cuore dei Romani, tanto che essi le dedicarono dei giochi, i Megalensia (o Megalesia), detti così da Megalesion, il tempio della dea sotto le mura di Pergamo. In realtà, il culto di Cibele voluto dal senato romano venne accolto a Roma (almeno in un primo momento) ripulito di quegli aspetti passionali e orgiastici tipici dei culti orientali, per evitare i pericoli che, secondo i tradizionalisti, potevano derivare alla sana tradizione del mos maiorum. Bassorilievo che raffigura un sacerdote di Cibele. La crisi della religione romana si cominciò ad avvertire, unitamente a quella delle istituzioni repubblicane, sul finire del II secolo a.C. Le lotte fratricide fin dal tempo dei Gracchi, le lotte degli italici per i diritti civili, gli omicidi politici e le guerre civili avevano creato un clima di sfiducia nelle istituzioni civili e religiose e allontanato gli intellettuali dalla vita politica. Nuove correnti di pensiero (stoicismo, epicureismo), inoltre, e nuovi culti provenienti dall’Oriente sembravano dare alle coscienze individuali quelle risposte intorno all’anima e alla natura degli dei che la religione tradizionale non aveva saputo dare. Invano Augusto cercò di far rinascere l’antico culto, restaurando templi in rovina e innalzandone di nuovi. In epoca imperiale i nuovi culti che da qualche tempo erano entrati a far parte del ricco patrimonio religioso romano assunsero sempre più importanza, specialmente quello persiano di Mithra, largamente diffuso tra i militari. I nuovi culti erano detti misterici, perché i contenuti dottrinali, le pratiche religiose e la loro vera natura erano rivelate esclusivamente agli iniziati. Questa condizione di crisi delle antiche istituzioni religiose, aggravata dalla divinizzazione di Cesare e di Augusto e dal culto dell’imperatore, riconosciuto come una divinità, avviarono un inarrestabile processo di decadimento che si concluse nel IV secolo con la fine del paganesimo, la chiusura dei templi e la lenta affermazione, nonostante le persecuzioni, del cristianesimo. Bassorilievo raffigurante Mithra che uccide il toro, uno degli atti simbolici del culto di questo dio. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 7 8 la religione dei romani LEGGIAMO I TESTI 1 L’oracolo dei Libri Sibillini relativo alla dea Cibele CHE COSA RIPASSARE a. ablativo assoluto b. proposizioni infinitive c. infinito storico Civitatem eo tempŏre repens religio invasĕrat, invento carmĭne (profezia) in libris Sibyllinis, propter crebrius eo anno de caelo lapidatum (caduta di pietre) inspectis, quandoque (qualora) hostis alienigĕna terrae Italiae bellum intulisset, eum pelli Italia vincique posse, si mater Idaea a Pessinunte Romam advecta foret. Id carmen, a decemviris inventum, eo magis patres movit quod et legati qui donum (offerta votiva) Delphos portavĕrant referebant et sacrificantibus ipsis Pythio Apollĭni omnia laeta fuisse1 et responsum, oraculo edĭtum, maiorem multo victoriam quam cuius ex spoliis dona portarent adesse populo Romano2. […] Itaque quo maturius fatis, ominibus oraculisque portendentis, sese victoriae compŏtes fiĕrent, id cogitare atque agitare quae ratio transportandae Romam deae esset. Livio, Ab Urbe condita 29, 10 1. omnia laeta fuisse: “tutto era stato favorevole”; è detto in riferimento all’esame delle viscere degli animali sacrificati. 2. maiorem… Romano: ordina adesse populo Romano victoriam multo maiorem quam (illam) ex spoliis cuius (= dal cui bottino) portarent dona. 2 L’arrivo di Cibele, la Gran Madre Idea, a Roma CHE COSA RIPASSARE a. ablativo assoluto b. proposizioni temporali c. proposizioni completive Il senato decide di ricorrere al re di Pergamo, Attalo, per trasferire a Roma la pietra nera (probabilmente un meteorite) in cui i fedeli vedevano simboleggiata la Gran Madre. Così nel 204 a.C. nel porto di Ostia il simbolo di Cibele viene accolto con grande solennità e da lì in processione trasportato dalle matrone nel tempio della Vittoria sul Palatino. P. Cornelius cum omnibus matronis Ostiam obviam ire deae iussus (est); isque eam de nave accipĕret1 et in terram elatam tradĕret ferendam matronis. Postquam navis ad ostium amnis Tiberini accessit, sicut erat iussus, in salum nave evectus (portare), a sacerdotibus deam accēpit extulitque in terram. Matronae primores civitatis (eam) accepēre; […]. Eae per manus, succedentes deinde aliae aliis, omni obviam effusa civitate, turibulis ante ianuas positis qua praeferebatur atque accenso ture, precantibus2 ut volens (benevola) propitiaque urbem Romanam iniret, in aedem Victoriae, quae est in Palatio, pertulēre deam pridie idus Apriles; isque dies festus fuit. Populus frequens dona deae in Palatium tulit, lectisterniumque et ludi fuēre, Megalesia appellata. Livio, Ab Urbe condita 29, 14 1. Si noti la variatio: iussus est… ire; (iussus est) acciperet… traderet. 2. precantibus: ablativo assoluto con soggetto sottinteso civibus, che regge la subordinata ut... iniret. 3 Il senato si oppone ai culti stranieri CHE COSA RIPASSARE a. proposizioni consecutive b. cum narrativo c. proposizioni completive Mentre Annibale trascorre l’estate nel territorio salentino (210 a.C.), nella speranza di impadronirsi di Taranto, a Roma il popolo, stanco per le vicende avverse di una guerra che andava per le lunghe, si sente deluso e abbandonato dagli dei patrii. Nelle case private, nel Foro e sul Campidoglio non si celebrano più cerimonie secondo il costume tradizionale e una nuova superstizione (religio), venuta da fuori, sembra aver sconvolto gli animi. Tanta religio, et ea magna ex parte externa, civitatem incessit, ut aut homines aut dii repente alii viderentur facti (esse). Nec iam in secreto modo atque intra pariĕtes abolebantur Romani ritus, sed in publico D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani etiam, ac (erat in) Foro Capitolioque muliĕrum turba nec sacrificantium nec precantium deos patrio more. Sacrificŭli ac vates cepĕrant hominum mentes; quorum numerum auxit rustica plebs, ex incultis diutĭno bello infestisque (malsicuro) agris, egestate et metu in urbem compulsa; et quaestus1 ex alieno errore facilis, quem velut concessae artis usu (= come un’attività consentita) exercebant2. Primo secretae bonorum3 indignationes exaudiebantur; deinde ad patres etiam ac publicam quaerimoniam excessit res. Incusati gravĭter ab senatu aediles triumvirique capitales4 quod (haec) non prohibērent, cum emovēre eam multutudinem e Foro ac disicĕre (distruggere) adparatus sacrorum conati essent, haud procul afuit quin violarentur. Ubi potentius iam esse id malum apparuit quam ut minores per magistratus sedaretur, M. Aemilio praetori urbano negotium a senatu datum est ut eis religionibus populum liberaret. Livio, Ab Urbe condita 25, 1 1. questus (guadagno): intendi et auxit numerum (hominum) quaestus facilis. 2. exercebant: il soggetto è sempre sacrificŭli ac vates. 3. bonorum: boni sono qui le persone oneste. 4. triumvirique capitales: i triumviri capitales erano incaricati di far eseguire le sentenze di condanna a morte. Le istituzioni religiose Secondo la tradizione, tutto il complesso sistema cultuale romano sarebbe stato organizzato dal re Numa Pompilio, che avrebbe stabilito riti e cerimonie annuali e ne avrebbe affidato la gestione ai vari collegi sacerdotali. Tuttavia l’antichità di alcuni riti e il fondo linguistico assai arcaico di alcuni inni liturgici fanno ritenere che alcune cerimonie e istituzioni religiose risalgano a un’epoca anteriore a quella dei re. In tutto il periodo della repubblica, comunque, e in gran parte dell’impero i collegi sacerdotali più importanti, che organizzavano e gestivano riti religiosi, furono quello dei flamini, dei pontefici, delle vestali e degli auguri, mentre un discorso a sé meritano gli aruspici. Accanto ai collegi operavano anche alcuni sodalizi costituiti da persone associate da funzioni comuni sotto la protezione di una divinità tutelare, a cui prestavano servizio e di cui celebravano le festività. I sodalizi più antichi furono quelli dei salii e degli arvali. Il collegio dei flamini I flamini (flamines1) erano sacerdoti preposti ciascuno al culto di singole divinità indigene, appartenenti alla più antica tradizione religiosa romana, dal cui nome aggettivale erano contraddistinti. Il loro collegio era costituito da quindici sacerdoti suddivisi in due gruppi: flamini maggiori e minori. I flamini maggiori erano scelti in origine tra le famiglie patrizie e abilitati alla carica solo dopo che avessero preso auspici dai quali risultasse che erano persone gradite alla divinità cui avrebbero prestato servizio. Erano tre: il flamen Dialis, il flamen Martialis, il flamen Quirinalis, addetti rispettivamente al culto di Giove, di Marte, di Quirino (nome dato a Romolo dopo la sua apoteosi), le divinità che costituivano la Triade capitolina originaria (poi sostituita dalla Triade Giove, Giunone, Minerva). Durante le cerimonie indossavano, come insegne della loro dignità, la toga coperta da una sopravveste di porpora (laena) e un copricapo bianco di pelle ovina (pileus o albogalerus o albus galerus) tenuto con una cordi1. L’etimologia di flamen è molto discussa. Alcuni, come Varrone (L.L. V, 15), collegano flamen a filum o filamen, il filo di lana che il flamine portava attorno al berretto sacerdotale; altri al verbo flare, “soffiare” (per alimentare la fiamma sacrificale). Nel secolo scorso alcuni studiosi di linguistica hanno avanzato l’ipotesi di una derivazione da un termine indoeuropeo,*bhlagh-men, scorgendo una parentela etimologica tra fla-men e brah-man (sacerdote indiano). D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 9 10 la religione dei romani cella che passava sotto il mento; alla sommità del berretto vi era una base circolare con al centro una verghetta di olivo rivestita di lana (apex). I flamini minori, dodici in tutto, erano addetti a specifiche divinità indigene (la tradizione ne ricorda solo dieci: Carmenta, Cerere, Falacer, Furina, Flora, Pale, Pomona, Portuno, Volturno e Vulcano) che già nel I secolo a.C. risultavano oscure anche allo stesso Varrone. Il loro flaminato non era incompatibile con l’esercizio di magistrature civili e militari. In epoca imperiale furono istituiti dei flamini preposti al culto degli imperatori defunti e divinizzati, che da essi traevano il nome. I flamini, sottoposti alla giurisdizione del pontefice massimo (infatti erano eletti dal collegio dei pontefici) erano gli esecutori dei sacrifici; godevano – particolarmente il flamen Dialis – di una grandissima influenza e prestigio, ma erano anche obbligati all’osservanza di norme sacre di comportamento assai dure, nel rispetto di tradizioni che forse, con il passare del tempo, divennero incomprensibili e insignificanti per la maggior parte dei Romani. Nella processione dei sacerdoti sull’Ara Pacis si riconoscono i flamini per il copricapo. Il flamen Dialis Il flamen Dialis è senza dubbio la figura di sacerdote più interessante e caratteristica della religione romana: era il primo dei tre flamini maggiori, il sacerdote per eccellenza, la personificazione vivente di Giove e godeva di grande prestigio presso il popolo. La sua figura, come quella del rex sacrorum (il sacerdote cui erano affidate le funzioni in passato compiute dal re), era ai vertici della primitiva società romana. Tito Livio ne attribuisce l’istituzione al re Numa Pompilio, il quale, prevedendo che in tempo di guerra i suoi successori si sarebbero allontanati dalla città, “per evitare che i servizi religiosi di pertinenza regale subissero interruzioni, creò, per Giove, un flamine che rimanesse perennemente al suo posto e gli conferì il privilegio di un abbigliamento speciale e della sedia curule del re”. Ma la complessità di questa figura, la simbologia rituale di certi atti, le interdizioni, le astinenze a cui era sottoposta fanno pensare a un’epoca molto più antica, anteriore alla fondazione stessa di Roma e contemporanea ai primi insediamenti dei Latini sul suolo laziale; altri studiosi, invece, scorgendo una probabile affinità non solo etimologica tra fla-men e brah-man (vedi nota 1, p. 9), ma anche funzionale tra flamini e bramini, la casta sacerdotale indiana, ritengono che il flaminato fosse già presente nella cultura indoeuropea e che questa figura rivestisse insieme poteri regali e sacerdotali. L’arcaicità di questo sacerdozio, per altro, non sfuggì a Ovidio, che lo definì “pelasgico”, come a dire “preistorico”. La fonte da cui ricaviamo maggiori informazioni sul flamen Dialis è Aulo Gellio, che attinge alle Antiquitates rerum divinarum di Varrone e al primo libro delle storie dell’annalista Quinto Fabio Pittore. GelD. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani lio espone un elenco dettagliato dei privilegi e particolarmente delle limitazioni a cui erano sottoposti non solo il flamen Dialis, ma anche la moglie, la flaminica. Il flamen Dialis doveva essere sposato con una vergine; il matrimonio, celebrato con il rito della confarreatio, era santo e indissolubile, perché simboleggiava l’unione tra Giove e Giunone. Solo la morte era l’unica possibilità di rottura. In tal caso il flamen Dialis perdeva la sua sacralità e decadeva dalla carica, anche perché le funzioni da lui celebrate prevedevano l’assistenza della moglie. Il flamen Dialis godeva di molti privilegi. Partecipava alle sedute del senato con diritto alla sedia curule, alla toga pretesta e a un suo proprio littore. Aveva un’abitazione ufficiale (la flaminia domus) senza cani da guardia, così da poter garantire a chiunque accesso sicuro per eventuali suppliche. Presiedeva ai matrimoni per confarreatio, alle Vinali rustiche (festività che si celebrava il 19 agosto con libagioni di vino e offerte in onore di Giove) e ai Lupercali. Nei conviti occupava il primo Testa di flamine con posto dopo il rex sacrorum. Aveva il potere di far sospendere le pene, l’albogalerus. perciò, se un condannato alla fustigazione lo avesse incontrato per strada, per quel giorno non poteva essere fustigato. Teneva il capo sempre coperto con un berretto bianco (pileus o albogalerus), fatto con pelle di agnello sacrificato, alla sommità del quale vi era una verghetta di ulivo (apex o apiculum) rivestita di lana, che, secondo alcuni, serviva per sentire meglio la voce di Giove. Consacrato costantemente al culto della divinità, il flamen Dialis era totalmente estraneo al lavoro: tutti i giorni per lui erano festivi. Al suo passaggio ogni attività veniva sospesa e si osservava il silenzio, per non turbare il suo colloquio con Giove. Se questi erano gli onori e i privilegi, numerose e imbarazzanti e, in certo senso, strane erano le prescrizioni e le astinenze imposte al flamen Dialis. Si tratta in sostanza di norme di comportamento ispirate a un ideale di libertà e di purezza che doveva caratterizzare la sua vita. Egli, quale incarnazione della divinità, doveva essere libero da qualunque vincolo morale e materiale e vincolato solo al dio al cui servizio era consacrata la sua vita. Tutto quello che poteva evocare vincolo o contraddire alla libertà della sua persona andava rimosso. Da qui derivavano le norme secondo cui non poteva prestare giuramento o ricoprire magistrature, non poteva portare anelli (a meno che non avessero una fenditura), non doveva avere alcun nodo nel berretto sacerdotale né nella cintura né in altra parte degli abiti; non poteva essere toccato da uno schiavo; se un uomo in catene o comunque legato fosse entrato nella sua casa, doveva essere immediatamente liberato dalle catene e queste, portate sul tetto attraverso l’impluvio, dovevano essere lasciate cadere fuori sulla strada. Non poteva passare sotto un pergolato, perché la vite ricorda il vino e il flamine non poteva essere dominato dal piacere e dall’ubriachezza. Non poteva nominare o vedere l’edera, pianta debole e senza frutti che con le sue molteplici strette nodose lega e avvinghia a sé le altre piante. I suoi capelli potevano essere tagliati solo da un uomo libero con un rasoio o forbici di bronzo (il bronzo era il metallo sacro che si usava nei sacrifici). Allo stesso modo il flamen Dialis, quale essere puro e sacro per eccellenza, doveva fuggire il contatto con tutto ciò che contamina o evoca la morte. Non poteva pertanto toccare un morto o entrare dove qualcuno era stato cremato, non poteva nominare o toccare la capra, il cane, la carne cruda e la fava: infatti la capra e il cane a Roma erano considerati animali impuri e venivano sacrificati per i defunti e gli dei infernali; la carne cruda era considerata impura, perché non purificata dal fuoco; la fava, per il suo fiore dal colore nero e bianco, richiamava il lutto e quindi i defunti. Al flamen Dialis era interdetto andare a D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 11 12 la religione dei romani cavallo (considerato anch’esso animale impuro, che evocava la violenza della guerra) o vedere l’esercito in assetto di guerra né egli poteva toccare o mangiare il pane fermentato con lievito, probabilmente perché in esso si scorgeva qualche carattere di impurità. Altre norme erano ispirate al mantenimento del vincolo stretto e ininterrotto con la divinità. Al flamen Dialis non era permesso portare del fuoco fuori dalla casa flaminia, perché esso era sacro e doveva servire solo per scopi sacri. Egli non poteva lasciare la città per più di un giorno. Il suo letto doveva essere sistemato nel vestibolo della casa, per essere facilmente accessibile ai Romani, e i piedi del letto dovevano essere spalmati con un sottile strato di argilla, perché lo tenessero in stretto contatto con la terra. Non poteva inoltre dormire lontano da quel letto per tre notti consecutive né era lecito che un altro dormisse in quel letto. Ai piedi del letto doveva esserci un cofano con piccole focacce per i sacrifici, in modo da poter fare in qualunque momento un’offerta alla divinità. Il flamen Dialis non poteva mai togliersi la tunica e restare nudo in nessun luogo aperto, perché egli, quale incarnazione Giove, non poteva apparire come uomo tra gli uomini. La moglie del flamen Dialis, la flaminica, condivideva le medesime prescrizioni e divieti. La sua veste doveva essere interamente di lana e i suoi calzari confezionati con pelle di animali sacrificati. Durante i riti espiaStatua di Giove: tori non si lavava né si acconciava e doveva mostrare un aspetto severo. il flamen Dialis era considerato Al di fuori di queste cerimonie, portava i capelli a tutolo, cioè a forma di l’incarnazione di Giove. cono, tenuti fermi da un nastro rosso. Non poteva salire le scale oltre tre gradini, a meno che non fossero protette ai lati da tavole, come le scalae Graecae, perché non le si vedessero le gambe. Con il tempo tutte queste interdizioni e astinenze divennero meno comprensibili e quindi meno rigide e, nonostante i privilegi e gli onori – più formali che sostanziali – connessi alla carica, il flaminato Diale rimase senza titolare per 76 anni, dall’87 a.C. all’11 a.C., anno in cui Augusto lo restaurò, con significative modifiche delle fin troppo dure e arcaiche prescrizioni. LEGGIAMO I TESTI 4 Istituzioni religiose di Numa Pompilio CHE COSA RIPASSARE a. gerundivo b. proposizioni causali c. propozioni interrogative indirette Tum sacerdotibus creandis animum adiēcit, quamquam ipse plurĭma sacra obībat, ea maxime, quae nunc ad Dialem flaminem pertinent. Sed quia in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore iturosque ipsos ad bella ne sacra regiae vicis desererentur, flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit, insignique eum veste et curūli regia sella adornavit. Huic duos flamines adiecit, Marti unum, altĕrum Quirino, virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacedotium et genti conditoris haud alienum. His, ut adsiduae templi antistĭtes essent, stipendium de publico statuit, virginitate aliisque caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodĕcim Marti Gradīvo legit, tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen, caelestiaque arma, quae ancilia appellantur, ferre, ac per urbem ire canentes carmina D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani cun tripudiis sollemnique saltatu iussit. Ponifĭcem deinde Numam Marcium, Marci filium, ex patribus legit, eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit: quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fiĕrent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Livio, Ab Urbe condita 1, 20 5 Il flamen Dialis (I) CHE COSA RIPASSARE a. proposizioni relative b. periodo ipotetico c. reggenza di utor Caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices, quos in libris, qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, item in Fabii Pictoris librorum primo scriptos legimus. Unde haec ferme sunt, quae commeminĭmus: equo Dialem flaminem vehi religio est; item religio est classem procinctam extra pomerium, id est exercitum armatum, vidēre; idcirco rarenter flamen Dialis creatus consul est, cum bella consulibus mandabantur; item iurare Dialem fas numquam est; item anulo uti nisi pervio cassoque fas non est. Ignem e “flaminia”, id est flaminis Dialis domo, nisi sacrum efferri ius non est. Victum, si aedes eius introiĕrit, solvi necessum est et vincula per impluvium in tegulas subdūci atque inde foras in viam demitti. Nodum in apice neque in cinctu neque alia in parte ullum habet. Si quis ad verberandum ducatur, si ad pedes eius supplex procubuerit, eo die verberari piaculum est. Capillum Dialis, nisi qui liber homo est, non detondet. Capram et carnem incoctam et hederam et fabam neque tangĕre Diali mos est neque nominare. Propagines e vitibus altius praetentas non succedit. Pedes lecti in quo cubat luto tenui circumlitos esse oportet et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare alium fas est. Apud eius lecti fulcrum capsulam esse cum strue atque ferto oportet. Unguium Dialis et capilli segmina subter arborem felicem terra operiuntur. Dialis cotidie feriatus est. Sine apice sub divo esse licitum non est; sub tecto uti licēret, non pridem a pontificibus constitutum Masurius Sabinus scripsit et alia quaedam remissa, gratiaque aliquot caerimoniarum facta dicitur. Farinam fermento inbutam adtingere ei fas non est. Gellio, Noctes Atticae X, 15 6 Il flamen Dialis (II) CHE COSA RIPASSARE a. proposizioni finali b. usi di cum Tunica intima nisi in locis tectis non exuit se, ne sub caelo tamquam sub oculis Iovis nudus sit. Super flaminem Dialem in convivio, nisi rex sacrificulus, haut quisquam alius accumbit. Uxorem si amisit, flamonio decedit. Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est. Locum, in quo bustum est, numquam ingreditur, mortuum numquam attingit; funus tamen exsequi non est religio. Eaedem ferme caerimoniae sunt flaminicae Dialis; alias seorsum aiunt observitare, veluti est, quod venenato operītur, et quod in rica surculum de arbore felici habet, et quod scalas, nisi quae Graecae appellantur, escendere ei plus tribus gradibus religiosum est atque etiam, cum it ad Argeos, quod neque comit caput neque capillum depectit. Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi: “Sacerdotem vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam”. Verba M. Varronis ex secundo rerum divinarum super flamine Diali haec sunt: “Is solum album habet galerum, vel quod maximus, vel quod Iovi immolata hostia alba id fiĕri oporteat”. Gellio, Noctes Atticae X, 15 D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 13 14 la religione dei romani Il collegio dei pontefici Il termine pontefice deriva etimologicamente da pontem facĕre: in origine, infatti, i pontefici avevano avuto il compito di provvedere alla costruzione del ponte Sublicio, in modo che i sacri riti potessero essere celebrati su entrambe le sponde del Tevere. La tradizione attribuisce la loro istituzione al re Numa Pompilio, perché eseguissero riti e cerimonie annuali secondo le prescrizioni da lui stesso dettate. Essi, dunque, si occupavano essenzialmente dei culti che appartenevano, fin dai tempi più antichi, alla tradizione religiosa romana e presiedevano a tutta la vita religiosa pubblica, intervenendo anche in alcuni atti di culto privato, come il matrimonio per confarreatio. Ma il loro compito non si limitò soltanto alla sfera religiosa, alla sorveglianza, cioè, del culto nei suoi diversi aspetti, bensì si estese anche all’ambito civile e politico. Il pontificato era, infatti, una carica politica; i pontefici, più che veri e propri sacerdoti, erano dei giuristi e, in quanto tali, nel periodo arcaico avevano il compito di codificare e interpretare le leggi. Questo conferiva loro grande autorità e prestigio nel campo del diritto. I pontefici, eletti nella fase arcaica dal patriziato1, furono in numero di cinque fino ai tempi della dittatura di Silla (82-79 a.C.), poi crebbero fino a quindici. La loro divisa era la toga orlata di porpora ed essi avevano diritto alla sella curule. Presiedeva il collegio il pontefice massimo2, nominato a vita da diciassette tribù estratte a sorte. Questi aveva la sua residenza ufficiale nel Foro (regia), era il consigliere dei magistrati e del senato in tutto quello che riguardava il culto pubblico e aveva il diritto di avere una scorta di littori (dodici in tutto), al pari dei consoli. Sotto la sua autorità erano le vestali, i flamini e il rex sacrorum (il sacerdote a cui Augusto ritratto erano affidate le funzioni religiose compiute un tempo dal re). come pontefice massimo con Spettava al pontefice massimo redigere gli Annales e i Fasti. Negli Annales regiil capo coperto strava anno per anno, sotto i nomi dei consoli e dei magistrati, tutti gli avvenimenti dalla toga. di maggior rilievo di politica sia interna sia estera, con le relative le date: entrata in carica dei magistrati, guerre, pestilenze, calamità naturali, prodigi, nascite mostruose. Tutto questo materiale storiografico, trascritto poi su una tavola imbiancata (tabula dealbata) veniva esposto nella sua casa, la regia, perché il popolo ne prendesse visione. Nel 130 a.C., il pontefice massimo Publio Mucio Scevola fece trascrivere e pubblicare in ottanta rotoli di papiro tutta questa preziosa documentazione, che prese il nome di Annales pontifĭcum o Annales maximi. Agli Annales, che rappresentano la più antica espressione letteraria di documentazione storica nell’ambito della cultura latina, attingeranno in seguito gli storici. I Fasti erano inizialmente una sorta di calendario in cui i giorni erano divisi in fasti e nefasti: fasti erano i giorni in cui era consentito svolgere le attività pubbliche e private, nefasti quelli in cui queste attività, per motivi religiosi, non potevano aver luogo. In seguito i Fasti vennero integrati, nei singoli mesi, con le indicazioni dei giorni dedicati alla celebrazione delle varie feste in onore delle divinità e dell’organizzazione dei ludi (giochi di vario genere) e presero il nome di “calendario”. 1. Con la lex Ogulnia del 300 a.C. fu aperto anche ai plebei l’accesso al pontificato. 2. Anche Giulio Cesare rivestì la carica di pontefice massimo e da Augusto fino Graziano (382 d.C.) questa prestigiosa carica fu appannaggio degli imperatori. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani Il collegio delle vestali Le vestali erano sacerdotesse addette a mantenere vivo il fuoco sacro che ardeva nel tempio di Vesta, vicino alla regia (sede del pontefice massimo), e simboleggiava la vita dello stato. Livio (1, 20) dice che era un sacerdozio “oriundo di Alba e non estraneo alla stirpe del fondatore”, alludendo al fatto che Romolo e Remo erano nati da una vestale. Le vestali erano scelte, dopo la cacciata dei re, dal pontefice massimo ancora fanciulle fra i 6 e i 10 anni, in origine tra le famiglie patrizie, in seguito anche tra quelle plebee. Erano in tutto sei e dovevano essere senza difetti fisici, nate da matrimonio celebrato per confarreatio e con genitori ancora in vita. Il loro compito, come si è detto, era la custodia del fuoco sacro che ardeva nel tempio di Vesta. Il loro servizio durava trent’anni (dieci anni come novizie, dieci come ministre del culto, dieci come maestre), durante i quali, sottoposte alla Virgo Maxima, erano tenute a mantenere la castità e, come si è detto, dovevano tenere sempre acceso il fuoco sacro. In caso di infedeltà al voto di castità o se avessero lasciato spegnere il fuoco sacro, erano condannate a essere murate vive in una camera sotterranea nel campo detto “scellerato”, nei pressi di porta Collina. Trascorsi i trent’anni, le vestali tornavano in libertà e potevano contrarre matrimonio, cosa che comunque avveniva raramente. Oltre alla custodia del fuoco sacro, le vestali avevano il compito di curare gli oggetti sacri riposti nel tempio e di attingere ogni giorno acqua dalla fonte delle Camene, poiché era loro vietato servirsi dell’acqua delle condutture artificiali, ma potevano usare solo Statua di vestale acqua sorgiva. Dovevano anche preparare la mola salsa, un miscuglio di fain marmo. rina di farro (grano con sale), che serviva per cospargere il capo degli animali da sacrificare. Erano circondate da grande rispetto e godevano di molteplici privilegi. Per distinguersi dalle altre donne, in pubblico procedevano con il capo coperto da un velo bianco, detto suffibŭlum, assicurato al petto mediante una fibbia. Prendevano parte a molte feste, sempre precedute da un littore, e occupavano i primi posti. Il console, incontrandole, era tenuto a fermarsi e a cedere loro il passo; se nel loro cammino si fossero imbattute in un condannato a morte, questi veniva graziato. Resti della casa delle vestali nel Foro Romano. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 15 16 la religione dei romani Il collegio degli auguri Il collegio degli auguri1 si componeva in origine di soli tre membri, scelti uno per tribù; passarono poi a nove e quindi a sedici al tempo di Cesare. Vi potevano partecipare solo i patrizi; dopo il 300 a.C., l’accesso fu consentito anche ai plebei. Gli auguri erano esperti dell’arte divinatoria, ereditata dagli Etruschi, che consentiva loro di interpretare, attraverso l’osservazione attenta di alcuni fenomeni, il volere degli dei nei confronti di ogni atto della vita pubblica. Si credeva, infatti, che gli dei – e particolarmente Giove – intervenissero nelle vicende umane manifestando la loro volontà attraverso segni particolari, quali il modo di volare e di cantare degli uccelli (signa ex avibus), il modo di beccare dei polli nel recinto sacro (auspicia ex tripudiis o pullaria) o l’apparizione di comete e di stelle cadenti, la caduta di fulmini (caelestia auspicia), le carestie, le nascite mostruose, i terremoti ecc. (signa ex diris). Nell’osservazione di questi fenomeni gli auguri impugnavano un bastone con un’estremità ricurva, il lituo (lituus), e traevano gli auspici. Il termine auspicium (da avis + specĕre, verbo arcaico che significa “guardare”, quindi “osservare gli uccelli a scopo divinatorio”) per i Romani indicava il diritto, riservato ai magistrati e in particolare ai consoli, di richiedere tale osservazione (auspicia habere) prima di intraprendere atti importanti per la vita dello stato. L’augure, quindi, poteva svolgere la sua funzione di interprete dei segni dati dagli uccelli, quale “tecnico divinatorio”, solo in seguito all’ordine del magistrato a cui interessava conoscere se gli dei approvavano o no le sue iniziative. Anche i privati, comunque, in determinate e importanti situazioni, potevano richiedere gli auspici. I luoghi di osservazione, detti auguracŭla, erano tre: uno sul Campidoglio, l’altro sul Quirinale, il terzo sul Palatino. Tra le varie cerimonie officiate dagli auguri, particolarmente importante era quella dell’augurium salutis, in cui si pregava per la salvezza del popolo romano. Gli aruspici Gli aruspici a Roma erano considerati stranieri (provenivano generalmente dall’Etruria) e non costituivano un vero collegio sacerdotale. Tuttavia essi ancora nel 408 d.C. erano in attività, poiché si tramanda che in quell’anno, durante l’assedio di Roma, essi pronunciarono in lingua etrusca maledizioni contro i Visigoti di Alarico. Gli aruspici erano maestri nell’arte divinatoria (l’aruspicina) che consisteva nello scrutare le viscere e, in particolare, il fegato degli animali sacrificati. Quest’ultimo veniva diviso in sedici settori, ognuno dei quali era dedicato a una divinità: in base alla conformazione delle varie parti, gli aruspici interpretavano la volontà degli dei. Allo stesso modo anche il cielo era diviso in sedici settori: i settori a nord-est erano governati dalle divinità più favorevoli, quelli a Il celebre fegato di montone in bronzo utilizzato dagli Etruschi per la divinazione e la predizione del futuro. 1. Incerta è l’etimologia di augur, -ris. Secondo alcuni autori, augur sarebbe da collegare con augēre (aumentare): l’augur, dunque, sarebbe “colui che proferisce presagi assicurando l’accrescimento di un’impresa”, grazie all’assenso degli dei. Altri studiosi ritengono poco attendibile il collegamento di augur con augēre, già proposto da autori antichi, e, mentre concordano sull’interpretazione del primo elemento (au- da avis), propongono per il secondo (-gur) varie radici indoeuropee. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani nord-ovest dalle divinità più infauste, i demoni dell’oltretomba. A seconda dell’apparizione di fulmini, meteore, uccelli in volo ecc. nei settori del cielo, l’aruspice traeva il presagio. Durante le funzioni gli aruspici indossavano un mantello frangiato e un copricapo a forma di cono; in mano tenevano il lituus, come gli auguri, con il quale segnavano le diverse parti dello spazio celeste. Il sodalizio dei salii I salii1 formavano due confraternite di carattere guerresco, ciascuna composta da dodici membri, quella dei Palatini con un loro tempio sul Palatino, e quella dei Collini (o Agonenses), con sede sul Quirinale. I primi, i più antichi, erano sacerdoti addetti al culto di Marte Gradivo (da gradior “avanzo, procedo”, cioè “colui che muove alla battaglia”), i secondi (la cui creazione si faceva risalire al re Tullo Ostilio) erano dediti al culto di Quirino. Erano eletti a vita, ma potevano lasciare la carica nel caso fossero stati eletti flamini o preferissero ricoprire una magistratura politica, come consoli o pretori. La tradizione attribuisce l’istituzione dei salii Palatini al re Numa Pompilio, il quale avrebbe dato loro come distintivo una tunica ricamata e come compito quello di custodire, in un edificio sacro sul Palatino, dodici scudi di bronzo, gli ancilia, uno dei quali sarebbe miracolosamente piovuto dal cielo2, quale presagio della futura grandezza e potenza di Roma. Per impedire il furto di questo scudo miracoloso, Numa avrebbe incaricato un artigiano, Mamurio Veturio, di costruirne altri undici del tutto identici, così da renderne impossibile la distinzione e il riconoscimento. L’abbigliamento dei salii ricordava quello die guerrieri: indossavano, infatti, una tunica bordata di rosso, tenuta chiusa da una fibbia sulla spalla (trabea), e portavano una cintura di bronzo a cui era agganciata una spada. Sopra la tunica portavano una pettorina di bronzo e un mantello; indossavano, inoltre, l’apex, il copricapo dei flamini (vedi supra). Celebravano una festa denominata salaria, che aveva luogo nei mesi di marzo e ottobre, in coincidenza con l’inizio e la fine delle campagne militari3. Durante questa festività i salii organizzavano una processione per le vie della città, nel corso della quale, cantando in coro e singolarmente l’inno ufficiale della confraternita, il carmem saliare, percuotevano gli scudi e si esibivano in una rumorosa danza guerresca, Mosaico che ritrae una cerimonia di purificazione celebrata dai salii. 1. Salii deriva da salio, che significa “saltare, ballare”. 2. Il fatto è riferito da Plutarco, ma Dionigi d’Alicarnasso racconta che quello scudo fu trovato, senza che alcuno l’avesse portato, nella regia, la sede del pontefice massimo, e che, essendo di forma strana (incavato da ambedue le parti, come quello dei Traci), fu creduto di provenienza divina. 3. Presso i popoli antichi non si combattevano guerre durante la stagione invernale, a causa della rigidità del clima. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 17 18 la religione dei romani detta tripudium, perché era eseguita con ritmo ternario e accompagnata dal triplice battito del piede per terra (tripudium da ter + pes, “tre volte il piede”). Il carme, in un linguaggio molto arcaico (e quindi in epoca storica quasi incompressibile), e il tipo di danza fanno pensare a un’istituzione della confraternita in un’epoca anteriore alla fondazione stessa di Roma, anche perché il tripudium, in tempi remoti, era conosciuto e praticato in città latine ed etrusche, come Alba, Laurento, Tusculo, Tivoli. Il sodalizio degli arvali Gli arvali (da arva, “campi coltivati”) costituivano un antichissimo sodalizio sacerdotale composto da dodici membri scelti a vita tra gli esponenti delle famiglie patrizie. Erano detti “fratelli”, perché, secondo la leggenda riportata da Plinio il Vecchio nella sua Historia naturalis1, sarebbe stato Romolo stesso a istituire questo sacerdozio. Egli, infatti, dopo la morte di uno dei dodici figli di Acca Larenzia e Faustolo (il pastore da cui era stato raccolto e allevato, insieme al fratello gemello Remo), ne avrebbe preso il posto e avrebbe chiamato sé e gli altri figli fratres arvales. Il collegio era presieduto dal magister, uno dei dodici, scelto dai fratelli stessi. Le insegne della loro dignità erano le corone di spighe e le infule (bende di lana bianca con le quali si cingevano il capo); assistenti nei sacrifici e nelle cerimonie erano quattro ragazzi nobili; la divinità del loro culto era Dia, più tardi identificata con Cerere, la dea protettrice delle messi e dei frutti della terra. Il loro rito più importante veniva celebrato presso un santuario situato fuori Roma, sulla sommità di un colle boscoso, al quinto miglio della via Campana, vicino alla Magliana. Nel 1778, durante gli scavi archeologici, fra le rovine del tempio fu riportata alla luce un’ iscrizione epigrafica contenente gli acta di una cerimonia celebrata nell 218 d.C. e il testo di un’antichissima preghiera, il carmen fratrum arvalium, che comprendeva un’invocazione ai Lari, divinità tutelari della famiglia, ai Semoni, divinità dei campi, Il tempio di Cerere a Paestum: gli arvali erano dediti al culto di Dia, poi identificata con Cerere. 1. Hist. Nat. XVIII, 6: “Romolo per primo istituì i sacerdoti Arvali e chiamò se stesso dodicesimo fratello tra quelli generati da Acca Larenzia, sua nutrice”. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani e a Marte inteso come divinità agreste. Questo documento, che, insieme al carmen saliare, rappresenta una delle prime espressioni letterarie della lingua latina, ha consentito di conoscere lo svolgimento del rito celebrato dai fratelli arvali. Si trattava di una solenne festa religiosa dedicata alla purificazione dei campi, che si celebrava nella seconda metà del mese di maggio. La festa, denominata ambarvalia (“processione intorno ai campi”), aveva la durata di tre giorni, durante i quali, tra canti, invocazioni, giochi, danze rituali, si svolgevano varie processioni intorno alle terre coltivate, al fine di allontanare le potenze malevole e propiziare il raccolto. Nel primo e nel terzo giorno la cerimonia aveva luogo presso la sede del magister, tra incensi, libagioni, offerta dei prodotti della terra e benedizione del pane e di spighe secche e fresche. Il culmine della solennità era al secondo giorno, quando la festa si spostava fuori Roma, presso il colle dove sorgeva il tempio di Dia. All’alba il magister, da solo, indossando la toga pretesta e portando sul capo una corona di spighe, immolava accanto a un altare, ai margini bosco, due porche e una giovenca bianca, le cui viscere venivano deposte su un’ara e le cui carni erano messe a bollire in ampie olle. Stendeva poi per iscritto un documento a conferma dell’avvenuto sacrificio. Deposte quindi le insegne, si ritirava nella sua tenda in attesa dell’arrivo dei fratelli. Questi, seguiti dal popolo, sopraggiungevano in processione intorno a mezzogiorno, vestiti con la toga pretesta e coronati di spighe; deponevano le insegne e prendevano posto in appositi tavoli, per gustare le carni delle vittime sacrificate. Al pomeriggio riprendeva la processione e, attraverso il bosco, si saliva al tempio di Dia, dove veniva celebrato un rito funebre, alla fine del quale dalla soglia del tempio si riversava il contenuto delle olle giù per il pendio boscoso, quale pasto alla madre dei Lari. Veniva quindi fatto allontanare il popolo che aveva partecipato alla celebrazione, mentre i fratelli arvali, e solo loro, rientravano nel tempio. Qui, a porte chiuse, al ritmo ternario di una danza rituale (tripudium), intonavano un antichissimo canto (il carmen fratrum arvalium), i cui versi venivano ripetuti per tre volte2. Data l’arcaicità del linguaggio, il significato delle parole, come scrive Quintiliano (I, 6, 40), con il tempo era divenuto incomprensibile anche agli stessi fratelli arvali; tuttavia si mantenne inalterato, in quanto i Romani ritenevano che ogni cambiamento ne avrebbe compromesso l’efficacia. Le festività Parlando delle divinità e dei sacerdoti romani, abbiamo citato diverse feste che venivano celebrate in momenti differenti dell’anno e in onore dei vari dei. Ora vogliamo esaminare tre feste particolarmente sentite presso i Romani: i saturnalia, i lupercalia e i lemuria. I saturnalia Tra le festività religiose dell’antica Roma, quella dei saturnali era una delle più importanti e solenni del calendario romano. Lo storico Tito Livio (Ab Urbe condita 2, 21, 2) collega l’istituzione dei saturnali con l’inaugurazione del tempio di Saturno alle falde del Campidoglio, avvenuta nel 497 a.C., sotto il consolato di Aulo Sempronio e Marco Minucio. In realtà, le origini dei saturnali risalgono a tempi più remoti. La leggenda ne attribuisce l’istituzione a quegli Argivi (Macrobio, Sat. 1, 7) che erano giunti nel Lazio con Ercole; e lo stesso tempio di cui parla Livio sarebbe stato costruito dove prima esisteva l’ara di Ercole dedicata a Saturno (Dionigi di Alicarnasso, Ant. Rom. VI, 1), divinità legata al mondo dell’agricoltura: il nome Saturno è infatti connesso a serĕre, seminare. I saturnalia sarebbero dunque una festa dalle lontane origini contadine, che coincidevano con la fine dell’anno solare e agricolo. 2. La triplice invocazione era considerata garanzia di efficacia. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 19 20 la religione dei romani Inizialmente la festa si celebrava in un solo giorno, il 17 dicembre; in seguito, con Cesare, fu portata a due, a quattro con Caligola e infine a sette con Domiziano, un arco di tempo che andava dal 17 al 23 dicembre, durante il quale cessavano tutte le attività lavorative, tribunali e scuole rimanevano chiusi, musici, danzatrici, attori e saltimbanchi improvvisavano agli angoli della strada i loro spettacoli, la gente si riversava nelle strade con buffi travestimenti e si lasciava andare a intemperanze e alla più sfrenata baldoria. Non tutti riuscivano a tollerare il caos e la confusione di quei giorni: quanti se lo potevano permettere si ritiravano nella loro tenuta di campagna, lontano dal frastuono della città (Plinio, Ep. II, 17, 24). La fine delle festività dei saturnali coincideva con quella del dies natalis Solis Invicti1, quando il vecchio Sole, terminato il suo ciclo annuale, entrato nel solstizio d’inverno, rinasceva e cominciava a riprendersi progressivamente il suo spazio sul buio, diffondendo sempre più luce e calore. Le festività iniziavano con una processione fino al tempio di Saturno; qui sull’ara si compiva un solenne sacrificio, durante il quale si scioglievano le bende di lana che avvolgevano i piedi del simulacro di Saturno, che rimanevano slegati fino alla fine del mese (probabilmente a simboleggiare il giacere del seme nella terra fino a quando non germoglia). Quindi davanti al tempio aveva luogo il lettisternio, il grande banchetto sacrificale: intorno a una tavola riccamente imbandita, preparata dagli epulones2, si mettevano a giacere sui cuscini le statuette degli dei in onore dei quali era offerto il banchetto, alla fine del quale venivano proclamati ufficialmente i saturnali. Durante quei giorni si poteva assistere a un vero e proprio sovvertimento dell’ordine costituito: ogni differenza sociale scompariva, gli schiavi con il pileo (copricapo tipico dei liberti) banchettavano con i loro padroni e da questi erano serviti, con piena libertà di parola e di critica3. Potevano quindi esprimersi liberamente, dare ordini ai loro stessi padroni, senza per questo incorrere in punizioni. Il poeta Orazio in una sua Satira (II, 7, 4-5) così incoraggia il suo schiavo Davo, che da tempo desiderava dirgli qualcosa, ma era trattenuto dalla paura: Age, libertate decembri, quando ita maiores voluerunt, utĕre: narra (“Coraggio, approfitta della libertà di dicembre, dato che così hanno voluto i nostri antenati: parla”). All’inizio dei saturnali veniva eletto a sorte il princeps Saturnalicius, uno schiavo con una maschera buffa e un vestito dai colori sgargianti (con prevalenza del rosso), a cui si accordavano poteri speciali: presiedeva i banchetti, organizzava e guidava le danze, che assumevano spesso carattere orgiastico, e alla fine della festività veniva simbolicamente messo a morte. I saturnali facevano in certo senso rivivere, anche se per pochi giorni, l’antica e mitica età dell’oro, sotto il regno di Saturno, quando tra gli uomini non vi erano disuguaglianze e tutti vivevano in pace, liberi da preoccupazioni e in armonia. A ricordo dell’antica uguaglianza, in quei giorni si scambiavano gli auguri e si mandavano reciprocamente dei regali, detti xenia. Si tenevano giochi nel circo ed era consentito il gioco d’azzardo, altrimenti severamente proibito. Le festività dei saturnali si protrassero per tutto il periodo dell’impero e oltre. Macrobio, uno scrittore vissuto tra il IV e il V secolo, compose, intorno al 440, i Saturnalia, in cui introduce una serie di conversazioni su temi impegnativi, ma anche leggeri e piacevoli, tenute da un gruppo di intellettuali in casa di un aristocratico, in occasione dei banchetti per le feste di Saturno nell’anno 384. Alcuni studiosi in passato hanno fatto risalire le origini del nostro carnevale alla festività dei saturnali, ma oggi questa tesi è stata abbandonata. 1. L’imperatore Aureliano nel 274 fissò la festività del dies natalis Solis Invicti il 25 dicembre, facendo del dio-sole la divinità principale del suo impero e ufficializzandone il culto. 2. Gli epulones erano membri di un collegio sacerdotale addetto alla cura dei pubblici e solenni banchetti nelle feste in onore degli dei. 3. Cicerone, pur di non servire la sua servitù, durante i saturnali preferiva ritirarsi nella sua tenuta alla periferia della città. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani LEGGIAMO I TESTI 7 Un invito alla moderazione nella festività dei saturnali CHE COSA RIPASSARE a. nominativo e videor b. proposizioni interrogative indirette c. periodo ipotetico December est mensis: cum maxime civitas sudat. Ius luxuriae publice datum est; ingenti apparatu sonant omnia, tamquam quicquam inter Saturnalia intersit et dies rerum agendarum; adeo nihil interest ut non videatur mihi errasse1 qui dixit olim mensem Decembrem fuisse, nunc annum. Si te hic haberem, libenter tecum conferrem quid existimares esse faciendum, utrum nihil ex cotidiana consuetudine movendum an, ne dissidēre videremur cum publiciis moribus, et hilarius cenandum et exuendam togam. Nam quod fiĕri nisi in tumultu et tristi tempŏre civitatis non solebat, (nunc) voluptatis causa ac festorum dierum vestem mutavĭmus. Si te bene novi, arbitri partibus functus nec per omnia nos similes esse pilleatae turbae voluisses nec per omnia dissimiles; nisi forte his maxime diebus animo imperandum est, ut tunc voluptatibus solus abstineat, cum in illas omnis turba procubuit; certissimum enim argumentum firmitatis suae capit2, si ad blanda et in luxuriam trahentia nec it nec abducitur. Hoc multo fortius est, ebrio ac vomitante populo siccum ac sobrium esse, illud temperantius, non excerpĕre se nec insignire nec miscēri omnibus et eadem sed non eodem modo facĕre; licet enim sine luxuria agĕre festum diem. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium II, 18, 1-4 1. Costruisci: nihil (autem) interest (esserci differenza), adeo ut mihi videatur non errasse qui…. 2. Capit: è sottinteso il soggetto animus noster. I lupercalia Una straordinaria scoperta archeologica è stata annunciata il 20 novembre 2007: secondo alcuni studiosi1, infatti, è stato ritrovato il lupercal, la grotta alle pendici del Palatino, dove, secondo la tradizione, Romolo e Remo erano stati allattati dalla lupa. Si tratta di un antro situato a 16 metri di profondità, alto circa 9 metri, lungo 7 metri e mezzo, che ha al centro della volta, ornata di marmi policromi, una grande aquila bianca su fondo azzurro, corrispondente alle descrizioni tramandate nei secoli. Quell’antro oscuro, a un passo dal Tevere, Augusto aveva abbellito solennemente, trasformandolo in luogo fondativo dell’impero. Presso quella grotta i Romani fin dai tempi antichi si riunivano, per ricordare il prodigioso miracolo dell’allattamento dei gemelli da parte di una lupa. La ricorrenza si celebrava il 15 febbraio, con grande partecipazione popolare, all’insegna della stravaganza e del ritorno a un mondo primitivo e selvaggio. I riti preliminari, secondo Plutarco (Romolo, 17), si svolgevano appunto presso il lupercal, nome da collegare con Lupercus (lupo e capro), divinità italica corrispondente al dio greco Pan Lukaios o al dio Fauno, protettore delle greggi. Qui, accanto alla grotta, venivano sgozzati un capro e un cane (vittime proprie degli dei Mani) e con il coltello ancora bagnato del loro sangue il sacerdote toccava la fronte di due ragazzi scelti fra le famiglie nobili; poi con un batuffolo di lana intriso di latte asciugava la fronte e quindi aspergeva e purificava il popolo. Durante questo breve rito i ragazzi e i luperci (sacerdoti di Luperco) esplodevano in sonore risate rituali. Si tratta di un rito di purificazione e di fertilità che fra i pastori primitivi era forse un rito rivolto ad allontanare i lupi. 1. La questione, però, è controversa e non tutti gli studiosi concordano sul fatto che la grotta ritrovata sia da identificarsi con il lupercal. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 21 22 la religione dei romani Si svolgeva quindi la processione. I luperci, nudi con una cintura ai fianchi, giravano correndo intorno al Palatino, flagellando con cinghie ricavate dalla pelle delle vittime appena sgozzate quanti incontravano nella loro corsa. Le donne si offrivano volentieri alle percosse dei luperci, poiché si credeva che esse favorissero la fertilità. Questa festività non godeva i favori di Cicerone, che nell’orazione Pro Caelio (26), ne parla con disprezzo, definendola “confraternita selvatica composta da pastori e contadini, formatasi nei boschi prima che esistessero civiltà e leggi”. La leggenda, infatti (come ci riferisce Dionigi d’Alicarnasso), vuole che questa festività sia stata introdotta da Evandro, che avrebbe recuperato un rito àrcade. In epoca storica si fa risalire a Romolo e Remo l’istituzione di due collegi sacerdotali, quello dei quintiliani e quello dei fabiani, che elaborarono un preciso apparato liturgico per celebrare i riti sacri. Un terzo collegio sacerdotale, detto giuliano, fu aggiunto in seguito in onore di Giulio Cesare. Capo di questo collegio, nel 44 a.C., fu – come ricorda Cicerone (Phil. 3, 12) – il console Antonio, che sotto gli occhi del popolo Romano andò nel Foro nudo, profumato ed ebbro e si diede ad arringare la folla; e quindi, accostandosi a Cesare, collega nel consolato, tentò di porgli sul capo un diadema regale, che Cesare respinse prontamente e fece deporre nel tempio di Giove Capitolino. Nell’ultimo periodo della repubblica pare che questa festa fosse alquanto decaduta, probabilmente per l’eccessiva licenza che i luperci si permettevano. La celebrazione comunque non rimase sospesa e Augusto (Svetonio, Aug. 31) nella sua riforma la richiamò a nuova vita, vietando però ai più giovani di prendervi parte. Inutili furono i tentativi dei vescovi contro la tenacia dei Romani (anche cristiani), i quali attribuivano le pestilenze e tutti i mali dell’impero al fatto che si fosse trascurata quella festa di purificazione. Intorno al 495 papa Gelasio indirizzò al senato un trattato confutatorio sotto forma di lettera contro i lupercalia, invitando il princeps senatus Andromaco ad abolire quella festività (che, evidentemente, all’epoca era ancora celebrata); e pare che vi riuscisse, se dopo quella data non si hanno più notizie dei lupercali. La volta del supposto lupercal, trovato sotto il Palatino nel 2007. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale la religione dei romani LEGGIAMO I TESTI 8 La festa del lupercale CHE COSA RIPASSARE a. proposizioni relative b. proposizioni completive c. cum narrativo Iam tum in Palatio monte Lupercal hoc fuisse ludĭcrum ferunt, et a Pallanteo, urbe Arcadica, Pallantium, dein Palatium, montem appellatum. Ibi Evandrum, qui ex eo genĕre Arcădum multis ante tempestatibus tenuĕrit loca, (hoc) sollemne (festa) allatum ex Arcadia instituisse, ut nudi iuvenes, Lycaeum Pana venerantes, per lusum atque lasciviam currĕrent, quem Romani deinde vocaverunt Inuum. Huic dedĭtis ludĭcro, cum sollemne notum esset, insidiatos ob iram praedae amissae1 latrones2, cum Romulus vi se defendisset, Remum caepisse, captum regi Amulio tradidisse. Livio, Ab Urbe condita 1, 5 1. I fratelli Romolo e Remo solevano organizzare delle spedizioni contro i ladroni per spogliarli del loro bottino e dividerlo poi fra i pastori. 2. Ordina: latrones, cum sollemne esset notum, ob iram praedae amissae insidiatos (esse) dedĭtis huic ludĭcro. I lemuria Tra le tante ricorrenze in cui gli antichi Romani ricordavano i defunti, particolarmente significativa appare quella dei lemuria. Lemŭres erano le ombre (o anime) dei morti, che, secondo un’antichissima tradizione, si distinguevano in buone e cattive: quelle buone erano i Manes o Lares, considerate divinità domestiche e onorate all’interno della famiglia; quelle cattive erano le Larvae, che, non soddisfatte delle attenzioni dei vivi nei loro confronti, uscivano in determinati giorni dell’anno dalle tombe e tornavano a vagare nelle ore notturne nelle case dove erano vissute, terrorizzando e tormentando i vivi e minacciando di trascinare nel regno dei morti un membro della famiglia, se non fossero state placate con offerte e sacrifici. Per propiziarsene i favori, i Romani avevano istituito apposite festività religiose, chiamate appunto lemuria o lemuralia, che si celebravano nel mese di maggio nei giorni 9, 11, 13. Durante quei giorni i templi rimanevano chiusi, non venivano celebrati matrimoni, si interrompevano tutte le attività che non fossero assolutamente indispensabili. Il poeta latino Ovidio (Fasti 5, 419-444) ci descrive il rito che serviva a tenere lontane le Larvae, rito che (a causa dei numerosi elementi di richiamo alla magia) dimostra la sua origine etrusca. Nel cuore della notte, quando il silenzio invita al sonno, il pater familias balzava dal letto e per tre volte in acqua corrente si purificava le mani; quindi a piedi nudi girava per la casa facendo schioccare il pollice con il medio, poiché temeva che, se fosse rimasto muto, la larva gli venisse incontro urtandolo. In bocca teneva fave nere1, quasi a rassicurare la larva che non erano avvelenate. Poi, depostele nelle mani, le lanciava una alla volta dietro di sé senza girarsi, pronunciando per nove volte la formula di rito: “Ecco, queste io ti getto e con esse riscatto me stesso e i miei”. Credeva infatti che la larva, seguendo non vista i suoi passi, le raccogliesse. Ritornava quindi a purificarsi ancora una volta le mani e a girare per la casa, facendo tintinnare un oggetto di bronzo per spaventare gli spiriti e pregando che si allontanassero dalla casa. Solo dopo aver ripetuto per nove volte: “Ombre dei miei padri, uscite!”, si volgeva indietro, sicuro di aver compiuto con purezza il rito e allontanato le larve dei morti. 1. Si credeva infatti che le fave appartenessero ai defunti, perché il loro fiore, unendo strisce nere con il bianco, portava i segni del lutto. D. CHILLEMI, M. CHIARELLO, Lingua communis © 2011 SEI – Società Editrice Internazionale 23